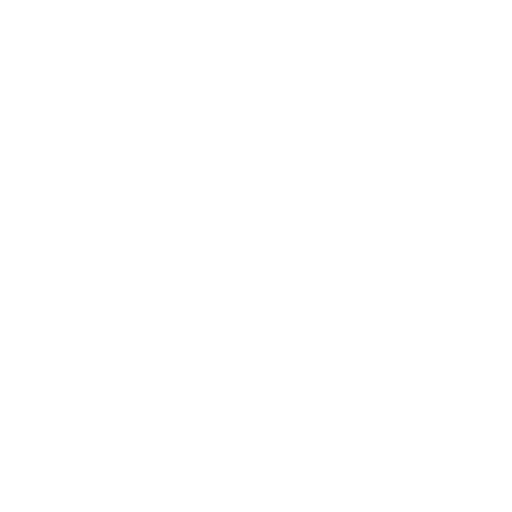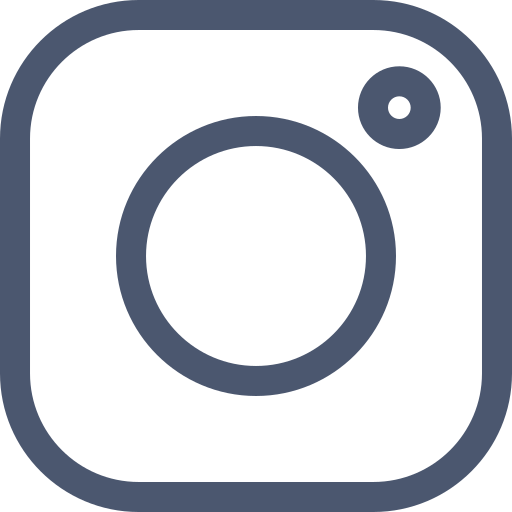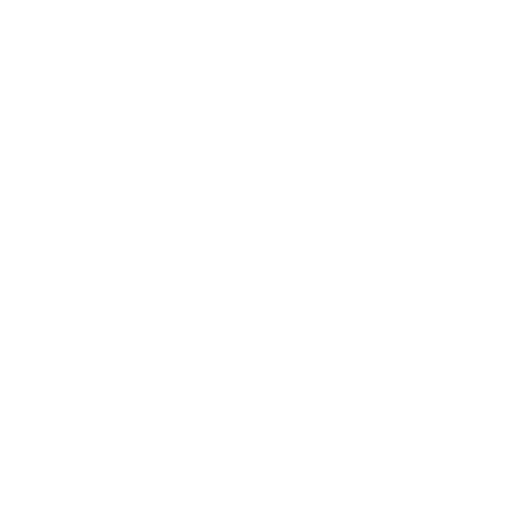Quante immagini offre di sé una città? Quante ne mostra Roma? Infinite, tante quanti sono gli occhi che la guardano, quanti sono i passi che la attraversano…Tra le tante vi proponiamo questa volta la visione di una prima volta, quella di un bambino degli anni quaranta dello scorso secolo. Si tratta di un racconto bellissimo e struggente, pieno di meraviglia e di stupore; una narrazione attenta a cogliere le irripetibili atmosfere di un’epoca storica irritornabile. Ecco dunque questo racconto dal titolo “Elegia romana”, pubblicato nel 2003 da L’argonauta, nel volume “Il giorno dell’ira e altri racconti” di Renato Gabriele.
ELEGIA ROMANA
Racconto: Renato Gabriele
Fotografie: Roberto Gabriele
“Stiamo arrivando, mi aveva detto lo zio, siamo sul binario”. Era stato lungo quel viaggio, avevamo ingoiato il fumo del treno nelle gallerie; sentivo in bocca un sapore di fuliggine. Nello scompartimento s’era formata una nebbia densa, tante le sigarette che gli uomini avevano fumato. Uno, seduto di fronte a me, ne aveva confezionate tante con quelle mani dure, callose. Gli riuscivano male, storte,mezze vuote. Le leccava per incollare i lembi della cartina e, così bagnate di saliva, le fumava con boccate piene strizzando gli occhi e lasciando che il fumo gli uscisse dagli angoli della bocca.
Durante il viaggio ero stato al finestrino a guardare gli alberi e le case sfilare veloci. C’erano autocarri abbandonati sulle strade, qualcuno rovesciato in un fosso. Erano carcasse spoliate di tutto, senza più motore, senza copertoni. Avevano perso ogni cosa, con il tempo avrebbero smontato e portato via anche il resto. Avevo visto un piccolo autoblindo e perfino un aereo che sembrava un giocattolo dimenticato su un prato. “ I segni del conflitto”, aveva detto lo zio, con quel suo parlare preciso. Mi dava brevi ma complete spiegazioni che non ammettevano domande né repliche.
Ad una fermata del treno avevo avuto paura di aver perso lo zio, avevo provato il panico di essere solo, abbandonato. Lo zio, che era sceso per bere alla fontanina della stazione, non era ancora tornato quando il treno si era rimesso in movimento, L’uomo che fumava mi aveva però rassicurato:” Non preoccuparti, vedrai che viene subito…tuo padre, sarà salito in un vagone dietro”. L’avevo visto esitare ma non avevo voluto dirgli che quegli era mio zio, che mio padre era morto. Adesso lo zio era lì, davanti a me, con gli occhi chiusi.
 Uno strattone, un rumore di ferraglia, un urto, un sussulto:”Ci siamo, vedrai com’è Roma”, fece lo zio con voce atona, senza enfasi, con la serietà di che propone di assolvere un dovere, un compito. Mi domandai subito se quella di Sassa, da dove ero partito quella mattina, fosse una stazione vera, se potesse chiamarsi una stazione, con le sue aiuole fiorite, lo zampillo, le panchine: tutto al sole, all’aperto, dove a certi intervalli regolari passava un trenino per bambini. Qui a Roma era tutto più scuro. C’erano molti treni allineati, ed erano neri, enormi. A Sassa passava soltanto la littorina, un trenino con un solo vagone, che si annunciava con un rombo come di un tuono che vada spegnendosi, nel silenzio assoluto della valletta.
Uno strattone, un rumore di ferraglia, un urto, un sussulto:”Ci siamo, vedrai com’è Roma”, fece lo zio con voce atona, senza enfasi, con la serietà di che propone di assolvere un dovere, un compito. Mi domandai subito se quella di Sassa, da dove ero partito quella mattina, fosse una stazione vera, se potesse chiamarsi una stazione, con le sue aiuole fiorite, lo zampillo, le panchine: tutto al sole, all’aperto, dove a certi intervalli regolari passava un trenino per bambini. Qui a Roma era tutto più scuro. C’erano molti treni allineati, ed erano neri, enormi. A Sassa passava soltanto la littorina, un trenino con un solo vagone, che si annunciava con un rombo come di un tuono che vada spegnendosi, nel silenzio assoluto della valletta.
C’incamminammo tra tutta quella gente vociante che pareva andare verso un’unica direzione comune. Tutti parevano presi da una smania che li accelerava. Trascinavano vecchie valigie di fibra, segnate e graffiate, stracariche, legate con lo spago e con grosse cinghie. Pensai che quella gente non desiderasse, dopo di là, andare in nessun altro luogo. Sembravano arrivati per restare ma continuavano a muoversi in quel posto su itinerari prestabiliti, a volte paralleli, a volte incrociati. Come le formiche. Non sapevo se io fossi arrivato per restare.
Quattro giorni prima giocavo ancora ai banditi con Nicolino. Ci appostavamo in mezzo al malvone, ai sambuchi, dietro le fratte del biancospino. Poi era arrivata tutta quella gente, che veniva su verso la nostra casa dallo stradone bianco. Erano scesi dalla corriera poco più sotto, a Madonna della Strada. Erano bianchi di pelle, molti di loro portavano gli occhiali. Mi pareva strano, mi ero chiesto per quale motivo tanta gente insieme portasse gli occhiali. Il giorno dopo era stato mio fratello a dirmi che nostro padre era morto, che quelli erano parenti venuti per la sua morte, per il suo funerale. Non conoscevo nessuno di loro, neppure lo zio che mi aveva portato a Roma con sé.
Ed eccomi qui, arrivato a Roma, tra quella folla frenetica, disordinata. Lo zio aveva portato con sé un incarto con un quadro di mio padre. In treno, un momento che eravamo soli, mi aveva parlato un poco di lui, della sua vita sfortunata. Avevo sentito per la prima volta che la vita di mio padre era stata sfortunata. Non sapevo che una vita potesse essere sfortunata. “Chi di voi sa disegnare, chi ha ripreso da lui?”aveva chiesto lo zio. Io avevo fatto spallucce lasciando cadere la domanda. Lo zio mi rassicurava, con la sua voce paziente. In quei giorni le voci di tutti quelli che erano venuti nella nostra casa avevano un comune accento, che non uniformava però la sostanza della voce. La voce della Bolognese era rimasta una musica per me, come sempre.
 Adesso camminavamo in silenzio, io portavo il mio pacco con la biancheria. Sul treno lo zio aveva detto:”Io porto i miei colli, tu porta il tuo pacco.” Non sapevo che cosa fosse un collo ma lo capii quando vidi che lui dava di piglio ai suoi involti. Presi il mio pacco fatto con la carta di giornali e tenuto con lo spago. Molti passeggeri avevano pacchi come il mio.
Adesso camminavamo in silenzio, io portavo il mio pacco con la biancheria. Sul treno lo zio aveva detto:”Io porto i miei colli, tu porta il tuo pacco.” Non sapevo che cosa fosse un collo ma lo capii quando vidi che lui dava di piglio ai suoi involti. Presi il mio pacco fatto con la carta di giornali e tenuto con lo spago. Molti passeggeri avevano pacchi come il mio.
Camminavamo affiancati, immersi nei nostri pensieri, tra uomini in maniche di camicia, con le maniche arrotolate, tra donne in abiti colorati. Qualcuno portava la giacca sul braccio o appoggiata alle spalle senza infilare le maniche.
Usciti da quella fiumana, aspettammo a lungo alla fermata del tram. Non ne avevo mai veduto uno prima di quella volta. Passava scorrendo pesantemente sui binari, con gente appesa dovunque fosse possibile, all’esterno. Dietro, però, su un rigonfiamento da cui partiva un grosso cavo, c’era solo un ragazzo perché l’appoggio era difficile. Riuscimmo anche noi a salire, impacciati nei nostri colli e restammo in piedi, pigiati da ogni lato.
 Scendemmo in un viale di periferia. Qui c’era gente più distesa, una folla ilare il cui vociare si dondolava a momenti sui rami delle acacie e restava talora come improvvisamente fermo nell’aria. Aspiravo profondamente l’odore delle gaggie, che mi riportava celermente al ricordo di Madonna della Strada. Qui però era costruito tutt’intorno, la strada era incassata tra gli alti fabbricati come un fiume tra alte rive scavate. Una strada di Roma era un po’ come una cupa di campagna, solo che al posto delle sponde di terra con gli arbusti penduli c’erano alte sponde di mattoni e steli di fanali. Adesso sentivo l’odore di frittura che usciva denso da una friggitoria. Odori nuovi per me; buono, piacevole quello che annusai passando davanti a un negozio con la scritta Pizzicheria. Dentro c’erano meravigliose torri di tonde scatolette rosse.
Scendemmo in un viale di periferia. Qui c’era gente più distesa, una folla ilare il cui vociare si dondolava a momenti sui rami delle acacie e restava talora come improvvisamente fermo nell’aria. Aspiravo profondamente l’odore delle gaggie, che mi riportava celermente al ricordo di Madonna della Strada. Qui però era costruito tutt’intorno, la strada era incassata tra gli alti fabbricati come un fiume tra alte rive scavate. Una strada di Roma era un po’ come una cupa di campagna, solo che al posto delle sponde di terra con gli arbusti penduli c’erano alte sponde di mattoni e steli di fanali. Adesso sentivo l’odore di frittura che usciva denso da una friggitoria. Odori nuovi per me; buono, piacevole quello che annusai passando davanti a un negozio con la scritta Pizzicheria. Dentro c’erano meravigliose torri di tonde scatolette rosse.
Voltammo in una strada morta, buia, dove non passava nessuno. Lo zio mi condusse in una latteria, un posto bianco di infinita tristezza. L’odore qui mi stomacava, detestavo il latte. Al banco c’era un uomo tutto vestito di bianco, aveva un lungo grembiule. Odorava di latte, aveva bianchissime le mani. A servire c’era anche una ragazza con un berrettino bianco a forma di bustina. La ragazza rideva con un militare, mentre gli serviva una coppa di panna. Trangugiai senza fiatare il bicchiere di latte che lo zio mi aveva porto. Mi domandò se ne desiderassi ancora. Risposi “Nz, grazie”. Lo zio mi suggerì di dire no invece di nz. “No, grazie”, feci io.
 In quel posto di desolante disperazione, in quel limbo albicante ebbi un urto del sangue, un soprassalto di palpiti nella gola:avevo visto mio padre, seduto a uno dei tavoli lungo il muro, mio padre che mangiava un uovo fritto intingendo nel rosso i pezzetti di pane. In quel sepolcro imbiancato e piastrellato.
In quel posto di desolante disperazione, in quel limbo albicante ebbi un urto del sangue, un soprassalto di palpiti nella gola:avevo visto mio padre, seduto a uno dei tavoli lungo il muro, mio padre che mangiava un uovo fritto intingendo nel rosso i pezzetti di pane. In quel sepolcro imbiancato e piastrellato.
Riprendemmo il tragitto per la strada morta. Passò una solitaria motocicletta a tutto gas, lasciandosi dietro un penetrante odore di olio bruciato. La strada mi pesava nelle gambe, camminavo in silenzio senza sapere dove fossimo diretti, neppure lo avevo domandato. Affrettavo il passo per uguagliare le falcate dello zio taciturno. M’ero incupito, attristato, sentivo un dolore indefinibile, oscuro. Mi entrava dentro per vie sconosciute, non era il dolore delle sassate di Nicolino. Questo era un disgusto, una nausea. Mi dissi che Roma era quel dolore, il mio spasmo indefinibile.
 Eravamo accaldati, camminavamo senza una parola. L’asfalto era molle ed esalava un odore acuto. Le case s’erano fatte rade, finché la strada morta andò a perdersi in un luogo aperto, buio, da cui si vedevano lontani fanali. Arrivammo sotto un caseggiato immenso, altissimo, una enorme scatola grigia che s’innalzava da un terrapieno in mezzo a sterri, al centro di una radura di sterpaglia, dove c’erano cumuli di detriti disseminati qua e là. Ai margini nereggiava l’imponente torre di tubi di un gasometro e, sotto, la sagoma a denti di sega di un tetto di fabbrica dalla tozza ciminiera.
Eravamo accaldati, camminavamo senza una parola. L’asfalto era molle ed esalava un odore acuto. Le case s’erano fatte rade, finché la strada morta andò a perdersi in un luogo aperto, buio, da cui si vedevano lontani fanali. Arrivammo sotto un caseggiato immenso, altissimo, una enorme scatola grigia che s’innalzava da un terrapieno in mezzo a sterri, al centro di una radura di sterpaglia, dove c’erano cumuli di detriti disseminati qua e là. Ai margini nereggiava l’imponente torre di tubi di un gasometro e, sotto, la sagoma a denti di sega di un tetto di fabbrica dalla tozza ciminiera.
Salimmo per una scala che mi parve interminabile, fino alla cima del caseggiato, là dove c’era l’appartamento dello zio. Lì dentro mi sentivo soffocare, lo spazio mi si chiudeva intorno. La zia scambiò brevi parole con lo zio. Mi prepararono una branda nella camera da pranzo e mi mandarono a letto. Ma non potei dormire. Guardavo l’ombra listata della persiana. Noi a casa non avevamo persiane ma imposte e tra queste passavano spiragli di luce, lame in tralice che dividevano il buio della stanza, quando nei pomeriggi di caldura , mia madre ci obbligava ad andare a letto.
Mi alzai e mi misi alla finestra. L’altezza mi sembrava vertiginosa, non ero mai stato così in alto. Guardavo l’abisso della radura,laggiù. Scrutavo il cielo. Le stelle brillavano pallide,sbiadite. Lassù arrivava un indistinto rumore, come un sommesso grugnito. Sentivo una radio, da basso. Una voce falso-flautata cantava:”Vecchia Romaaa, sotto la lunaa, non canti piùùùù…”
Da “Il Giorno dell’ira e altri racconti”di Renato Gabriele, L’Argonauta Editore, 2003