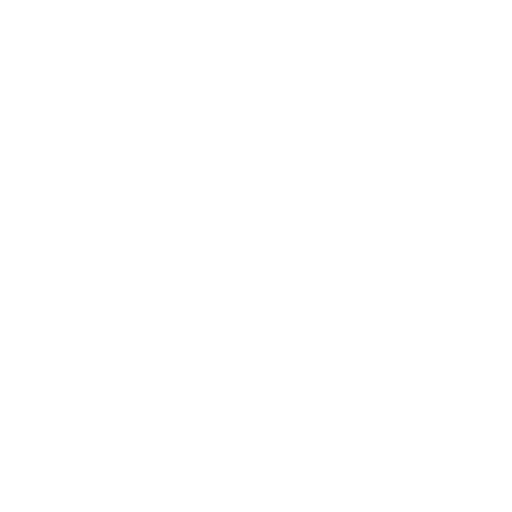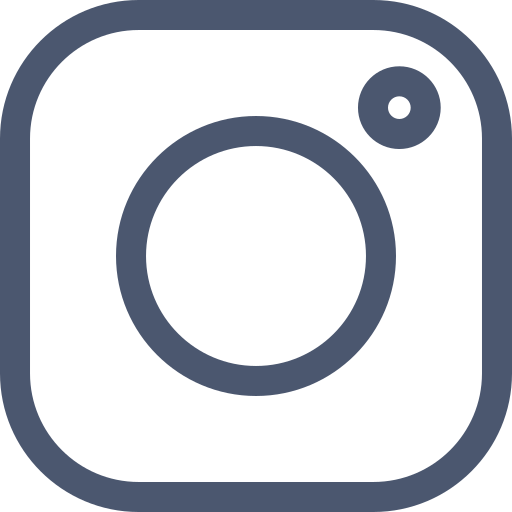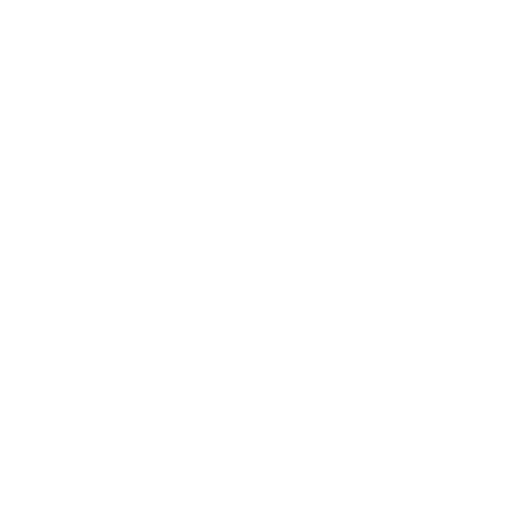Dal Romanzo Il comandante della caccia reale di Renato Gabriele (Genesi, Torino 2008). Il libro narra la vicenda, intorno all’anno 1830, di Nicandro Ferrante, master di caccia di Francesco I di Borbone. Il Romanzo è stato selezionato per il Premio Campiello 2008. Clicca qui per vedere la scheda del libro
Il libro sarà in vendita durante il workshop.
S’incamminò per la lieve discesa di Toledo inondata di sole ed ormai molto animata. Era completamente stordito dall’alto rumore che vi risuonava come un cacofonico sottofondo musicale dal quale a strappi, secondo il prevalere dell’uno o dell’altro strumento, si poteva distinguere ora un sonoro zoccolare ora un arrotare o un battito metallico ora il richiamo d’un venditore ora il vociare di un gruppo di persone o una canzone proveniente da una finestra.
Diversi lo seguivano con lo sguardo e qualcuno addirittura si voltava, forse incuriosito dal contrasto che fra loro facevano i vestiti dal tono tanto discorde e dal fucile che portava con la canna in giù, a spasso per la città, unitamente alla borsaccia. Gli si avvicinò un fratacchione di cerca che gli chiese l’elemosina per le anime del purgatorio ma lo fece con un tono che gli suonò insultante. Dette una moneta e pensò che forse avrebbe fatto meglio a tenere la giacca vecchia ed a lasciare la nuova al sarto, per ritirarla l’indomani insieme con le brache.
Considerato che il sole scaldava a sufficienza ed anzi finanche troppo, si svestì della giacca ed andava portandola ripiegata sul braccio, restando con il solo panciotto sulla camicia.
Il largo di San Ferdinando a Chiaia brulicava di gente intorno ad un paio di saltimbanchi. I due caffè erano pieni di uomini in tuba e vestiti di nero. In giro c’erano donne con l’ombrellino e nugoli di ragazzini rattoppati, da cui don Nicandro si tenne accuratamente alla larga, reputandoli pericolosi marioncelli ed avendo per giunta l’impaccio del bagaglio e dell’arma, che sicuramente riducevano le sue difese contro i borseggiatori. E tra quella gente dovevano essercene molti.
Si fermò sulla piazza di palazzo. Eccola là davanti, la chiesa di Pietro Bianchi, la intravedeva dietro l’impalcatura. Non gli parve una cosa speciale, almeno per quello che ne avrebbe potuto capire lui; doveva però essere importante, se lo stesso architetto aveva saputo ideare quella grande macchina del teatro mobile alla Fagianeria, un marchingegno poderoso, per l’Anticristo!, che aveva potuto essere smontato in così poco tempo e trasportato altrove.
*
*
*
*

*
*
*
*
Camminando per la via fu costretto a mettere i piedi in certi rivoli d’acqua o d’altri liquami, cercando intanto di schivare scoli e iatture che potessero macchiargli la chamberga. Ma non poté schivare le continue richieste d’elemosina che gli faceva una moltitudine di persone malridotte, coperte di stracci e chiaramente denutrite, con gli occhi infossati dalla fame, emaciate, ingobbite e bitorzolute, zoppe e gozzute, cieche e mutilate, che suscitavano in lui uno schifo istintivo e nessun intenerimento caritativo ma reazioni d’insofferenza per nulla temperate:-Passa là, dannato zelluso…fetente! Non me toccare co’ ‘ste luride mani, per l’Anticristo!
Queste oltraggiose proteste gli causarono alla fine un’aggressione in un vicolo stretto in cui, ignorando che fosse a cul di sacco, era andato a cacciarsi. Se la cavò menando cazzotti poderosi e calci da mulo, senza neppur dover toccare la sferra che portava infilata alla cintura. Dovette però cambiare itinerario e portarsi a Toledo, dove c’era tanta gente e dove il numero dei mendicanti, pur non scemando, era più concentrato nei pressi delle chiese, dove ormai sul far della sera andava parecchia gente per la funzione vesperale, ed all’uscita dei palazzi gentilizi e dei conventi, dove restavano ad aspettare gli avanzi della cena.
Dopo aver bighellonato per fondachi e botteghe, guardando con insistenza negli occhi alle donne che passavano a piedi o in carrozza, quando gli riusciva di farlo, senza essere per nulla intimorito dalla presenza degli uomini che le accompagnavano, pensò di rientrare a palazzo. Non prima però di aver fatto le compere progettate e che volle abbondanti: di maccaroni e di zampi di porco arrostiti, di zeppolelle e di altre fritture. Per terminare con le dolcezze, aveva comprato frutti canditi e cioccolatte.
*
*
*

Stava dirigendosi al Montedidio con lo scopo di vedere la ragazza, di presentarsi a lei sia per levarsi l’uzzolo che le trame della madre gli avevano messo in capo, sia per provare, non si sa mai, a corteggiarla, come aveva ormai capito di dover fare, corteggiare le donne che non amavano le maniere spicce alle quali lui era aduso, lui che per la verità trovava ridicole le mosse del suo mentore in proposito, il dolcissimo Fergola.Lui, il guardiacaccia, non aveva mai imparato a corteggiare ed al più era stato capace di fare due regali, trovando che questa fosse una facile strada di approccio alle grazie femminili.
Per la strada però aveva cambiato idea sullo scopo della visita. Il nuovo proposito gli era stato suggerito dalla sensazione che gli avevano dato, quel giorno come quello precedente, le continue richieste d’elemosina di certi poveri cenciosi e gli sguardi di alcuni che incontrava: la senzasione di essere da quelli reputato un signore, e forse anche facoltoso. Avrebbe allora ben potuto presentarsi in una modisteria, anche per comprare qualche cosa di più costoso ed importante di una cuffia ricamata.
La modisteria si riconosceva da lontano per un’insegna a bandiera a forma di cappello. Da un braccio metallico infisso nel muro pendeva una sagoma di lamiera piuttosto sottile, ritagliata sul profilo di una cappina femminile alla moda, del tipo a sporta, e tutta dipinta a colori vivaci, così il passamano che accostava le tese per annodarsi sotto il mento, così i fiorellini e le aigrettes che ornavano la piatta cupoletta. Sulla cornice alta della porta, per chi provenisse dall’incrocio delle strade, e perciò visibile ben da lontano, era posta una vasta tabella di bandone leggermente curvato di foggia rococò, con dipinta la scritta Mode al centro di due silouettes, l’una di un paio di guanti lunghi, l’altra ancora di un cappellino.
L’interno ebbe su Nicandro l’effetto di una cappella di preghiera, per il sommesso mormorio che l’attraversava, senza che si distinguesse da quali labbra provenisse quel parlottare, se non da un’indistinta origine posta al centro di certi gruppi di due o tre giovani lavoranti a capo chino, la cui calma operosità fatta di svelti gesti di mani sicure, l’affascinava a guardare.
*
*
*
Nicandro veleggiava a lunghi passi nel vento, che davanti al Castiello tirava gelido e gagliardo. Ad Astroni avevano forse già indossato i tabarri, a scanso che l’umido respiro del bosco intaccasse le ossa; forse avevano anche acceso i camini ed allungavano già le gambe alla fiamma, arrostendo le prime castagne per ingannare le ore del buio, che nel cono profondo della foresta anticipava la notte.
L’autunno che pareva in quei giorni talvolta smentito da certe brevi sopravvivenze dell’estate, si capiva comunque definitivamente arrivato: dalla qualità e dal colore dell’aria nelle sere e dai voli degli uccelli bruni, partiti ormai le rondini e i balestrucci, a rigare i più pallidi tramonti.
Anche a Napoli, finiti i fichi tardivi, s’erano già visti i frutti autunnali e soprattutto le ceste ricolme di castagne di Mercogliano, quei bei frutti così freschi e lucenti, e dentro così bianchi e sodi, con la barba dei fioricini ancora intatta.
A falcate s’era lasciato alle spalle l’Incoronatella ed in breve era giunto alla rua catalana, ancora alquanto animata, anche se i garzoni delle botteghe avevano cominciato a sgomberare, dagli attrezzi di lavoro e dai materiali d’ogni genere, la stretta strada che, tutta quant’era lunga, era selciata. Restavano all’aperto soltanto le opere finite e la merce, insomma soltanto gli oggetti da vendere. E così restavano appesi ai ganci esterni delle botteghe i panari e i canestri, i cordami d’ogni tipo e misura e, ammonticchiati com’era possibile alla meglio, per non ostruire il traffico dei carri e della gente, botti e varrili, mastelli e tinozze, e banchetti carichi di scelle di baccalà e d’arenghe affummichiate…
Negli interni già riluceva qualche lampa, come nell’officina d’un ferraro e nel fondaco d’un carbonaio, un uomo dalla faccia totalmente nera, in cui roteavano gli occhi d’un bianco inusitato, intento a spalare, per ammassarli in gruppi più grossi, i residui della vendita del giorno, che puzzavano del piscio d’ogni cane di passaggio.
Uscendo per recarsi al teatro di San Carlo, ch’era proprio a due passi, girato l’angolo del palazzo reale, si ricordò di dover avvertire il guardaporta che sarebbe rincasato dopo l’ora normale di chiusura ma questi lo rassicurò che lo avrebbe trovato anche a quell’ora nella bussola a vetri, essendo previsti alcuni rientri a quattr’ore di notte, per via di altri spettatori dell’opera, gente importante del secondo piano.
Giunto sulla vasta piazza di palazzo, si volse alla sua sinistra, nella direzione del mare, scrutando il cielo, ma brevemente perché l’addensamento delle nubi attestava chiaramente come stesse mettendosi il tempo. Pioggia, di certo, e neanche poca! L’inverno, pensò Nicandro, si promette acquoso. Si lasciò andare al pensiero o piuttosto alla visione, tanto gli era nitida l’immagine davanti agli occhi, della pioggia, quando cadeva a fiumi su Astroni.
Mancando ancora un paio d’ore all’incontro con il barone, che doveva avvenire sotto il porticato del teatro, andò alla ricerca d’un barbiere per farsi radere. Presto trovò una bottega in cui c’era da attendere poco essendovi soltanto due avventori da servire, meno che nelle altre barberie, che aveva incontrato numerose nei quartieri spagnoli.
Entrò senza salutare e rispose con un salute a voi ai salamelecchi dell’untuoso padrone, che lo aveva chiamato cavaliere eccellenza. Tre erano i clienti serviti in quel momento, in turno c’era poi un giovane musicista o studente, che di continuo apriva con uno scatto la custodia del suo strumento, una sfavillante cornetta, che traeva fuori e soppesava per provarne i tasti con le dita e quindi riporla sul velluto rosso cupo e richiudere poi la nera scatola sagomata. L’altro in attesa era un barbogio in calze nere di seta e scarpe verniciate e dalle fibbie dorate, alla moda delle calzature che Nicandro aveva visto indossare solo dai prelati.
*
*
*
Dopo circa un’ora ritornarono sulla piazza di palazzo, ormai sulla via di rientrare a casa per il pranzo domenicale. In piazza c’era un assembramento di gente che pareva far ali ad uno spettacolo o ad una gara che si stesse svolgendo lì in mezzo. Molti infatti urlavano incitamenti e sbattevano le mani o alzavano i pugni. Domandarono ai presenti senza però ben comprendere le risposte. Si trattava di una gara tra uomini che montavano…sì! certi cavalli meccanici, una diavoleria che veniva esibita per la prima volta in pubblico.
Si avvicinarono al canapo che delimitava lo spazio di quella giostra e videro da lontano, su certi stranissimi trabiccoli, due uomini scamiciati che affannavano a girare intorno ad una meta e si urtavano urlando come ossessi indiavolati. La prima a riconoscere Nicandro in uno dei due concorrenti, prima ancora di sentirlo urlare: per l’Anticristo t’afferro e te passo!, fu Pompilia. Lo vide che sgomitava allungando quelle zampacce da cane, chillo farabutto d’uno tradetore, per fare leva in terra e spingere in avanti quel marchingegno. Alla fine, arrivato per primo in mezzo a due panzoni in tuba, uno di qua uno di là, scese dal trabiccolo trafelato ed ansante, con le narici da cane ancor più dilatate del solito, ma possente, sangue di Giuda!, ed imponente, e ricevette da uno dei panzoni, che gridava: il vincitore, il vincitore!, una ghirlanda infiocchettata. E Pompilia dovette anche sopportare l’umiliazione di assistere al gesto plateale che il comandante fece, ma da chi l’aveva mai visto fare quell’orso cicisbeo?, di consegnare la ghirlanda a Margareta, che gli reggeva, quella smorfiosa inguantata di bianco, la giacca: proprio come una di famiglia, una mogliera!, e di nominarla regina davanti alla folla acclamante:- La ghirlanda la dongo a chesta regina jonna, a chesta figliola ch’è la rigina de chesta jurnata, a ‘sta bardascia affatata e gentile, che ave d’oro li capilli!
*
*
*
Si diresse dunque alla rua catalana dove trovò una babilonia di gente nelle cui voci risuonavano lingue e dialetti incomprensibili. Oh maronna! Pure li Turchi ce stanno! Per ogni dove si vendeva qualcosa, sia roba da mangiare che cianfrusaglie. Si soffermò un poco a guardare un grassone con un turbante sormontato da una piccola falce di luna, ma che parlava napolitano con una voce pastosa ed arrochita, che gli gonfiava il collo, ad ogni parola, come quello di un rospo. L’uomo era impegnato in quell’uguale cantilena ipnotica che accompagna sempre il gioco delle tre carte, in cui era intento con le sue grassocce ma mobilissime mani dalle unghie cerchiate di una farda nera.
Allontanatosi da quel crocchio si sentì chiamare dalla voce di un ragazzetto alle sue spalle. Avrà avuto sette od al massimo otto anni ed era in compagnia d’una torma di coetanei scalzi e smandrappati come lui.-Signo’, signo’, vedite ccà…- Gl’indicava quella che diceva una grossa macchia, una lordura di grasso, giusto al centro delle spalle, su quella sciammeria tanto bella.
Nicandro non riusciva a guardare in quel punto della schiena e fece spallucce scacciando la banda di ragazzini con un gesto della mano e continuando a camminare. Ma uno di quelli, per convincerlo, gli aveva passato un dito su quell’untume nero e glielo aveva mostrato.- La vedite ‘sta ‘nzogna nera?- Nicandro allora si tolse la giacca e quelli l’aiutarono, facendo di tutto, ancorché lui li scacciasse come mosche fastidiose, per grattare il grosso di quella spessa e densa materia.- Vabbuono, iatevenne mo! Guarda tu che canchero m’hanno cumbinato a ‘sta sciamberga nova nova! Vabbuono accussì, iatevenne, iatevenne!-
I ragazzini, che fino a quel momento ridacchiavano sfottenti, che peccato…’sta bella sciammeria…guarda ccà!, e si davano di gomito strizzandosi l’occhio, si mostrarono come risentiti ed offesi dalle urla di don Nicandro e si dileguarono rapidamente. Fu allora, appena quelli furono spariti dalla sua vista, che Nicandro portò istintivamente la mano alla tasca della chamberga. Vuota. Un tuffo al cuore.
Meccanicamente tastò il giustacuore. Il rigonfio era lì, quello almeno per fortuna. Certo avevano dovuto tastarlo anche chilli nati da cane, bastardi mariuoli. Adesso che ci pensava, si rendeva conto di averli scacciati , ed in malo modo, non per reazione a quella finzione d’aiutarlo ma per il fastidio d’essere toccato simultaneamente da tante mani in ogni parte del corpo. Ecco, cercavano il fagottone, il pacco grosso, e dovevano aver urtato anche la sferra che portava alla cintura, dovevano averla subito vista, ‘sti muccusi delinquenti! E lui, la sferra, quella no che non gliel’avrebbe lasciata sfilare; i denari sì, in quello erano riusciti. Altra cosa sarebbe stato il tentativo di sottrargli il coltello, la cui presenza al suo fianco era né più né meno che quella di un arto aggiuntivo e di cui serbava la coscienza che si ha delle membra del corpo.
 Renato Gabriele è scrittore, poeta e saggista.
Renato Gabriele è scrittore, poeta e saggista.
Cell. +39 349 6678755
Email: renatogabriele43@gmail.com