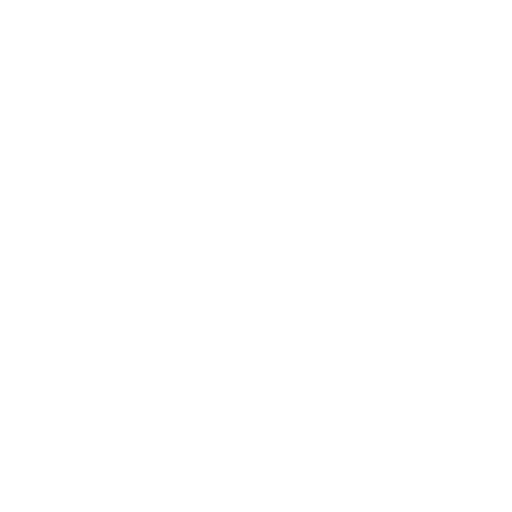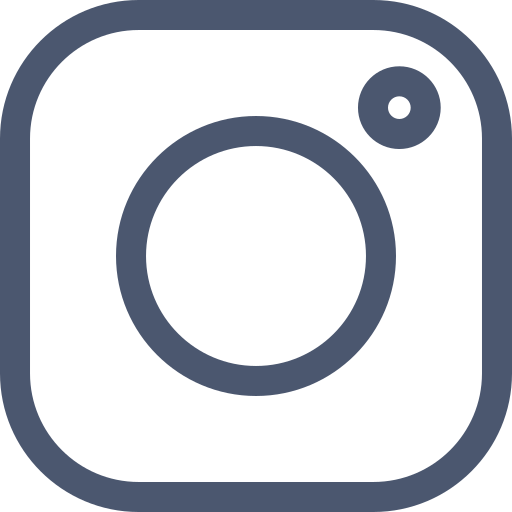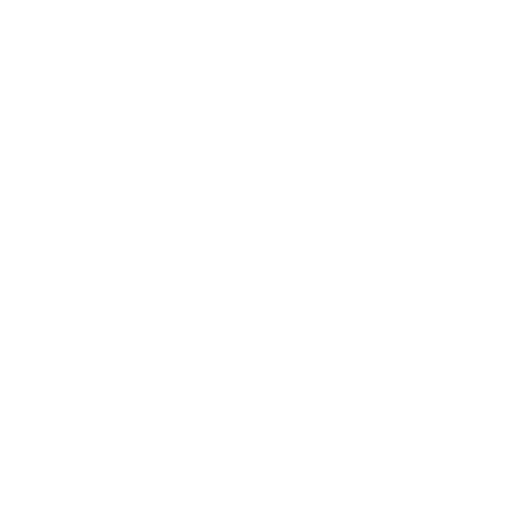Se esiste una strada epica è proprio la Route 66 negli Stati Uniti. Epica perché il solo nome la lega ad una serie di miti che hanno influenzato non solo il nostro modo di viaggiare ma anche quello di essere e di pensare. “The mother Road”, la chiamano, ossia “la strada Madre” quella da cui tutte le strade hanno origine mentale. I cartelli lungo i locali storici la chiamano con tutti gli altri aggettivi possibili: “Legendary” oppure “Historic” o amichevolmente “Old”.
Ma andiamo per ordine e iniziamo proprio dalla fine: La Route 66 non esiste più. E forse proprio questo è servito ad aumentarne il fascino e la notorietà, a renderla immortale nonostante sia stata ufficialmente dismessa e sostituita dalla più moderna Interstate 40, una enorme autostrada a 6 corsie che segue grosso modo il vecchio tracciato e collega ora come allora Chicago a Los Angeles, anzi, a Santa Monica, per essere precisi.
 Gli americani hanno spazio e soldi: preferiscono rifare una strada che ampliarla, e i criteri di costruzione della Route 66 (risalivano a circa 100 anni fa ) oggi non sono più validi: c’erano troppe salite, troppi villaggi, troppa strada fatta per aggirare una montagna. Oggi i tracciati sono diversi, si punta tutto a risparmiare tempo, soldi, benzina e quindi la strada è morta fisicamente ma il suo spirito è vivo più di prima nell’immaginario collettivo di milioni di viaggiatori in tutto il mondo.
Gli americani hanno spazio e soldi: preferiscono rifare una strada che ampliarla, e i criteri di costruzione della Route 66 (risalivano a circa 100 anni fa ) oggi non sono più validi: c’erano troppe salite, troppi villaggi, troppa strada fatta per aggirare una montagna. Oggi i tracciati sono diversi, si punta tutto a risparmiare tempo, soldi, benzina e quindi la strada è morta fisicamente ma il suo spirito è vivo più di prima nell’immaginario collettivo di milioni di viaggiatori in tutto il mondo.
Perchè il mito? Perchè le sue 2138 miglia (circa 3400 chilometri) sono state percorse da milioni di camionisti e automobilisti che la percorrevano in modo pionieristico nei decenni che andavano dagli anni ‘20 ai ‘70 del secolo scorso. Occorreva affrontare la strada: sedimentare dentro di sé la distanza e i tempi necessari a percorrerla e afferrare il volante per mettersi alla guida. I primi anni, ovviamente non c’era neanche l’asfalto: era un vero e proprio rally da fare, e il premio era già il solo arrivare a destinazione. Le figure più importanti legate alla strada erano proprio i meccanici e i gommisti insieme ai benzinai che avevano un ruolo più sociale che economico: senza di loro il viaggio non sarebbe arrivato a destinazione.
 Dato che ci volevano giorni per percorrerla interamente, come nelle nostre moderne autostrade le altre tappe obbligate in cui fermarsi erano i motel ed i ristoranti disseminati lungo tutto il percorso. Migliaia di avamposti sparsi nel nulla, nel bel mezzo di un deserto o in cima ad un valico di montagna sul quale, una volta arrivati, occorreva far riposare i motori per abbassarne la temperatura che saliva in proporzione allo sforzo dovuto alla pendenza e alla quota. Le soste non erano tutte uguali, c’erano dei posti che vivevano di una loro notorietà dovuta a qualcosa che li distingueva da tutti gli altri e la gente era disposta ad allungare le proprie tappe per arrivarci: la più buona torta di mele della Route 66, oppure la più bella cameriera del Missouri, o la famosa bistecca di manzo del Big Texan da 72 once (circa due chili di carne) che si può mangiare gratis ma solo per chi riesca a finirla in 60 minuti, entrando poi di diritto nell’Albo d’Oro del ristorante di Amarillo.
Dato che ci volevano giorni per percorrerla interamente, come nelle nostre moderne autostrade le altre tappe obbligate in cui fermarsi erano i motel ed i ristoranti disseminati lungo tutto il percorso. Migliaia di avamposti sparsi nel nulla, nel bel mezzo di un deserto o in cima ad un valico di montagna sul quale, una volta arrivati, occorreva far riposare i motori per abbassarne la temperatura che saliva in proporzione allo sforzo dovuto alla pendenza e alla quota. Le soste non erano tutte uguali, c’erano dei posti che vivevano di una loro notorietà dovuta a qualcosa che li distingueva da tutti gli altri e la gente era disposta ad allungare le proprie tappe per arrivarci: la più buona torta di mele della Route 66, oppure la più bella cameriera del Missouri, o la famosa bistecca di manzo del Big Texan da 72 once (circa due chili di carne) che si può mangiare gratis ma solo per chi riesca a finirla in 60 minuti, entrando poi di diritto nell’Albo d’Oro del ristorante di Amarillo.
 La Route 66 era una sorta di lungo villaggio su strada in cui ciascuno degli esercenti conosceva bene i propri vicini e aveva almeno sentito parlare di tutti gli altri; con alcuni si era in amicizia, con altri in guerra commerciale. Nessuno era mai veramente da solo lungo quella strada, anche quando intorno non c’era anima viva. Quei locali, a volte fetidi altre volte delle vere a proprie oasi di pace, erano sempre da qualche parte dietro ad una curva, in fondo al rettilineo, in cima alla salita per dare conforto o aiuto ai viaggiatori.
La Route 66 era una sorta di lungo villaggio su strada in cui ciascuno degli esercenti conosceva bene i propri vicini e aveva almeno sentito parlare di tutti gli altri; con alcuni si era in amicizia, con altri in guerra commerciale. Nessuno era mai veramente da solo lungo quella strada, anche quando intorno non c’era anima viva. Quei locali, a volte fetidi altre volte delle vere a proprie oasi di pace, erano sempre da qualche parte dietro ad una curva, in fondo al rettilineo, in cima alla salita per dare conforto o aiuto ai viaggiatori.
 E tutto questo ben lo sapevano Jack Kerouac e gli altri poeti della Beat Generation che vedevano nella grande strada la realizzazione di un ideale di libertà, il mezzo per vivere il grande sogno americano. La strada come metafora della vita, non solo come percorso fisico su un nastro di asfalto, ma come un vero esercizio di stile filosofico. La strada era, ed è ancora, il mezzo con il quale spostare il pensiero dall’orizzonte in cui è rinchiuso dentro casa. Ecco quindi che il solo fatto di percorrerla è già una crescita personale, un arricchimento interiore. “On the Road”, era il titolo del libro che ha ispirato tutto questo movimento di pensiero: essere sulla strada è la condizione necessaria per avvicinarsi fisicamente e mentalmente a tutto questo.
E tutto questo ben lo sapevano Jack Kerouac e gli altri poeti della Beat Generation che vedevano nella grande strada la realizzazione di un ideale di libertà, il mezzo per vivere il grande sogno americano. La strada come metafora della vita, non solo come percorso fisico su un nastro di asfalto, ma come un vero esercizio di stile filosofico. La strada era, ed è ancora, il mezzo con il quale spostare il pensiero dall’orizzonte in cui è rinchiuso dentro casa. Ecco quindi che il solo fatto di percorrerla è già una crescita personale, un arricchimento interiore. “On the Road”, era il titolo del libro che ha ispirato tutto questo movimento di pensiero: essere sulla strada è la condizione necessaria per avvicinarsi fisicamente e mentalmente a tutto questo.
 La strada è luogo di incontro con gli altri e con se stessi, un posto di scambio di merci e di esperienze. La sosta in un locale era l’occasione per sapere le condizioni meteo, o di eventuali incidenti, frane ecc. Così come avviene nella vita di tutti i giorni quando ci si ferma a riflettere su cosa ci accade intorno, altrettanto il viaggio on the road è l’occasione per incontrare tutto questo e il modo migliore per farlo è di sicuro una scoppiettante moto Harley Davidson che è la realizzazione meccanica di uno stile di vita basato su grandi ideali di pace e libertà.
La strada è luogo di incontro con gli altri e con se stessi, un posto di scambio di merci e di esperienze. La sosta in un locale era l’occasione per sapere le condizioni meteo, o di eventuali incidenti, frane ecc. Così come avviene nella vita di tutti i giorni quando ci si ferma a riflettere su cosa ci accade intorno, altrettanto il viaggio on the road è l’occasione per incontrare tutto questo e il modo migliore per farlo è di sicuro una scoppiettante moto Harley Davidson che è la realizzazione meccanica di uno stile di vita basato su grandi ideali di pace e libertà.
 Poi è arrivata la modernità, la Route 66 ha perso velocemente la sua utilità di collegamento ma non il suo fascino. Oggi è stata sostituita e coperta dal nuovo tracciato che in alcuni tratti la lascia ancora visibile al Viaggiatore in tutta la sua bellezza. In alcuni tratti, sì… Oggi la strada ci appare come una viuzza di campagna con una sola corsia per senso di marcia, i locali che un tempo erano brulicanti di vita, di lavoro, di persone e di servizi ora sono chiusi, decadenti, abbandonati e pieni di fascino senza tempo. Alcuni di quelli che si trovavano nelle città ancora riescono a restare aperti, sono diventati dei “musei”, vere istituzioni che ancora funzionano a pieno ritmo, alcuni sono stati rinnovati o lasciati al loro destino, altri infine sono diventati negozietti in cui si vendono souvenir turistici legati alla strada: antiche targhe di automobile originali, giubbotti da motociclisti, insegne di vecchi ristoranti o marche di benzine e pneumatici degli anni ‘50 mischiati a paccottiglia di produzione seriale cinese.
Poi è arrivata la modernità, la Route 66 ha perso velocemente la sua utilità di collegamento ma non il suo fascino. Oggi è stata sostituita e coperta dal nuovo tracciato che in alcuni tratti la lascia ancora visibile al Viaggiatore in tutta la sua bellezza. In alcuni tratti, sì… Oggi la strada ci appare come una viuzza di campagna con una sola corsia per senso di marcia, i locali che un tempo erano brulicanti di vita, di lavoro, di persone e di servizi ora sono chiusi, decadenti, abbandonati e pieni di fascino senza tempo. Alcuni di quelli che si trovavano nelle città ancora riescono a restare aperti, sono diventati dei “musei”, vere istituzioni che ancora funzionano a pieno ritmo, alcuni sono stati rinnovati o lasciati al loro destino, altri infine sono diventati negozietti in cui si vendono souvenir turistici legati alla strada: antiche targhe di automobile originali, giubbotti da motociclisti, insegne di vecchi ristoranti o marche di benzine e pneumatici degli anni ‘50 mischiati a paccottiglia di produzione seriale cinese.
Nonostante tutto, la strada mantiene ben vivo il suo mito, di strade famose per i Viaggiatori ce ne sono tante in tutti i continenti: dalla Transandina alla Panamericana, dalla Transtibetana alla Carretera della Muerte o alla Great Ocean Road, ma la Route 66 le batte tutte per fascino e notorietà, a parte la nostra Via Appia, l’antica Regina Viarum che da 2000 anni assolve a questo ruolo per noi italiani.

La cosa che lascia stupiti è che anche nei tratti urbani le strade sono vuote, le auto sono pochissime e non esistono file ai semafori. Le cittadine che si incontrano lungo il percorso, anche quelle abitate, hanno strade sono enormi anche in pieno centro e sempre vuote, la gente non cammina a piedi, l’America non è un posto dove si può camminare a piedi, le distanze sono troppo grandi. L’impressione che si ha è quella di vivere in un vecchio film western nel quale le case non sono più di legno ma di cemento armato e i cavalli ora hanno quattro ruote ed un motore.
Lungo “La Strada” si ha ancora quel senso di vuoto che provava James Dean in Gioventù bruciata, ed è ancora possibile sentirsi liberi come Dennis Hopper e Peter Fonda in Easy Rider. Questa strada è stata la la musa ispiratrice di film anche più recenti come Thelma e Louise nella loro fuga dalla vita, e persino di Cars, un film di animazione della Pixar in cui le auto prendono vita e anche questo è ambientato sulla “sixtysix”. Impossibile viaggiare senza sentire di vivere come in un film, impossibile non riconoscere un po’ di noi stessi in ciascuna di quelle storie; guidando su quelle strade si rivivono quelle emozioni in prima persona. Come in un film.

Così come nella vita ci sono periodi in cui ci si ferma a pensare, anche le soste fanno parte del viaggio, ed è possibile scegliere il posto giusto per farlo: ci sono locali che mantengono il loro fascino inalterato, in cui è ancora possibile mangiare un hamburger ascoltando la musica nostalgica e intramontabile di Bob Dylan o le note del rock texano e incalzante dei barbuti ZZ Top. Questa strada ha ispirato artisti di ogni genere; i musicisti non potevano rimanere insensibili al suo fascino, pensando ad essa hanno scritto gli evergreen che oggi tutti cantano a squarciagola nella radio della macchina noleggiata per viaggiare da quelle parti. Musica e cibo in viaggio sono elementi di fortissima ispirazione e mescolati insieme sono in grado di moltiplicare le emozioni, si mescolano con la nostra anima, con la nostra cultura e fanno poi parte di noi. Nessuno mai potrà dimenticare il sapore della senape sulle patatine mangiate in auto guidando e ascoltando Elvis o i Rolling Stones nel deserto del New Mexico. Una emozione forte non si dimentica, più emozioni forti vissute contemporaneamente rimangono profonde ed evidenti come una cicatrice della quale andare fieri, come un enorme tatuaggio da esibire in strada.
 Oggi percorrere quello che resta della vecchia Route 66 è ancora un’impresa: la strada non è tracciata, occorre avere una buona mappa e seguire (dove ci sono) le indicazioni per la “Historic Route 66”, sono delle stradine secondarie desolate e piene di fascino, a volte si interrompono nel nulla e occorre tornare indietro perchè non si innestano con nessuna altra strada. Occorre armarsi di pazienza e di un certo spirito di avventura per “sentire” la strada; il bello è proprio scoprirla miglio dopo miglio, accorgersi di scorci mozzafiato o di noiosissimi passaggi nel vuoto assoluto del grande continente americano. Questo è il viaggio dei viaggi, quello che si fa per esserci, per sentire di far parte di qualcosa, di un luogo, di una storia che non finirà mai. La Route 66 è l’essenza stessa del viaggio, è il viaggio fatto per viaggiare, per scoprire se stessi sulla strada della vita.
Oggi percorrere quello che resta della vecchia Route 66 è ancora un’impresa: la strada non è tracciata, occorre avere una buona mappa e seguire (dove ci sono) le indicazioni per la “Historic Route 66”, sono delle stradine secondarie desolate e piene di fascino, a volte si interrompono nel nulla e occorre tornare indietro perchè non si innestano con nessuna altra strada. Occorre armarsi di pazienza e di un certo spirito di avventura per “sentire” la strada; il bello è proprio scoprirla miglio dopo miglio, accorgersi di scorci mozzafiato o di noiosissimi passaggi nel vuoto assoluto del grande continente americano. Questo è il viaggio dei viaggi, quello che si fa per esserci, per sentire di far parte di qualcosa, di un luogo, di una storia che non finirà mai. La Route 66 è l’essenza stessa del viaggio, è il viaggio fatto per viaggiare, per scoprire se stessi sulla strada della vita.
 Si impiegano circa 2 settimane a percorrere tutta la strada che separa il lago Michigan dall’Oceano Pacifico. Per fermarsi a vedere qualcosa come per un selfie vicino ad un motel storico, si impiega del tempo che va aggiunto ai tempi di guida e questo va sommato ai tempi di un riposino o di una visita ad una delle “Ghost Town”, le tante cittadine rimaste abbandonate intorno ad un distributore di carburanti in disuso. Camminando in questi luoghi si sente un silenzio che va oltre il non sentire rumori, questo è qualcosa di più profondo, quasi il rispetto che si deve ai luoghi sacri o ai cimiteri. La sensazione che spesso si prova è quella di una grande anima che aleggia ancora in quei posti che prima erano così pieni di vita, di gente, di lavoro.
Si impiegano circa 2 settimane a percorrere tutta la strada che separa il lago Michigan dall’Oceano Pacifico. Per fermarsi a vedere qualcosa come per un selfie vicino ad un motel storico, si impiega del tempo che va aggiunto ai tempi di guida e questo va sommato ai tempi di un riposino o di una visita ad una delle “Ghost Town”, le tante cittadine rimaste abbandonate intorno ad un distributore di carburanti in disuso. Camminando in questi luoghi si sente un silenzio che va oltre il non sentire rumori, questo è qualcosa di più profondo, quasi il rispetto che si deve ai luoghi sacri o ai cimiteri. La sensazione che spesso si prova è quella di una grande anima che aleggia ancora in quei posti che prima erano così pieni di vita, di gente, di lavoro.
 Questo viaggio deve essere preparato non sul web e sulle migliaia di libri che ne parlano dal punto di vista turistico, questo è un viaggio dell’anima, occorre prepararsi spiritualmente ad una esperienza che sarà forte e travolgente, nulla sarà più come prima. Partire per la Route 66 significa documentarsi su chi l’ha percorsa prima di noi, ascoltare musica, guardare foto e film, leggere romanzi. Significa guidare con il finestrino abbassato, senza l’aria condizionata, solo così la strada potrà essere un’esperienza di vita e non “solo” un grande viaggio.
Questo viaggio deve essere preparato non sul web e sulle migliaia di libri che ne parlano dal punto di vista turistico, questo è un viaggio dell’anima, occorre prepararsi spiritualmente ad una esperienza che sarà forte e travolgente, nulla sarà più come prima. Partire per la Route 66 significa documentarsi su chi l’ha percorsa prima di noi, ascoltare musica, guardare foto e film, leggere romanzi. Significa guidare con il finestrino abbassato, senza l’aria condizionata, solo così la strada potrà essere un’esperienza di vita e non “solo” un grande viaggio.