Foto e parole di Francesco Carmignoto
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

 In volo verso la Tunisia avevo un unico desiderio: spingermi oltre il già visto e smettere di scattare normali foto di bei luoghi, per iniziare a fare belle foto di luoghi normali. Ma subito mi sono scontrata con una difficoltà. Cos’era davvero normale in un mondo così lontano e così diverso dal mio, dove abitudini, tradizioni, cultura e storia apparivano ancora non contaminate dalla globalizzazione?
In volo verso la Tunisia avevo un unico desiderio: spingermi oltre il già visto e smettere di scattare normali foto di bei luoghi, per iniziare a fare belle foto di luoghi normali. Ma subito mi sono scontrata con una difficoltà. Cos’era davvero normale in un mondo così lontano e così diverso dal mio, dove abitudini, tradizioni, cultura e storia apparivano ancora non contaminate dalla globalizzazione?

Poi mi sono semplicemente lasciata catturare dal fascino senza tempo di quel cono di terra che si snoda tra la Libia e l’Algeria.
Laggiù la luce calda e intensa trasmette un senso assoluto di solitudine e serenità che trasporta in una dimensione vibrante di energia. E’ come una forza antica e potente: la stessa che permea le vaste distese di sabbia e aridità.


L’effetto di quella luce è in ogni piega dei volti di chi nel deserto vive e lavora, fabbricando mattoni, pascolando il bestiame, dormendo in capanne fatiscenti. Ho incontrato famiglie di nomadi e seminomadi e nei loro tratti scavati dalla fatica ho scorto il peso di una vita durissima. Su quella pelle, segnata da solchi profondi, sono impressi i segni del sole cocente, della sabbia e del vento.

Le guance scavate e gli zigomi sporgenti riflettono la fatica e la durezza di una vita lungamente messa alla prova dalla penuria di acqua, di cibo e di riposo. Eppure quei volti raccontano storie di coraggio, saggezza e resilienza da cui traspare una bellezza autentica, plasmata dalla forza interiore di chi lotta quotidianamente per sopravvivere. Diverso, ma forse ancora più graffiante, è lo sguardo dei bambini, sulle prime un po’ smarrito davanti alla fotocamera ma, subito dopo, risoluto e penetrante. Faticavo a immaginare che quella vita all’insegna della povertà, così lontana dagli agi e dalle comodità del mondo occidentale, avrebbe continuato a fluire implacabile anche dopo il mio passaggio troppo rapido perché potessi coglierne pienamente il peso e il significato.


Diverse, invece, sono state le sensazioni scaturite dall’incontro con le popolazioni berbere e le loro tradizioni millenarie di persone accoglienti, semplici, assai povere. Eppure non è raro scorgere i loro visi sorridenti che fanno capolino dalle abitazioni dei villaggi in cui abitano. A Matmata, Toujane e Zammour le abitazioni troglodite sono scavate nel terreno argilloso che mi ha inghiottita quando, con un po’ di riluttanza, ho dovuto dormirvi. Non nascondo di essere stata spaventata dal quel contatto diretto con la natura che, invece, mi ha offerto un riparo confortevole in cui gli iniziali timori si sono sciolti nella dolcezza inaspettata della sua protezione, così contrastante con quella forza primordiale proveniente dall’energia selvaggia che si sprigiona in quell’ambiente apparentemente ostile e misterioso, soprattutto per chi non lo conosce. Ma è proprio laggiù che può avvenire un autentico richiamo alla nostra connessione con la natura, alla nostra capacità di adattamento e alla nostra ricerca di significato in un mondo complesso: è un luogo dove, come per magia, forza e fragilità sembrano fondersi in una danza eterna.

Foto e parole di Roberta Vitali
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


In mondi ai confini della società industrializzata esistono società che sembra si muovano a velocità differenziata dove l’iniziativa e la fantasia del singolo ancora non sono state sostituite da attività imprenditoriali caratterizzate da un coacervo di spregiudicate capacità operative, capitali, strutture e profitto.

Qui ancora la manualità e la fantasia non perseguono necessariamente l’esasperazione del guadagno (del resto non facilmente ottenibile considerando la realtà di quelle economie). Ciò avrebbe come immediata conseguenza un decremento di genuinità sia dei prodotti che dei rapporti umani. Sembra quasi che si tenda a privilegiare uno status quo temporaneamente immobile nel tempo senza apparenti aspirazioni a sviluppi.

Quindi: Oggi come ieri e, con molta probabilità, come domani……
Ma se questa è una faccia della medaglia (il rallentamento dello sviluppo per scelta etica, sociale e religiosa), l’altra mette in risalto una situazione che vede noi, paesi civili (un tempo recente anche colonizzatori), in parte responsabili di questa realtà perché inesorabilmente presenti laddove esiste ancora qualcosa di cui appropriarsi a buon prezzo (petrolio, terre rare, metalli preziosi, paesaggi da utilizzare per turismo ecc.), e completamente e colpevolmente assenti nei paesi dove tutto ciò è carente.

Un’ istantanea immediata ci mostra Paesi in condizioni obbiettivamente difficili fino all’inverosimile, ai quali è stato scippato tutto ciò che era possibile per poi essere abbandonati a loro stessi (competenze zero, preparazione tecnologica scarsa, cultura minimale, strumentazione industriale inutilizzabile per carenza di pezzi di ricambio, occidentali, difficoltà di specializzazione degli addetti.)

Risalta all’occhio curioso una attività non tesa allo spreco (usa e getta) ma ad un utilizzo e riutilizzo dei materiali di ogni genere in una costante attività in cui il tempo non ha più il valore stressante come da noi ma si stende in giornate umanamente sostenibili pur se sostanzialmente faticose.

Siamo sicuri che fra breve tempo i paesi consumisti non saranno costretti a fare marcia indietro e rivedere gli schemi utilizzati fino ad oggi??

Dovremmo prevedere un sistema progressivo di ridimensionamento degli eccessi e frenare il consumismo che distrugge l’ambiente e la società che di “civile” ormai ha solo l’appellativo.

Foto e parole di Roberto Renai
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Siamo nel nord dell’India. Il confine pakistano che si affaccia al Mar Arabico.
Entrare in queste fabbriche non è facile, attraverso alcune persone ben inserite nel contesto sociale, amici di amici che ci procurano un permesso per visitare questi enormi capannoni dal caldo spaventoso. Veniamo abbracciati da campi di acciaio ancora fumante, rumori assordanti e un formicaio di persone, tutto annerito dalla fuliggine del grande forno dall’aspetto vulcanico.

I camion che incessantemente scaricano rottami di grandi dimensioni e caricano il metallo rinnovato uscito dalle ceneri come una fenice nera. All’inizio fotografare e spostarsi qui è veramente difficile, la paura di farsi male o di essere un pericolo per questi instancabili lavoratori è costante. Dopo un po’ ci si abitua e si intuisce dove mettere i piedi, quando abbassare velocemente la testa, quando non respirare e quando proteggere gli occhi.

Queste foto raccontano del mondo delle fonderie di acciaio e della vita lavorativa di uomini che con il riciclo dell’acciaio cercano di sopravvivere. La vita qui per loro si svolge in modo circolare, la mattina gli operai si alzano presto, c’è chi a rotazione prepara i pasti per gli altri.

Chi sta alla fornace, chi al deposito di carbone. Iniziano i turni e gli uomini sono impegnati a demolire vecchi relitti di navi provenienti da tutto il mondo, il metallo viene tagliato, lavorato, fuso e nuovamente trasformato.

Solo il metallo qui cambia vita, purtroppo non accade a questi uomini, loro sono sempre qui, tutti i giorni finché il fisico regge, fino a sera, fino a quando la sirena suona l’arrivo del tramonto.

Una catena umana fatta di fatica, sudore e duro lavoro. Molti occhi curiosi e sorrisi amichevoli ma amari.

Foto e parole di Nicola Ducati
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Ovvero il deserto esistenziale

“Sono tornato là,
Dove non ero mai stato.
Nulla, da come non fu, è mutato.”
Giorgio Caproni

Vita e morte mi appaiono come un’unica funzione che si annulla nel proprio principiare, quasi un movimento fermo, un atto mancato nella caduta del tempo dove le forme dell’esistenza trasmutano nel silenzio, si dissolvono i contorni della vita e persistono, distratti, i residui della memoria nei lacerti della creazione umana.

Impartire bordi alle cose, soffrirne il peso per poi arrendersi alla cieca trasformazione: fremiti del nulla nella vastità dello spirito.

… Ed è in questa marea dell’anima che la morte mi par essere sempre più sorella della vita.

Foto e parole di Tina Salipante
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Chissà come sarebbero le nostre città se fossero vuote.

A volte ce lo siamo chiesti, a volte con difficoltà abbiamo provato ad immaginarlo, altre volte l’abbiamo visto in tv. Le città non sono vuote, come abbiamo sentito spesso ripetere in queste settimane di pandemia.

Le vediamo vuote se le facciamo coincidere con il loro spazio pubblico e se pensiamo che si esauriscano nella loro immagine metafisica, che i giornali e i social ci hanno proposto nei giorni di pandemia.

Ma allo stesso tempo guardando, non soltanto con gli occhi, si vede che queste città restano piene di vita, di corpi e di anime, le nostre, che rimangono invisibili, vite compresse nei modesti o preziosi formicai che sono le nostre case, è dentro di noi, sentiamo lo smarrimento di un tempo che si è dilatato, sentiamo l’ansia, quel non riuscire neppure a leggere o a pensare con profondità alle cose che facciamo.

In queste settimane di quarantena tutti abbiamo capito che è entrata in crisi la nostra stessa idea di abitare, che nella sua accezione più profonda non si esaurisce nella casa, ma la trascende, altrimenti non avremmo fatto così fatica ad accettare questo isolamento.

Si gioca in quell’equilibrio fragile tra interno ed esterno, tra necessità di appartarsi e richiamo della vita collettiva. Siamo feriti nelle certezze, divisi negli affetti, separati da tutto ciò che amiamo.

Dal desiderio di raccontare queste sensazioni… nasce l’idea di “raccontare” queste città e questi spazi vuoti del mondo, così affascinanti, ma anche così ansiosi… e di fotografarli attraverso i video e le foto trovati sul web e di “fermarne il tempo” con una vecchia Poloroid Instant.
Foto e parole di Lello Fargione
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Istanbul, “Un portfolio venuto dal passato”.

“Una capsula del tempo è un contenitore appositamente preparato per conservare oggetti o informazioni, destinato a essere ritrovato in un’epoca futura”.

Nelle nostre case esistono delle capsule del tempo, ma non ce ne rendiamo conto, esse sono le scatole dove sono conservate le vecchie foto.
Le scatole di fotografie vengono spesso ritrovate nei mercatini, i ritrovamenti che sono il frutto dello svuotamento delle cantine e delle abitazioni, che passando di proprietà sia per eredità che per vendita ad altri proprietari, vengono svuotate per far spazio al nuovo.

Passeggiando tra i mercatini, trovo una vecchia scatola di biscotti in latta, l’apro e all’interno trovo una porzione di mondo sospeso nel tempo, è Istanbul, ma non riesco a collocarla in uno spazio temporale ben definito, tutto sembra essersi fermato agli anni 50, ma sarà cosi……..

In questo lavoro ho cercato di giocare tra realtà e finzione.

Sul finire degli anni 90, feci un viaggio ad Istanbul, “città d’oriente che incontra l’occidente”. Questo portfolio è il frutto di quel viaggio, le foto scattate in analogico, sono state digitalizzate e post-prodotte, aumentando virtualmente i segni del tempo, ma ho volutamente lasciato qualche indizio di modernità per svelare il trucco.

Foto e parole di Lugi Cipriano
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Centinaia di cavalli e pastori sulla spiaggia di Saintes Maries:
1000 cavalli, 200 pastori e migliaia di appassionati si riuniscono il 10 e 11 novembre sulla spiaggia di Saintes Maries de la Mer per uno dei più grandi festival dell’abrivado nel sud della Francia. Un incontro unico tra la Camargue, i cavalli, i tori e tutti gli amanti della tradizione taurina.

Ogni giorno, il festival inizia con la colazione offerta sulla spiaggia orientale in un luogo chiamato “Rousty” (parcheggio Bambou Palm Beach). Partenza dei cavalieri e dei tori dalle ore 11 con una colonna di 11 abrivados che si susseguiranno lungo il percorso di 6 km che li porterà all’arena.

Si rievoca il trasferimento come in passato (non c’erano camions) dei tori all’arena al centro del paese per la tradizionale corsa camarghese, una specie di corrida dove però l’unico che rischia è l’uomo.

La difficoltà dei cavalieri sta nel tenere i tori all’interno dell’abrivado, il tutto è complicato dalla presenza di disturbatori che con drappi, petardi e fumogeni (aboliti nell’ultimo festival), cercano di spaventare i cavalli affinché i tori si disperdano…

Uno spettacolo impressionante da vedere assolutamente per innamorarti della Camargue e delle sue tradizioni!

Sono nato, in un angolo selvaggio dove i tori neri sono re; ed è stato scosso dalla mia giovane età dai fenicotteri in subbuglio.
La mia casa era tutta bianca, tra pini e giunchi; e il maestrale con i rami mi compose belle canzoni.
Sono nato su questo suolo arido dove, come Attila, il sole fa mille rughe sulla terra per soffocarne il risveglio.
Ma quando appare la luna e la sua chiarezza inonda le rubine e le grandi paludi, si crederebbe di vedere la fine del mondo.
Je suis …la Camargue
Jean-Marc Allègre

Foto e parole di Claudio Varaldi
Questo racconto ha partecipato ed è stato pubblicato sul libro di Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Il corridoio del Wakhan è un’impervio lembo di terra che si estende nella parte nord-orientale dell’Afghanistan; area tra le più remote del mondo, venne percorsa da Alessandro Magno nel 327, da Marco Polo nel 1271 e da Genghis Khan nel XIII secolo: ramo dell’antica via della Seta, è stato crocevia di comunicazione tra Oriente e Occidente.

È in questa terra severa che, circa 2.500 anni fa, si insediarono i pastori nomadi di origine Kirghisa e i Wakhi, minoranze etniche dalla vita sospesa nel tempo.
I carovanieri kirghisi praticano ancora oggi un nomadismo pastorale: perennemente in viaggio con le loro mandrie e con le loro abitazioni mobili, le yurta, si possono incontrare durante le loro traversate, negli accampamenti temporanei, tra le immensità delle notti stellate, quando è solo la luce calda di un piccolo falò ad illuminare i visi solcati dai segni di un’esistenza durissima.

La vita delle tribù stanziali Wakhi si basa su un’agricoltura di altura combinata con la pastorizia. Fuori le mura dei villaggi le donne mungono e piccoli pastori accudiscono gli animali. I panni lavati nel fiume, nei brevi mesi estivi possono essere stesi sull’erba sotto il cielo terso, tappezzando come arazzi un panorama incantato.

I numerosissimi bambini hanno tratti somatici, così come i loro occhi incredibilmente verdi o di un nero profondo, che rivelano le loro radici iraniche e mongole.

Purtroppo oggi queste popolazioni vengono messe a rischio dal regime talebano. Da quando hanno preso il controllo dell’Afghanistan, i talebani hanno lanciato un assalto ai diritti umani, perseguitando le minoranze etniche e religiose. Il Corridoio è di particolare interesse per il traffico di oppio, in quanto unica frontiera terrestre dell’Afghanistan con la Cina.

Il progetto di una strada che attraverserà quest’area porta con sé implicazioni fortemente negative per le popolazioni locali: contaminazione culturale, antropizzazione di un’area selvaggia, rilocazioni forzate e aumento del presidio talebano.

I talebani avevano promesso un governo inclusivo e tollerante, rispettoso dei diritti della popolazione, dichiarazioni che si sono presto dimostrate false. Le afgane e gli afgani che hanno deciso di rimanere nel paese per provare a darsi un’altra possibilità oggi vivono un incubo senza fine.

Foto e parole di Robertino Radovix
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Durante uno degli ultimi viaggi in Etiopia di ritorno da Gondar verso il Lago Tana, dopo circa un ora di strada la mia guida, Ashennafi Demoz, mi propone di assistere al battesimo copto che, ai piedi della cascata sacra di Addis Zemen, veniva praticato da alcuni frati del vicino convento di Toragedam.

Dopo un percorso abbastanza accidentato ci fermammo subito dopo una curva nel punto dove si apriva un piazzale sterrato e dove, all’interno di un recinto di rami d’albero e frasche, si erano radunate alcune persone.
La mia guida parlotta con il ragazzo che sorvegliava un piccolo e consumato cancelletto in legno e dopo qualche minuto entriamo nell’area appena sotto la cascata dove vari gruppi di persone con dei bambini, da pochi mesi ad alcuni anni, vestiti in con morbidi teli di iuta e ricamati con colori sgargianti, si preparavano per essere battezzati.
Arriviamo alla cascata dove già era entrata una ragazza seguita da un uomo di mezza età il quale, completamente nudo e tremante dal freddo, rimaneva sotto il getto imponente d’acqua coprendosi con le mani le parti intime. La gente intorno pregava, l’atmosfera era molto intima e carica di emozione. Io ero incerto se iniziare a scattare oppure attendere. La mia curiosità e desiderio di fermare per sempre quel magico momento carico di mistero e religiosità, fu troppo forte ed iniziai a scattare prima molto timidamente e poi, alternando gli scatti con alcune riprese video, cercai di padroneggiare la scena cercando comunque di portare il massimo rispetto alle persone presenti.
Dopo la benedizione da parte del frate fu la volta di una ragazza con al collo una croce di metallo ed anche lei fu obbligata a mettersi nuda e ad entrare sotto la gelida e imponente cascata d’acqua. La gente che raccolta pregava sommessamente, di colpo si ferma ed il brusio diviene sempre più forte sino a quasi diventare un grido corale.
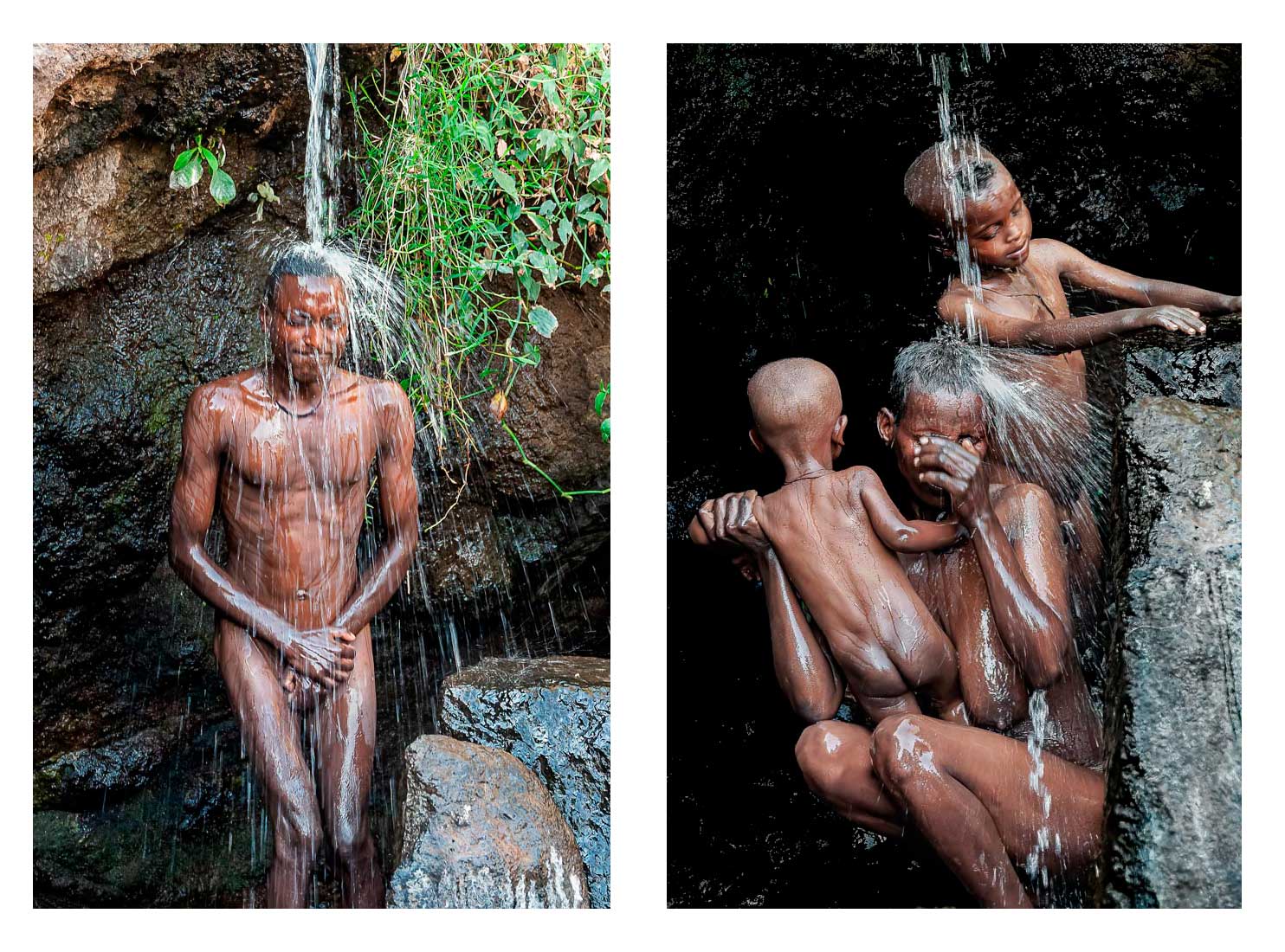
Una ragazza portata da suo fratello dopo aver parlato con un frate entra sotto la cascata con la sola speranza di poter guarire dalla malaria che non riusciva a debellare. La ragazza viene aiutata a spogliarsi ed entra con passo incerto aiutata dal fratello , sin sotto il getto d’acqua. Contemporaneamente dall’altro lato una giovane donna con due bambini si spoglia ed anche lei si mette sotto l’acqua portando con se in braccio il figlio più piccolo e tenendo per mano quello più grandicello, La giovane donne stringe intorno a se sotto l’acqua i suoi due figli, la gente inizia a protestare con un mormorio che va a crescere sino a confondersi con le urla della donna e dei due bambini.
La donna alternava momenti di sconforto e calma apparente ad urla e agitazione incontrollata. Io non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Per fortuna Ashennafi viene in mio soccorso e mi preannuncia che la donna è indemoniata e che tra poco assisteremo ad un esorcismo. Nel frattempo la ragazza ammalata di malaria, tremante e quasi pronta a cadere, viene aiutata dal fratello e da un frate ad uscire dall’acqua ed ad asciugarsi e rivestirsi sedendosi li vicino per riprendere un poco le forze, se ne avesse ancora!

La donna che sempre gridava come un ossessa viene avvicinata da un frate con in mano una grossa croce di metallo dorato. Questo inizia a parlarle prima sommessamente e dopo con grande fermezza e voce imperiosa inizia a vibrare, sulla testa della sedicente indemoniata, numerosi colpi di croce quasi a voler scacciare veramente il demonio che si era impossessato della giovane donna. Dopo alcuni minuti sia la donna che l’esorcista si fanno più calmi ed iniziano a parlare tra loro a voce bassa , la donna scoppia in lacrime e l’esorcista dopo averla benedetta con la croce l’accompagna, insieme ai due bambini, verso il gruppo di persone più vicino.
Un anziano e fiero signore, quasi sicuramente il padre della donna, porta un abito bianco per coprire sua figlia e prende in braccio il più piccolo dei nipoti per asciugarlo. Tutti insieme si avviano verso l’uscita della cascata. Pareva fossero trascorse ore da quando eravamo arrivati e sopraggiunta la calma ci ritroviamo spossati e privi di forze quasi che, quanto accaduto in pochi minuti fosse la conseguenza di una lotta alla quale tutti avevamo partecipato per ore.
Rimango incerto e disorientato e per fortuna ancora una volta Ashennafi viene in mio soccorso, mi prende il gomito e mi invita ad avviarmi con lui verso l’uscita.

Foto e parole di Francesco Merella
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Un paese un po’ lasciato in disparte negli anni passati, forse a causa della sue tragiche vicissitudini abbastanza recenti, la Cambogia è un gioiello affascinante e ricco di storia per un viaggiatore ed ancor più per un fotografo.
Non solo il famosissimo sito di Angkor Wat, una delle mete piu’ visitate al mondo, rimasto nascosto e dimenticato per secoli, ma molto della Cambogia merita essere visitato e vissuto.

I templi buddisti sparsi ovunque, le migliaia di monaci che li abitano, la rigogliosa natura con le sue grandi foreste, il lago Tonle Sap con la sua gente che vive su palafitte e si muove su barche e canoe cosi’ come noi usiamo le auto, i suoi mercati incredibili e affascinanti , l’ottima cucina locale e la grazia e gentilezza della sua popolazione.
I monasteri buddisti sono un punto di raccolta per diversi bambini e ragazzi che altrimenti non avrebbero altre possibilità per studiare e vivere al di fuori della strada. Le loro preghiere, i loro riti , le cerimonie, le benedizioni ai fedeli sono un’occasione unica per il fotografo e per tentare di capire un poco la loro filosofia di vita.

I mercati, come spesso succede in tutto il mondo, sono luoghi incredibili per incontrare la varia umanità e anima pulsante di ogni paese o città. Dal mercato per carne e pesce , ovviamente all’aperto senza frigoriferi e invaso da mosche e insetti vari , all’incredibile “Russian market “ di Phnom Penh , cosi’ chiamato per via della frequentazione degli espatriati russi negli anni 80, dove , tra negozi o meglio piccoli spazi stipati all’inverosimile, viene venduto di tutto e, senza divisori, di fianco al macellaio si trova il “beauty center” o, tra centinaia di pezzi di ricambio per moto e biciclette i bambini, presenti ovunque , vivono le loro giornate.

I cambogiani , almeno quelli incontrati nel mio viaggio, si sono sempre dimostrati una popolazione gentile ed accogliente. La possibilità di entrare nelle loro case, vivere qualche ora con loro , mangiare con loro, mi ha dato la possibilità di conoscerli un po’ piu’ da vicino e conoscere qualche dettaglio della loro recente tragica storia negli anni dei Khmer rossi.
Il quasi novantenne ex combattente ha il corpo ricoperto di tatuaggi quali simboli per la protezione contro le pallottole dei suoi stessi compatrioti durante la sanguinosa guerra civile del 1975-1979, che causo’ la morte di quasi un terzo della popolazione cambogiana. Basta visitare il museo di Tuol Sleng a Phnom Penh ( la famosa prigione S-21) per rendersi conto dell’assurdità e dell’atrocità di quel buio periodo della loro storia.

Alla brutalità di quel periodo si contrappone ora la grazia e gentilezza della maggior parte della giovane popolazione cambogiana. I bambini , numerosissimi e presenti ovunque , si divertono con quel poco che hanno o trovano per strada. Durante le numerose feste locali le bambine vengono spesso truccate e vestite per le tradizionali danze locali.

Come in tutti i paesi in via di sviluppo, le contraddizioni della vita locale sono spinte all’estremo. La maggior parte della popolazione è povera, per non dire poverissima, e di fianco a loro, nella grande città di Phnom Penh, si trova il concessionario della Rolls Royce , della Lamborghini, cosi’ come i negozi dei piu’ famosi stilisti di moda italiani e francesi.

E’ stato un viaggio bellissimo, tra passato e presente , tra ricchezza e povertà, che mi ha fatto scoprire un’altra parte di questo nostro piccolo-grande globo sul quale viviamo.

Foto e parole di Sergio Volani
“Cambogia” ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Quando l’anno scorso ho detto ad amici e conoscenti che sarei andato a fare un Reportage in Armenia, molti di loro mi hanno chiesto perché mai ci andassi ed alcuni mi hanno perfino domandato dove si trovasse.

Meta di viaggio insolita, l’Armenia è un paese bellissimo e ricco di storia, monumenti e paesaggi stupendi; il suo popolo, poi, è ospitale come pochi e pronto ad accogliere il viaggiatore nella semplicità delle proprie case, offrendogli all’occorrenza un sorriso e un caffè.

A livello paesaggistico, ciò che rende riconoscibile l’Armenia sono i numerosi monasteri medievali che costellano gran parte del territorio. Con la loro struttura semplice, sobria e austera, si stagliano su paesaggi visivamente spogli e desolati, spesso sperduti. Di grande interesse artistico per i viaggiatori, rappresentano l’emblema dell’identità armena, intrisa di senso di appartenenza, orgoglio e religiosità.

La religiosità è appunto uno dei capisaldi di questo paese: è noto a tutti quale prezzo abbia dovuto pagare il popolo armeno per abbracciare il cristianesimo come religione ufficiale.
Rappresentativo di questa sofferenza è il fatto che il Monte Ararat, simbolo nazionale del paese e montagna sacra per il popolo armeno, sia geograficamente collocato all’interno del territorio turco, e quindi al di fuori dei confini armeni.

Nonostante il passato difficile e travagliato, però, l’impressione che si ha visitando questo paese è che gli Armeni abbiano saputo mantenere un grande senso di identità e dignità, non facilmente riscontrabile in egual misura presso altri popoli.

A titolo esemplificativo, riporto una notizia letta di recente: a seguito del disastroso terremoto che ha colpito la Turchia, l’Armenia ha deciso di riaprire il confine tra i due paesi, chiuso da ben 30 anni, per inviare aiuti ad Ankara. Questo gesto, più di tante parole, può sicuramente aiutare a comprendere la grandezza del popolo armeno.



India : Il fascino che ti cattura, puoi visitare questo paese 100 volte e rimanere comunque senza parole!
Ogni volta la stessa emozione e ammirazione per un luogo così unico e affascinante. Ti accorgi presto che ciò che per noi è incredibile, diverso o strano per il popolo indiano è invece la normalità e uno stile di vita.

Il fascino dell’ India attraverso gli occhi di un viaggiatore e fotografo sta proprio nel vivere e catturare allo stesso tempo la bellezza e l’unicità di questo Paese. I contrasti così forti e ogni volta una nuova opportunità, sempre con la voglia di raggiungerlo e sicuramente con una diversa maturazione e consapevolezza.

Sei catalizzato e avvolto ogni volta da una strana sensazione che ti accompagna nel viaggio. Respiri la grande devozione e umanità di un popolo dove la ricchezza e il valore delle cose materiali viene vissuto in modo molto diverso e spesso incomprensibile ai nostri occhi.

Emozioni attraverso la luce, le atmosfere, il calore, la spiritualità, la bellezza anche dove c’è niente o poco perché è proprio nelle piccole cose che spesso si rivela il valore più grande.

Ci si rende presto conto che l’importanza sta nell’osservare più che nello scattare. A volte molte immagini non hanno bisogno di essere scattate, restano in noi e aiutano a rafforzare il nostro modo di vedere e documentare. Non ci sono immagini banali o inutili, ma immagini che avremmo potuto documentare diversamente.

In molti reportage in India e nelle migliaia di immagini scattate, spesso prevalgono colore e sentimenti discordanti nel voler rappresentare luoghi, persone e ambienti, ottenendo immagini che non rappresentano esattamente la realtà o ciò che avremmo voluto realizzare.

In questa serie di immagini, riassumendo le tante immagini viste e catturate, ho voluto rappresentare principalmente un’ India dai colori caldi e forti. Accogliente e ricca di emozione e sensorialità, il suo fascino e la sua ricchezza unica e catalizzante. La luce quando aiuta ad immergersi e lasciarsi trasportare e sempre con la voglia di tornare per scoprire e documentare di più.
In realtà è uno di quei luoghi che crea dipendenza, dopo un pò di tempo che non ci vai, senti l’esigenza di tornare ed ogni volta che concludi il viaggio sai che non sarà l’ultimo.

Foto e parole di Luigi Rota
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


I segni indelebili dello Tsunami del 2004 e la guerra civile cruenta in Sri Lanka terminata il 18 maggio 2008, distrussero questa terra ed il suo nuovo futuro è iniziato da allora.

Decisi di viaggiare alcuni anni dalla costa nord ovest di Jaffna alla costa sud a wiligama passando per le grandi colline del centro fino a Nuwara Elia, ritraendo le piccole donne tamil raccoglitrici del the.

In questo lavoro ho voluto ricercare le storie e i racconti anche di quel passato, ma provando a vederne la bellezza attraverso la fotografia in bianco e nero.

Un viaggio dalle colline del The di Nuwara Elia alle coste a nord di Mannar distretto settentrionale confinate con il continente Indiano ancora oggi zona militarizzata.

Oggi questa terra ricomincia a vivere ed a convivere (anche se con estrema difficoltà vivendo per il suo 80% di turismo), con quel passato che oggi rimane nelle testimonianze nei volti e nelle storie della gente dello Sri Lanka.
Foto e parole di Maurizio Gjivovich
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione
La storia di Maurizio Gjivovich qui pubblicata è esposta a Roma fino al 21 febbraio 2024 presso la OTTO Gallery in Piazza Mazzini 27, scala A piano 4.
Quelle che seguono qui sono le foto dell’allestimento:


C’ERA UNA VOLTA IL MARE
Il lago di Aral
Negli ultimi decenni si è consumato un enorme disastro ambientale, quasi sconosciuto, ma forse il più grave; grave perché ampiamente previsto fin dal 1964 da studi appositamente commissionati e ciò nonostante scientemente perseguito.

L’Aral era un grande lago salato, quasi tre volte la Sicilia. Tanto grande da essere chiamato “mare”, il Mar d’atal. Ed era molto pescoso.
Moynak, in Uzbekistan, era un tempo una ridente cittadina sulle rive del Mar d’Aral. Oggi non ride più, perché l’Aral non c’è più. Viveva grazie alla pesca e alla lavorazione del pescato, inscatolato sul posto in una fabbrica i cui prodotti rifornivano tutta l’URSS, di cui faceva parte l’Uzbekistan.

Ma nel secolo scorso l’URSS volle sviluppare l’agricoltura in zone semidesertiche, attingendo le acque d’irrigazione dagli immissari dell’Aral. Si sapeva che l’Aral sarebbe morto, ma si pensava di sfruttare anche le nuove terre emerse per questa coltivazione.

Le acque cominciarono a ritrarsi dal 1960. Nel 2007 il 90% dell’Aral era sparito; la salinità dell’acqua rimasta era decuplicata, rendendo impossibile la vita. La flotta di pescherecci fu abbandonata ad arrugginire sul fondo prosciugato del lago.
La lavorazione del pesce però continuò inscatolando il pescato del Mar Baltico, trasportato in Uzbekistan da migliaia di chilometri, e poi ridistribuito a migliaia di chilometri di distanza. Ma la dissoluzione dell’URSS rese insostenibile questo sistema e la fabbrica fu abbandonata. Lasciando gli abitanti senza risorse: anche l’agricoltura è impossibile, perché le acque dell’Aral, ritirandosi hanno lasciato sul terreno un concentrato di sale, fertilizzanti e pesticidi, con l’aggiunta delle scorie tossiche gettate in acqua da una base militare sovietica, situata in un isola in mezzo all’Aral.

Quando il clima diventa caldo e secco, il che accade molto spesso, il terreno diviene polveroso; il vento porta questa polvere tossica sulla città e i suoi abitanti, ma arriva anche a centinaia di chilometri.

L’unica cosa che cresce sono dei miseri sterpi, buoni solo per le capre e le pecore. Per il resto si vedono uomini e bambini tra le macerie di quella che era la fabbrica del pesce, alla ricerca di rottami ferrosi da vendere per pochi spicci. Non c’è acqua corrente, non ci sono fognature. I bambini che giocano per le strade polverose, sorridendo felici come tutti i bambini, sono l’unica nota di speranza.

Si va in Uzbekistan per vedere la favolosa Samarcanda e le antiche città che costellavano la via della seta. Ma visitare l’Aral, significa visitare qualcosa che non c’è, un non-luogo, un non-mare, pieno di non-acqua e di non-vita. Una distesa di chilometri di conchiglie bianche nel deserto. Non sono le conchiglie fossili che si trovano anche in montagna: sono conchiglie che solo pochi anni fa ospitavano un essere vivente e ora sono li a tappezzare quello che era un fondale.
 Intanto le navi fantasma solcano il deserto, guidate da un faro spento che sorge dove non c’è più la costa.
Intanto le navi fantasma solcano il deserto, guidate da un faro spento che sorge dove non c’è più la costa.
Foto e parole di Roberto Manfredi
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.
La storia di Roberto Manfredi qui pubblicata è esposta a Roma fino al 21 febbraio 2024 presso la OTTO Gallery in Piazza Mazzini 27, scala A piano 4.
Quelle che seguono qui sono le foto dell’allestimento:




Mi chiamo Narghisa sono una materassaia.

Lavoro in questo edificio da così tanto tempo che oramai lo chiamo casa.

Qua trascorro gran parte della mia giornata e con ago e filo cucio insieme scampoli di stoffa e scampoli di vita.

Le fotografie sbiadite alle pareti raccontano di un tempo lontano, lavoravamo in tanti, oggi sono rimasta solo io.

Scrivo a mano con precisione sul mio quaderno gli ultimi ordini.

A breve il laboratorio sarà venduto, stanno costruendo grandi alberghi, stanno immaginando grandi cose e strumenti piccoli come ago e filo non ce la fanno più a tenere insieme i pezzi della storia.

Non so cosa ci sarà qui domani e se resterà la traccia di un ricordo, quello che so è che tutto ciò che fin ora ho realizzato l’ho fatto con le mie mani.

Foto e parole di Laura Pierangeli
“La materassaia di Bukhara” ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


C’è un’antica via di ghiaccio che da generazioni apre le porte del mondo al popolo Zanskari, “chadar”. Siamo in Ladakh, regione dell’India racchiusa tra Karakorum e Himalaya ad oltre 3.700 metri di altezza. Qui, per poco più di un mese, tra gennaio e febbraio, il fiume Zanskar diventa percorribile e rompe l’isolamento dell’inverno.

I mercanti di spezie e stoffe hanno aspettato quel momento ogni inverno per secoli… l’attimo in cui oriente e occidente si incontravano sulla Via della Seta. Sembra ancora di vederli, accalcati tra le locande e nelle strade di Leh, avvolti nei profumi e il vociare dell’antica capitale.

È un cammino incantato e terribile, tra gole profonde, crepacci, dirupi ma anche colori inattesi e cascate di ghiaccio. Avanti, un passo dopo l’altro, nel vento gelido, ho imparato ad ascoltare con rispetto la voce del ghiaccio sotto gli scarponi.

La macchina fotografica per rubare almeno un po’ di quella meraviglia che riempie gli occhi, per cristallizzare i gesti rituali delle guide che si ripetono da secoli: la preparazione delle slitte, l’allestimento delle grotte per i bivacchi, i canti tradizionali che accompagnano in ogni momento della giornata.

Tre giorni di cammino che diventano un viaggio nel tempo verso il monastero di Karsha Gompa, circondato dal suo villaggio, dove il potente suono della Sankha, la tromba conchiglia, richiama i monaci per l’inizio della Puja, la celebrazione del Risveglio del Buddha.

L’antico monastero del X secolo è uno scrigno di storia e spiritualità, ma anche di arte con i suoi straordinari dipinti murali.

Il tesoro più prezioso di Karsha Gompa è, però, la luce nello sguardo dei monaci e del popolo Zanskari… il mio pretesto per tornare a casa è stato quello di poter raccontare quella luce con queste foto.

Foto e parole di Christian Giudice
Questo racconto ha partecipato al Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


I ricordi fanno rumore: le voci, suoni di passanti, risa dei bambini o del vento che insinua ovunque la sabbia divenuta respiro.

Un andare e venire nel mobile sguardo che tutto vuole accogliere e di cui non ha mai abbastanza: orizzonti leggermente frastagliati, cespugli di faticoso verde, vette miti accerchiate d’intenso arancio, morbide dune che dividono lo spazio con l’azzurro liquido, divorato dal verso dei gabbiani.

E il cielo, il grande cielo azzurro o disseminato di nastri di nuvole a raccogliere ombre.

La luce disegna e definisce luoghi, sguardi, intenzioni, pietre, mura policrome sbrecciate incomplete antiche e nuove, uomini e animali, donne e passi frettolosi, bambini e la curiosità del divenire, in un frammento costante pieno di vita.

Quando poi al buio, tutto diventa uno, custodito dal silenzio delle stelle.

Foto di Roberto Malagoli, parole di Lisanna Pina
“Mauritania” è il SECONDO CLASSIFICATO di Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Si tratta di un’ antica lotta indiana chiamata “kushti”.
Ho cercato di raccontare l’intimità e lo svolgersi delle loro giornate/quotidianità

Giovani bambini, spesso di famiglie povere, o salvati dalla vita di strada, vengono assorbiti nella scuola palestra-monastero chiamata akhara già in tenera età, iniziando un percorso di duro allenamento fisico e mentale.

Al rigoroso allenamento si uniscono le fondamentali regole religiose che educano i ragazzi. Tra queste niente sesso, niente alcol, poca vita sociale e rigorosa preghiera alle prime ore del mattino e durante la giornata.

Combattono nella Sacra terra di argilla rossa, chiamati “Akhada”.
L’obiettivo è concentrarsi su uno stile di vita puro per costruire forza mentale e fisica: la debolezza sarà debellata, forza e virilità restituiti all’ uomo, l’orgoglio della nazione restaurato.

La kushti tradizionale sta vivendo un periodo di profonda crisi perdendo il contatto con la terra rossa sostituita da materassini e perdendo la filosofia che la caratterizza a causa di un processo di modernizzazione sociale che tende a svalutare l’aspetto spirituale e rendendo lo spazio/scuola più sicuro e lontano da vecchie pratiche e regole religiose.

I bambini spesso vengono presi dalla strada, orfani e soli. Oppure figli di famiglie povere, quelli piu forti verranno accolti nella scuola. Qui però non riceveranno istruzione scolastica. Se non otterranno titoli e premi nella lotta verranno allontanati e si ritroveranno soli, senza cultura, senza saper leggere. Senza amici e senza saper dare una carezza alla vita, saranno facilmente assorbiti nel crimine!




Da quasi 10 anni viaggio per il mondo alla ricerca di tutte quelle popolazioni e minoranze etniche poco conosciute, spesso invisibili alla nostra società, che ancora sopravvivono alla globalizzazione cercando di mantenere vive le loro caratteristiche tradizioni ancestrali.

Al largo delle coste di Filippine, Malesia ed Indonesia vivono i Bajau,popoli indigeni, nomadi e apolidi conosciuti anche come zingari del mare.

Diffidenti, perché abituati a vivere isolati, sono spesso trattati con indifferenza o denunciati perché considerati immigrati illegali sulla terraferma, infatti non sono riconosciuti da nessuno Stato e non hanno alcun diritto fondamentale.

In passato si muovevano liberamente nei mari del Sud-est asiatico mentre oggi sono più stanziali, ma ancora vivono strettamente legati al mare in piccole palafitte di legno costruite sull’acqua bassa o in barche chiamate “lepas”, lontani dalla terraferma e la sua società.

Hanno una conoscenza dell’Oceano senza eguali e la loro vita trascorre lenta, scandita dai ritmi delle maree.
Esperti apneisti, imparano a nuotare appena nati; la pesca e la raccolta di conchiglie e crostacei rappresentano la fonte principale di sostentamento dei Bajau, che raggiungono la costa solamente per commerciare i loro prodotti o per ripararsi dalle forti tempeste.

Salis, un pescatore Bajau, mi ha introdotto nella sua comunità facendo da interprete e permettendomi di fotografare il loro stile di vita e le loro abitudini. Mi ha raccontato che ha provato a trasferirsi sulla terraferma per lavorare in città, ma dopo qualche mese, il richiamo nostalgico del mare è stato troppo forte ed è tornato a vivere nella sua palafitta, scappando dalla routine e dalla quotidianità di una vita stanziale.

L’inasprimento dei controlli, la graduale diminuzione della fauna marina e le restrizioni ai loro movimenti stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dei Bajau, ma trasferirsi sulla terraferma e abbandonare il loro stile di vita non è ancora un’opzione contemplata.

Foto di Jacopo Della Valle, parole di Anita Palma
“Waterworld” E’ IL VINCITORE ASSOLUTO di Travel Tales Award 2023. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Balance in the confusion – Mi sono trovato spesso a chiedermi come sia viaggiare in India per la prima volta. Io la mia opportunità non l’ho mai avuta. Sono figlio di un viaggiatore che ha fatto dell’India la sua meta preferita, perciò i tantissimi racconti di questo luogo non mi hanno permesso di viverla questa “prima volta “.

Posso però mostrare come vivo interiormente i miei diversi viaggi in questa terra.
Il titolo del progetto lo racconta brevemente e il mio vissuto lo trasforma in quelle che sono le mie personali sensazioni, quando entro in questo luogo che per me è magico.

All’interno di un mondo confusionario fatto di suoni, rumori, occhi grandi di bambini che sorridono e altri che ti “squadrano”. Fatto di oscurità e colore, di profumi e odori forti, di commercianti e mendicanti, e di fede.

In mezzo a tutta questa apparente confusione io trovo la mia pace, il mio equilibrio, un mondo rallentato che mi permette di osservare dentro ad ogni persona che inquadro e mette tutto al suo posto regalandomi quel senso di magia che provo ogni volta che sono qui.

Foto e parole di Giulio Cesare Grandi
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Islanda. In nessun luogo al mondo come su quest’isola all’estremo nord dell’Europa ci si sente al limite tra due opposti, come se camminassimo lungo una linea sottile tracciata tra due diversi universi.

Siamo in Islanda, che già di per sé non è un’unica isola, come superficialmente appare se ci limitiamo ad osservare la mappa. Qui affiorano e si incontrano due diverse placche tettoniche. La cosa fa sì, ad esempio, che un giorno calpesti suolo europeo, mentre un altro sei già in America.

Qui, lingue di ghiaccio che nascono dalle montagne dell’interno finiscono la loro corsa gettandosi in acque scaldate dalla Corrente del Golfo. All’interno, intanto, getti di vapore bollente fuoriescono impetuosi dalla neve.

Guidi nelle aree densamente popolate della costa, ma poco dopo ti trovi ad attraversare territori completamente deserti per centinaia di chilometri, pietraie nere che non ospitano da millenni neanche le forme di vita più elementari.
Tutto qui sembra essere al crocevia tra universi opposti.

Porticcioli, barche da pesca, marinai abituati a prendere il largo incuranti di ogni meteo. Anche qui, mi chiedo se le scene a cui assito appartengono al presente o se non siano piuttosto ricordi, dejà vu di un passato a lungo sognato, fatto di terre estreme e avventure immaginate.

E’ un mondo a colori, come nel mirino della mia reflex, o soltanto monocromatico, come se lo vedessi sul vetro smerigliato di una vecchia macchina a lastre?

Tutto è come camminare lungo una linea sottile. Un po’ di qua, un po’ di là

Foto e parole di Aldo Frezza
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Sana’a è ancora la bellissima Venezia d’Oriente dei miei ricordi del viaggio di alcuni anni or sono.
Pochi i kalashnikov a tracolla. Restano i jambiya, i pugnaloni ricurvi portati nella fascia attorno ai fianchi da tutti i maschi yemeniti, le case deliziose di mattoni color ocra, gli archi delle porte e delle terrazze, le decorazioni di gesso che contornano le finestre, i vetri dai tanti colori. Una fantasia irrefrenabile di ricami che salgono nelle facciate, nei vicoli, nelle piazzette e nei giardini con palme e alberi da frutto.

Lo sguardo si sofferma inebriato dal bellissimo e umano disordine.
Partiamo subito per i monti dell’Harazz, in un susseguirsi di piccoli villaggi arroccati sui pendii. Sembrano fortificati come quelli del nostro Medioevo. Da ogni cocuzzolo i castelli turriti dominano le larghe terrazze coltivate. Quasi tutte ad alberelli di qat, delle cui foglioline gli yemeniti vanno matti.

Ecco le belle case in pietra rosata di Thilla, distesa sul pendio. Nel suo negozietto ritrovo la giovane donna di un viaggio precedente, che non portava il velo e che mi aveva assicurato con forza che lei non lo avrebbe mai messo.

Mi mostra orgogliosa il suo volto, con un sorriso allegro. Anche le donne yemenite possono avere un simbolo di libertà! Le faccio i miei complimenti, ricordandole l’incontro di sei anni prima. Mi aggiro nel suo negozio pieno di oggetti interessanti. Compro una specie di cuore di alabastro trasparente, intarsiato con curiose scritte in ebraico. Non sono convinto che sia antico, ma mi sembra molto bello e misterioso.
Nello Yemen erano molti gli ebrei, spesso artigiani bravissimi a lavorare anche l’argento e considerati veri maestri nel cesellare i più preziosi jambiya.

Foto e parole di Francesco Carmignoto
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Israele non è un Paese qualunque.
Israele è un concentrato di emozioni, contraddizioni, stati d’animo, profumi. L’arrivo a Tel Aviv si presenta come un’odissea di controlli meticolosi, lunghi ed estenuanti. Poi esci dal terminal e ti ritrovi proiettato in una città giovane, eccentrica, di tendenza.

Tel Aviv non dorme mai quasi a sembrare l’oblio dei giovani israeliani, che vogliono lasciarsi alle spalle le complessità della vita quotidiana.
Poi Gerusalemme.

Qui potrei scrivere un libro, come d’altra parte potrei non scrivere nulla. Gerusalemme è una città impossibile da raccontare, puoi solo farti guidare da emozioni e sensazioni.
La città vecchia intanto; dentro le antiche mura è bellissima, i colori chiari e tenui, il suq pieno di gente, avvolta dai colori della frutta, dal profumo di pane fresco, e spezie. Tutt’intorno le chiese, i minareti, contornate da vicoli che formano un labirinto quasi senza fine.

La città è divisa in quattro quartieri: il quartiere musulmano, ebraico, cristiano e armeno. In ognuno di questi settori, si percepiscono, si vedono, si toccano le singole diversità e differenze. In ogni spazio si delineano tutte le icone delle singole religioni monoteiste: il Muro del Pianto, la Chiesa del Santo Sepolcro, la Spianata delle Moschee.

Camminando in questi luoghi sacri, si avverte tutta la carica emotiva, tutte le tensioni, e quella strana energia, che deriva dalla convivenza in spazi decisamente compressi. A fine giornata senti il cuore, la testa e l’anima che chiedono a gran voce un po’ di riposo. Con gli occhi di medico e la mia grande passione per la fotografia, ho cercato di catturare ogni mia singola emozione in uno scatto. Gerusalemme è respirare emozioni con l’anima.

Un semplice tramonto si trasforma in una luce sensoriale, l’alba ti travolge di spiritualità interiore. La fotografia è lo specchio di un’interpretazione emotiva soggettiva, personale. E’ in grado di sviluppare quella chimica cellulare che accende la comunicazione sensoriale di chi osserva. A Gerusalemme tutto ciò è possibile.
Foto e parole di Milena Masini
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Un viaggio in Tunisia per raccontare “Il Maghreb Dimenticato”. Un progetto per diffondere e far conoscere le popolazioni Berbere del Nord-Africa. Il progetto costituisce un’occasione di riflessione sulla civiltà mediterranea, sui caratteri di parentela e non di antagonismo tra popolazioni che rappresentano la cultura millenaria del Maghreb, e che concorrono alla creazione della nostra storia comune fin dall’alba dei tempi.

Le aree montuose del Dahar, nel sud desertico della Tunisia, sono caratterizzate da paesaggi di monti aridi e rocciosi stagliati da erosioni di milioni di anni. Qui sorgono villaggi abitati da tempi immemori da popolazioni che noi genericamente chiamiamo “Berberi” o Imazighen (uomini liberi), come essi preferiscono definirsi.
Usi e costumi di antica memoria sono stati mantenuti e tramandati e costituiscono quell’ “essenza Berbera” che aveva affascinato lo storiografo tunisino Ibn Khaldoun che nel XIV secolo ne raccontò storia e gesta.
Il viaggio è l’occasione per entrare in contatto con lo stile di vita delle comunità di questi villaggi dove il tempo scorre lento tra paesaggi evocativi ed emozionanti. Tradizioni secolari scandiscono la vita quotidiana, gestita soprattutto dalle donne.

Ancora vestite con abbigliamenti lontani dal XXI secolo svolgono tutti i lavori più pesanti, in casa come nei campi. Le antiche fibule utilizzate per l’abbigliamento e i tatuaggi marcano un’identità che difficilmente si potrà tramandare. Per fotografare non bisogna essere invadenti. E’ necessario stabilire un contatto in modo da poter condividere momenti importanti della quotidianità e così osservare attività legate alle tradizioni locali. Ho anche la fortuna di assistere ad una “Fantasia”; straordinaria esibizione equestre di antica tradizione, sfrenata corsa di cavalli in cui viene simulato un attacco armato.

Qui il turismo di massa non è mai arrivato e le primavere arabe hanno solo contribuito ad accentuare l’isolamento di questi luoghi. Villaggi celati nel paesaggio come Chenini, Douiret, Guermessa, Matmata, Tamerza punteggiano un territorio di desertica grandiosità con architetture caratterizzate dalla presenza di cittadelle abbarbicate sulle rocce o sorprendenti abitazioni trogloditiche scavate nella terra.

La miscela tra nomadismo, agricoltura e sedentarizzazione è il vero fondamento su cui si basava la creazione degli Ksour: castelli con la funzione di granai. All’interno, ogni famiglia possedeva, e la pratica era in vigore fino a pochi anni fa, il suo ghorfa, una celletta di stoccaggio dei generi di prima necessitò (olio d’oliva, cereali).

Alcuni di questi granai fortificati, come Ksar Ouled Sultane, possono essere considerati veri e propri capolavori architettonici. Ksar Metameur, Ksar Hallouf, Ksar Haddada, Ksar Mrabtine, Ksar El Ferch, Ksar Gattoufa, Ksar Kedim, Ksar Ouled Debab, Ksar Ouled Sultane…, come una litania di santi ogni spuntone roccioso o avamposto di pianura conserva uno ksar o i ruderi di quello che un tempo lo era. Ne esistono più di 150, molti avvolti solo dal silenzio dell’abbandono, ma tutti degni di uno sguardo che però il tempo non può assicurare.

Foto e parole di Luigi Vigliotti
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Isole Lofoten – Il termine “arcipelago” a me, e penso a molti altri, suggerisce infallibilmente la visione di spiagge tropicali che scendono in acque cristalline, costellate da palme inclinate che si protendono verso il mare.

-Dove vai? -Alle isole Lofoten -Che bello! Non prendere troppo sole!
Raccomandazione nemmeno troppo stupida, perché alle Lofoten, per tutto il mese di giugno, ci sono 24 ore di sole al giorno. Sì, perché le Lofoten si trovano all’interno del circolo polare artico, dove, all’inizio dell’estate, si può vedere il sole di mezzanotte.

-Vai in marzo? Chissà che freddo!
-Davvero! Pensa che a Svolvær (che per inciso è la più antica città del circolo polare artico) la temperatura minima di marzo è in media di ben due gradi sotto zero! Ma non c’entra il riscaldamento globale: grazie alla Corrente del Golfo le Lofoten hanno la più grande anomalia di temperatura positiva al mondo rispetto alla latitudine. L’Islanda, ad esempio, si trova più a sud ma è molto più fredda!

E grazie a queste singolarità che le Lofoten ci offrono qualcosa di unico, senza chiederci di morire di freddo. Paesaggi artici davvero singolari, dove si possono ammirare montagne innevate che si gettano nel mare, fiordi che si inoltrano nell’entroterra al punto che risulta difficile capire se si sta guardando il mare o un lago, vedute decorate da piccole città e dalle onnipresenti “rorbu”, le caratteristiche abitazioni su palafitte, sempre dipinte di rosso pompeiano.

Ma le Lofoten non sarebbero magiche come sono se non ci fosse la dama verde. Le aurore boreali. Che qui si possono osservare in una situazione geoclimatica pressoché ideale. Arrivano quando vogliono, si offrono, danzano, danno al paesaggio, già fiabesco di suo, un pizzico di magia. E poi se ne vanno, lasciandoci senza fiato.
Foto e parole di Roberto Manfredi
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


Due cose colpiscono viaggiando in Myanmar: l’intensa attività di costruzione, mantenimento e allargamento della rete stradale e il fatto che gli aspetti più faticosi di questa attività vengano svolti per la maggior parte da manodopera di genere femminile.

Le donne in Myanmar hanno un grado di indipendenza e autonomia relativamente maggiore rispetto ad altri paesi asiatici. Il sistema educativo però le penalizza, le posizioni di responsabilità sono precluse e conseguentemente a esse sono affidati i lavori più faticosi e di minor valore.

La costruzione delle strade è un esempio immediato di tutto ciò. L’attività è piuttosto semplice, sulla terra viene disposto un letto di sassi e successivamente passato il catrame.

Il lavoro di raccolta e trasporto di grandi pietre, la loro successiva rottura in sassi più piccoli, il trasporto e il posizionamento finale di quest’ultimi sono tutti demandati al genere femminile.

Gli uomini si occupano solo della guida degli automezzi, del fuoco che scioglie il catrame e del versamento del catrame stesso sui sassi. Tutte attività che comportano molto più pause di quelle svolte dalle donne.

Questo tipo di cantieri si trova spesso su qualsiasi strada si faccia; già poche foto testimoniano quanto descritto e spiegano più di molte parole.

Foto e parole di Maurizio Trifilidis
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

In Madagascar, la città di Ambatolampy è rinomata per i suoi manufatti in alluminio. I turisti vengono portati lì da compagnie di viaggio per acquistare bellissimi oggetti in alluminio lucido.

Possono entrare nelle manifatture e osservare la gente del posto al lavoro. Giovani uomini e adolescenti si guadagnano da vivere fondendo vecchie parti metalliche, da qui il nome “aluminium slaves”. I pezzi vengono raccolti in tutto il paese e portati in questa città.

Come ovunque in Madagascar, le persone usano il carbone per accendere fuochi. Qui lo usano per fondere il metallo, una volta smontati i blocchi motore o le barriere metalliche. Mettono le parti metalliche in pentole sterili e le fondono. Quindi portano le pentole con il metallo fuso nelle case con tetto e lo versano negli stampi che hanno preparato in precedenza, con argilla, sabbia e legno.

Non ci sono precauzioni di sicurezza: gli uomini maneggiano le pentole di alluminio liquido a mani nude. Versano il liquido in forme semplici accanto ai loro piedi nudi. Per tutto il giorno respirano la polvere e l’inquinamento, dalla prima infanzia in poi. Alla fine della giornata, l’elettricità viene interrotta afferrando il cavo nudo dal contatto.

Le manifatture sono presentate come una forma di lavoro romantica e vecchio stile, ma è una vita molto dura. E la gente continua a sorridere.
Sono dovuto andare in Madagascar per una conferenza sulla biologia della conservazione. Ho trascorso un mese viaggiando e cercando di capire le dinamiche di un paese con una distruzione devastante. Con questa serie voglio documentare la vita di questi lavoratori che ho visitato due volte durante il mio soggiorno in Madagascar nell’agosto 2019.

Foto e parole di Pia Parolin
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


La Pasqua è la festività più sacra di tutto l’anno per il mondo ortodosso, ed anche in Grecia è particolarmente sentita. Sull’isola di Karpathos, nel piccolo villaggio di Olympos, abbarbicato sulle montagne a nord dell’isola, si svolgono ancora i riti pasquali legati alle tradizioni bizantine.

La festa coinvolge tutti gli abitanti del piccolo paesino, ed inizia il venerdì santo (Megali Paraskevi) , quando donne e bambini portano in chiesa fiori per decorare l’Epitaffio, bara simbolica di Cristo , sulla quale vengono anche appese foto dei defunti nell’ultimo anno . Alla sera, l’Epitaffio viene portato in processione nelle viuzze del paese, fermandosi nelle case per la recita di preghiere.
Il sabato è la giornata dedicata alla preparazione del pranzo pasquale. Le donne fanno il pane negli antichi forni e viene messa a cuocere la capra, piatto tipico di questa festa. Alla sera inizia il rito pasquale che si prolunga per ore, in una chiesa gremita di gente.

Le celebrazioni terminano il martedì con la processione delle icone attraverso il paese fino al piccolo cimitero e poi in giro per i sentieri fermandosi nelle piccole chiesette disseminate ovunque nella vallata circostante.

Foto e testo di Sergio Volani
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Il mio lavoro fotografico è costantemente ispirato dall’arte e dall’architettura che mi circonda nella mia città natale Roma, e dalla diversità di coloro che la frequentano. La collezione di immagini “The homage and the hero” è realizzata con un senso di profonda gratitudine per l’unicità e la bellezza di ciò che abbiamo intorno e per la possibilità di poterne usufruire. In questa collezione racconto l’apprezzamento per il lavoro che altri hanno svolto nel creare tale bellezza nella opposta relazione tra l’omaggio e l’eroe.
Da un lato la vita erratica e vulnerabile dell’eroe dello scatto, “the hero”. Si tratta di colui o colei che sta vivendo quel luogo, che ne definisce lo spazio, il protagonista dell’immagine. Ha colto la mia attenzione, passa di li per caso o che magari viene dal lato opposto della terra per visitare la città e la sua architettura anche solo per una volta. Mostra meraviglia e stupore per l’unicità di ciò che vede.
Dall’altro vi è invece l’elemento architettonico, “the homage”, ovvero il dono lasciato da coloro che ci hanno preceduti. Spesso origine di dolori e sofferenze, di punizioni e sacrifici. L’omaggio è li affinché si possa ammirarlo ed usufruirne, dargli un senso. Di opposta natura rispetto all’eroe, perché permanente e costante nel tempo, è spesso lì da secoli.
L’omaggio e l’eroe alla fine tornano insieme, in una danza comune, si fondono nella moltitudine di scatti sovrapposti che sintetizzano tutto il lavoro fatto sul luogo delle riprese. le immagini, una sull’altra, enfatizzano l’intenzione comune dell’omaggio e dell’eroe di stare insieme, di onorare il regalo ricevuto dando scopo alla reciproca presenza. l’obiettivo finale, ambizioso, è di convogliare i due protagonisti in un unico elemento dinamico, dando loro forza e finalità, ritrovando il movimento che si era perso nelle singole immagini.
Le immagini, una sull’altra, enfatizzano l’intenzione comune dell’omaggio e dell’eroe di stare insieme, di onorare il regalo ricevuto dando scopo alla reciproca presenza.

Nata e cresciuta nella città eterna, ad eccezione di quattro anni passati a New York per favorire la crescita personale, Nelly attualmente vive a Roma. Inizia ad interessarsi in maniera costante alla fotografia, a scattare con regolarità e ad approfondirne le conoscenze nel 2013, ma è solo a fine 2019 che propone il suo lavoro al pubblico partecipando al “Wave market fair” a Roma.
Da autodidatta in ripresa, post produzione e stampa di fotografia digitale, usa frequentemente altre metodologie per fotografare sperimentando continuamente modalità diverse dalle regole canoniche. L’obiettivo finale è quello di provocare i limiti imposti dalla fotografia sull’incapacità di riprodurre il senso del movimento. La fotografia è un mezzo di comunicazione letargico e statico; lei utilizza spesso multiple esposizioni o altri sistemi di ripresa non convenzionali (quali l’uso di obiettivi basculanti o vintage e a fuoco manuale) per enfatizzare il movimento anziché documentare la nuda e cruda realtà.
Il suo obiettivo finale è portare l’osservatore lontano dalle difficoltà quotidiane, far si che lo stesso possa condurre il proprio pensiero distaccandosene temporaneamente. Avendo a disposizione solo una parte del messaggio, l’osservatore, per mezzo del suo vissuto, aspirazioni e immaginario ne completa e personalizza l’interpretazione; se questi si lascia andare all’istinto e alla sua voce interiore.

Instagram: https://www.instagram.com/nellyschneiderphotography/
Facebook: https://www.facebook.com/nellyschneiderphotography/
OTTO Rooms
Piazza Giuseppe Mazzini 27 – Piano 4 Scala A.
00195 Roma
Ecco il link: https://goo.gl/maps/AhST5w2Nkc52

OTTO Gallery si trova nel Quartiere Prati di Roma ed è collegata benissimo anche con i mezzi di trasporto:
Puoi dormire direttamente nella di OTTO Rooms! Per prenotare la tua camera da OTTO Rooms CLICCA SU QUESTO LINK.


Le campane hanno avuto nei secoli un funzione pubblica, civica e religiosa, trasmettendo messaggi e acquisendo un valore simbolico.
Le campane venivano e vengono tutt’ora usate anche nei rituali magici: per scacciare gli spiriti malevoli e allontanare i temporali o per attirare gli Angeli.
Oltre a scandire il trascorrere del tempo e costituire un richiamo liturgico, svolgono da sempre la funzione di comunicare al popolo situazioni di pericolo imminente, gioie, dolori e lutti.
Utilizzate nei rituali religiosi di Occidente e Oriente, con il loro suono, dolce e potente allo stesso tempo, attirano a sé gli uomini e segnano un sacro legame fra l’Uomo e il Divino.
In Italia sono poche le fonderie di campane rimaste ma è ad Agnone, piccolo borgo dell’Alto Molise, conosciuto anche come il “paese delle campane”, che nasce la voce degli Angeli.

Qui infatti si trova la più antica fonderia in Italia, la Pontificia Fonderia Marinelli, dove i segreti e le tecniche di questo antichissimo mestiere sono tramandati da padre in figlio. Una tradizione che perdura da oltre 1000 anni, oggi portata avanti dai fratelli Armando e Pasquale Marinelli.
In questa antica fonderia di famiglia si realizzano campane e sculture bronzee a mano utilizzando la tecnica della “cera persa” già conosciuta dai fonditori medievali e rinascimentali.
Le campane quindi non sono fatte in serie ma ogni pezzo viene realizzato a mano su commissione da chiese, governi, imprese e organizzazioni e le sue campane si possono trovare in tutto il mondo.
Molte delle campane realizzate dalla fonderia si trovano in Vaticano. La fonderia ha anche ottenuto il diritto e l’onore, conferitole da Papa Pio XI nel 1924, di effigiarsi dello Stemma Pontificio.

Fabbricare una campana è una vera opera d’arte e la sua realizzazione è una esperienza di notevole impatto emotivo.
Il materiale utilizzato è il bronzo, una lega di rame e stagno che nel caso delle opere artistiche della fonderia Marinelli è di qualità purissima. Per l’intero processo si va dai tre mesi per le campane più piccole fino a un anno per quelle più complesse.
Si parte dalla costruzione di una forma costituita dall’Anima, che corrisponde all’interno della campana e viene realizzata in mattoni, lasciando la parte interna cava e un foro nella parte alta e viene ricoperta da un primo strato argilla.

Si procede con la Falsa campana, ovvero l’anima viene ricoperta con ulteriori strati di argilla speciale, sino ad ottenere una superficie levigata. Questa avrà esattamente lo spessore voluto per la campana. Su questa vengono applicate le cere con le iscrizioni dedicatorie, le immagini ed i fregi artistici.
Infine si fora il Mantello applicando sulla falsa campana altri strati di argilla sino allo spessore desiderato.
La forma così completata si riscalda con la tecnica della “cera persa”, ovvero viene acceso il fuoco all’interno dell’anima per far sì che la cera si sciolga col calore lasciando impressa in negativo, all’interno del mantello, la composizione artistica.
A questo punto si solleva il mantello, si distrugge la falsa campana e lo si ricolloca sull’anima.
Il modello è ora interrato nel fosso di colata dove avviene la fusione a circa 1150°C. Il bronzo liquefatto viene versato nelle singole forme riempendo lo spazio libero creatosi tra l’Anima e il Mantello.

La fusione è un processo che non può permettersi il minimo errore pena la cattiva riuscita del lavoro. Ha sempre una componente quasi mistica e delicata e come tale genera apprensione e va benedetta. Spesso questo viene fatto alla presenza di un sacerdote che accompagna con litanie e preghiere il culmine di tale fase produttiva.
Solo dopo svariato tempo si potranno rompere le forme per vedere il risultato. Il metallo deve raffreddare poco a poco e senza sbalzi di temperatura. Dal suo raffreddamento può cambiare la “voce” della campana.
Ma la campana non è ancora terminata. Appena liberata del suo involucro, deve essere pulita: i bassorilievi vanno puliti con spazzole d’acciaio e poi a colpi di scalpello e di lima.
Si tratta di un lungo e paziente lavoro affidato alle mani esperte di maestri artigiani. L’interno deve alla fine essere riguardato e vi si deve attaccare il battaglio.
Per constatare inoltre che la campana sia perfettamente funzionante e non incrinata, vengono convocati degli esperti che con un diapason verificano il livello di tonalità della campana. Visitare la fonderia è un’esperienza unica.

Foto e parole di Lia Dondini Taddei
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Viaggio spesso in Germania e mi piace perdermi nelle strade andando incontro alla gente.

In questo Paese le città e le persone hanno la fama di essere rigorose e grigie, ma all’osservazione dei fatti, mi sembra davvero uno stereotipo non sostenibile.

In realtà c’è tanto colore in tutto e in tutti e in questo lavoro mi è piaciuto riscoprirlo per esorcizzare in questo momento storico il vero grigio che c’è nei nostri cuori.

La pandemia, le guerre, i disastri ecologici chiudono i nostri animi in scure prigioni e forse i colori ci aiuteranno a trovare nuove risorse impensate nelle differenze,

nell’amicizia, nelle reti costruttive positive, perché possiamo ancora sperare in un futuro multicolor, multietnico e vivibile.

Foto e testo di Francesca Romana Semerano
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Si definiscono «minatori freelance». Vivono con pochi ricavi dopo aver rivoltato, setacciato, e scavato nella terra rossa cambogiana alla ricerca di zirconi azzurri, pietre preziose destinate al mercato locale e internazionale.

La regione di Ratanakiri, nel nord est della Cambogia, è conosciuta per le gemme che la sua terra rossa nasconde nel ventre. Nel villaggio di Bar Kaev, abbandonata la strada maestra che porta verso il Vietnam, ci si addentra in una superficie che una volta ospitava la foresta. Lungo il sentiero che la attraversa compaiono qua e là decine di profondi buchi neri.

Ogni buco è una cicatrice lasciata da una miniera di zirconi abbandonata: quelle in funzione si riconoscono subito dal telo teso che le ombreggia. Non siamo in una grande miniera a cielo aperto dove migliaia di uomini formiche lavorano come formiche per estrarre le pietre preziose; qui le miniere sono a conduzione familiare, aperture larghe a sufficienza per farci infilare un uomo e profonde più di dieci metri.

Non ci sono scale per salire e scendere laggiù. Si sfrutta solo la forza delle braccia e delle gambe per entrare e uscire dalla pancia della terra. La squadra è composta da due persone, che ciclicamente si alternano. Uno scava e l’altro si mette all’argano mentre l’altro in fondo al pozzo, lavorando sempre in ginocchio riempie i secchi e li aggancia uno dopo l’altro alla corda che li porterà in superficie.

Metà della giornata la si trascorre in superficie e l’altra metà nel sottosuolo, queste sono le proporzioni, la fatica è equivalente e condivisa a metà, come diviso è il ricavo frutto del sudore di giornata.

La speranza di buona sorte nutre la smania del cercatore ma la perseveranza appaga la necessità di garantire alle proprie famiglie che vivono in capanne vicino alla miniera, un guadagno medio giornaliero decente di circa 15 dollari.

Foto e testo di Lello Fargione
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.

Un lungo viaggio in famiglia negli Usa, dopo aver trascorso l’anno prima in Vietnam, in compagnia di moglie e figli.

Scettico della meta americana, ma pressato da molti (papà ce lo devi, non possiamo solo fare trekking e girare per villaggi sperduti, vogliamo andare negli stati uniti) mi sono sentito in dovere di proporre alternativa ai miei amati viaggi.

In preda a due adolescenti curiosi ed euforici di vedere le grandi metropoli americane, eccoci a New York City. Da lì, con i famosi megabus alla volta di Philly e Washington per poi dirigerci con un auto a nolo x miglia e miglia attraverso New Jersey, Delaware, Virginia, North Carolina e South Carolina, alla scoperta della middle america on holiday.

Pick up stracarichi, con al seguito barche, grill….insomma, mi sono dovuto ricredere.
Una Vacanza all’insegna del Big is Better…Risvegli felici, seduto fuori da un motel ad osservare l’americano in vacanza. Fantastico!

Scrivi un commento all’Autore usando il form qui in basso. Non è richiesta alcuna registrazione, noi riceveremo il tuo commento e lo pubblicheremo e quando riceverai delle risposte al tuo messaggio verrai avvisato dal nostro sistema se lo vorrai.
Questa storia ha partecipato a Travel Tales Award 2022. Clicca sul link per partecipare anche tu alla nuova edizione.


La voglia di fotografare nasce spontaneamente nella prima infanzia vissuta tra le Rhodope Mountains. Vado per la mia strada, cercando di trasformare un frammento di tempo in eternità attraverso le mie fotografie.
Negli ultimi dodici anni ho viaggiato molto in giro per le Rhodope Mountains, nella mia Bulgaria. Una montagna di una bellezza unica, ricca di passato e piena di misticismo e misteri. Le Rhodope Mountains sono vaste e non basterebbe una vita per vedere tutto quello che offrono.

Qui ho incontrato persone quasi centenarie, che portano dentro di sé un’intera epoca, un tesoro prezioso. In questo lavoro ho voluto raccontare momenti di vita della gente che vive nei piccoli villaggi di queste montagne.

Ho raccontato di Emine, nel Villaggio di Krestava, che tratta la sua mucca come un’amica portandola ogni mattina al più vicino abbeveratoio. Del vecchio pastore Ali, nel Villaggio di Smolevo, che da giovane allevava milleduecento pecore ed ora ne ha solo una ventina di cui si prende cura.

Alla fine di maggio, nella parte occidentale dei Monti Rodopi, inizia la tosatura delle pecore ed Ali è così abile col suo vecchio paio di forbici che sono riuscito a malapena a scattagli una foto. Altro aspetto importante nel raccontare la quotidianità di questi villaggi è l’importante attività legata alla raccolta ed essiccazione del tabacco, utilizzato poi per fare le sigarette e guadagnare qualcosa da vivere, come Abidim, del mio amato villaggio di Ribnovo, che tira giù il tabacco essiccato per fare spazio al nuovo.

Infine non possono mancare le persone dei villaggi durante vari tipi di eventi, come i festeggiamenti per la tradizionale “Syunet” (circoncisione dei ragazzi) sempre nel piccolo villaggio di Ribnovo, o i matrimoni nel centro del paese in cui la gente esce per divertirsi e curiosare.

Sempre qui si svolgono le partite di “grease wrestling” (sport tradizionale turco). I concorrenti si spalmano olio sul corpo per rendere i combattimenti più difficili e interessanti. I vincitori delle categorie leggere ricevono come premio un percorso con un coach, e nelle categorie pesanti il migliore vince un vitello.
Foto e parole di Miroslav Mominski
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

 Poche zone sulla Terra riuniscono una così straordinaria quantità di motivi d’interesse. È una regione di difficile accesso, dal clima estremo, dove si raggiungono le temperature più alte del pianeta. Per secoli l’unico collegamento con il resto del mondo è avvenuto attraverso le carovane di dromedari che trasportavano blocchi di sale sull’altopiano etiopico. Ancora fanno da cornice ad una regione dalle mille sfumature. Nel percorrere il tragitto delle carovane attraversando Il Fiume Saba ho voluto mettere in evidenza le sfumature e le forti emozioni che hanno lasciato in me una traccia indelebile.
Poche zone sulla Terra riuniscono una così straordinaria quantità di motivi d’interesse. È una regione di difficile accesso, dal clima estremo, dove si raggiungono le temperature più alte del pianeta. Per secoli l’unico collegamento con il resto del mondo è avvenuto attraverso le carovane di dromedari che trasportavano blocchi di sale sull’altopiano etiopico. Ancora fanno da cornice ad una regione dalle mille sfumature. Nel percorrere il tragitto delle carovane attraversando Il Fiume Saba ho voluto mettere in evidenza le sfumature e le forti emozioni che hanno lasciato in me una traccia indelebile.

Uomini che alle prime luci del mattino sono pronti ad accingere il loro cammino e nelle luci del giorno la loro tenacia, allegria e socievolezza scalpisce la loro fatica. Nel caldo riposo del sole sfrecciano come lance con le lunghe file di Dromedari al loro seguito per proteggersi dal caldo torrido del giorno.

Uomini dalla pelle dura ma con sguardi che lasciano trasparire la loro fragile timidezza, celata dalla forza che imprimono sui sassi di sale della Piana del Sale e nei passi lenti ma ritmati del loro cammino.

Uomini di etnie diverse ( Musulmani e cristiani) lavorano insieme, condividono abilità e capacità. Hanno bisogno gli uni degli altri per vivere e per conservare un’identità e una tradizione che resiste da millenni. In un paese dove niente fa pensare a un equilibrio, musulmani e cristiani riescono a convivere con un obiettivo comune: il commercio del sale, che da tempi immemorabili fa vivere migliaia di famiglie.

” Le carovane di Sale, una vita in cammino, di sudore, di sete e stanchezza. A volte la sosta in un oasi. Le carovane restano un racconto di silenzio e di luce argentata” ( cit. tratta dal libro” Gente in Cammino” di Malika Mokeddem ).

Foto e parole di Anna Rita Carrisi
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Per anni mi sono detto che avrei dovuto visitare Cuba prima della dipartita di Fidel Castro pensando che alla sua morte l’isola si sarebbe velocemente trasformata.

Il caso ha voluto che fossi a Cuba, assieme a tre amici fotografi, proprio il giorno della sua morte, il 25 novembre 2016 e per i successivi 9 giorni di lutto nazionale dichiarati dal fratello e capo del governo cubano, Raul Castro.

In quei giorni abbiamo attraversato tutta l’isola, dall’Avana a Santiago, percorrendo le stesse strade del corteo funebre, incontrando e parlando con decine e decine di donne e uomini cubani. Abbiamo visto una Cuba compatta nell’unità nazionale e penso sinceramente addolorata per la mancanza improvvisa del loro “Comandante”, come tutti lo chiamavano, uniti nello slogan “Yo soy Fidel”.

Alla domanda: “Ed ora dove andrà Cuba?” tutti, con varie sfumature, ma con grande determinazione, hanno risposto che la direzione era già stata segnata dal Comandante e che avevano intenzione di seguirla adattandola ai giorni nostri.

So perfettamente che a Cuba c’è un ferreo regime, ma penso che la maggior parte fosse sincera, unita da una orgogliosa identità nazionale che il lutto rendeva, se possibile, più forte.

Ho avuto la sensazione che per tanti fosse come la perdita di un padre, molti hanno anche aggiunto: “Nel bene e nel male”, parlando della guida del Comandante, “Ha fatto il meglio che poteva per Cuba”.
La storia giudicherà.

Foto e parole di Francesco Munaro
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Nell’agosto del 2018 parto alla scoperta della Puna, il vasto altopiano desertico dell’Argentina nord-occidentale, che si estende in mezzo alle due cordigliere andine, come lo spazio compreso tra i due lembi scostati di una cerniera lampo aperta malamente. Ci arrivo da Salta (a due ore di volo da Buenos Aires) dapprima percorrendo in 4×4 una pianura dove si alternano vigneti e cactus a perdita d’occhio.

Poi salendo, per oltrepassare il primo lembo della cerniera montuosa, tra cui sono adagiate morbide dune di sabbia rosata finissima punteggiate di cespugli dorati. E finalmente, si dispiega davanti ai miei occhi la vuota vastità della Puna di cui non si coglie la fine.
Capisco subito di essere molto in alto, oltre i 2000 metri, perché l’aria ha il sapore e l’odore della purezza, e il respiro ti brucia in gola.
I colori predominanti sono il giallo della secca e rara vegetazione bassa, il rosa violaceo delle alture striate di neve, il blu intenso del cielo e il nero della cenere sparata nei secoli dai numerosi coni vulcanici.
Non si incontra nessuno lungo i lunghi rettilinei di terra battuta che sembrano tracciati con il righello.

L’autista/guida dice che qui vengono pochissimi turisti, e neanche gli Argentini conoscono la Puna. Di tanto in tanto si incrociano i binari di una ferrovia ancora usata per trasportare sale e minerali tra Argentina e Cile. A Tolar Grande (m. 3508), un villaggio in mezzo al nulla, c’è una minuscola stazione dove i camion caricano e scaricano i vagoni.

E’ qui che finalmente incontro i pochi abitanti della Puna. Si radunano alla sera a mangiare e bere nell’unica locanda del paese, mantenendo indosso le giacche a vento perché anche all’interno il freddo è davvero tosto, e la stufa a legna proprio non ce la fa a scaldare.
E, usciti fuori, li ritrovo rannicchiati sulle panche della sala del municipio, l’unico posto dove prende il cellulare, o rintanati nelle loro jeep parcheggiate lì intorno con i motori accesi per ripararsi dal gelo.

Il primo agosto qui si celebra il rito di ringraziamento alla Pachamama (Madre Terra), una tradizione antichissima delle popolazioni andine. Per caso mi accorgo di un gruppo radunato attorno a una buca scavata nel terreno. Dopo aver recitato in raccoglimento la loro invocazione vi seppelliscono i loro doni alla Madre Terra: alcolici, frutta, ortaggi, riso, sigarette e foglie di coca, di cui hanno tutti le guance gonfie. Si passano l’un l’altro una ciotola contenente un miscuglio di tutte le bevande che hanno radunato, alcoliche e non.
Anch’io ne provo un sorso, per non offenderli. Il tono delle voci è sommesso per rispettare la sacralità del momento. Il silenzio è il suono tipico della Puna. Ancora adesso, a distanza di anni, se chiudo gli occhi lo rivedo quel cielo blu, avverto il vuoto silenzio e respiro la purezza di quell’aria.

Foto e parole di Marco Parenti
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/


Genna è il nome che viene dato dai cristiani copti di Etiopia al Natale. Questo viene celebrato il 7 gennaio, dato che in Etiopia viene ancora seguito l’antico calendario giuliano.
I festeggiamenti del Natale Copto si svolgono nella città santa di Lalibela che si trova nel nord dell’Etiopia ad una altezza di ca. 2500 metri sul livello del mare. La città è famosa per le sue chiese rupestri scavate nella roccia, che nel 1978 sono state dichiarate patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Lalibela ha ventimila abitanti che diventano circa duecentomila a inizio gennaio. In questo periodo migliaia di fedeli da tutto il paese percorrendo piste polverose la raggiungono camminando per giorni o anche per settimane.
I festeggiamenti del Genna iniziano nel pomeriggio del 6 gennaio e si protraggono tutta la notte e per tutto il giorno di Natale.
Abbiamo passato la notte della vigilia all’interno della chiesa rupestre Bet Maryam insieme ai fedeli copti. Si è trattata di una esperienza eccezionale e indimenticabile.

Attraverso un angusto passaggio scavato nella roccia, si raggiunge lo spazio posto intorno alla Chiesa dove moltissime persone, in gran parte vestite di bianco, sono ammassate dappertutto.
Vista la calca non è possibile muoversi liberamente. Ci si trova come immersi tra i fedeli e può succedere di colpire o anche di calpestare qualcuno nel tentativo di spostarsi senza, peraltro, suscitare lamentele.

Sembra di essere in un sogno: il fossato intorno alla chiesa è popolato da una moltitudine di fedeli che in piedi, seduti o sdraiati per terra vegliano per tutta la notte alla luce di centinaia di candele. Il suono delle nenie e dei tamburi è continuo; alcuni dei fedeli pregano o leggono testi sacri, altri cantano o danzano, altri si appisolano dove capita, tutti aspettano la cerimonia del mattino quando i sacerdoti vestiti con i loro tipici costumi sgargianti formano un corteo e raggiungono la chiesa pe celebrare la messa.

Colpiscono la profonda devozione e la grande umanità dei fedeli che dimostrano una inaspettata disponibilità. Lo straniero viene accettato senza indecisione e con grande tolleranza. Non si può non essere rapiti da questa magica atmosfera e rimarrà probabilmente per sempre il desiderio di ritornare al Genna.

Foto e parole di Stefano Bianchi
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/


Viaggiare. È uno stato dell’essere, oltre il movimento oggettivo del corpo.
Testimone, vestito d’invisibilità per non interferire, fotografo con l’intento di cogliere quel momento, movimento, ripetuto all’infinito eppure diverso ogni volta. La luce colpisce gli oggetti: contenuti e forme danno significato ai semplici e rituali gesti, definiti, irripetibili per senso e appartenenza: la foto insegue la trama e ne cerca la sintesi.

Alle prime luci dell’alba giovani Dei tritano ghiaccio freddo come polvere di stelle. L’eco lontano millenni che affiora continuo alle labbra: tu conosci la mia pena, aiutami, tu che puoi tutto. Un’ombra su un muro ocra o turchese: di chi sei?

Un sorriso fugge inconsapevole sotto il peso (della vita), e dei mattoni. Il vento che muove lievi teli, ordinando il colore di pieno e vuoto: dov’è il colore del cielo, dove il tessuto?

O lo scambio di parole fuori un bar, uguali, negli innumerevoli idiomi dei diversi confini. Ogni giorno sulla Terra accade: la magia dell’essere qui. Guardarsi intorno, simili ed estranei: scegliere cosa prendere, cosa portare con sé, perché da quello verremo cambiati. Le immagini precipitano nell’anima e muteranno il modo di percepire, d’intendere, la relazione con l’altro. Uno specchio dell’esistenza: potresti essere tu, potrei essere io..

Foto di Roberto Malagoli e parole di Lisanna Pinna
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/


Dubai è una nuova città, una città che vuole essere moderna, ad iniziare dalla sua urbanistica e dalle sue architetture.
E’ un grande centro urbano che oppone la verticalità dei grattacieli all’orizzonte del deserto; la modernità svettante verso l’alto alla tradizione islamica.

“E’ delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura.

Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche il filo del loro discorso è segreto, le loro regole sono assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra.”
Le città invisibili – Italo Calvino
Foto e parole di Sandro Lombardo
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Sui banchi di scuola avevo imparato che nel lontano continente asiatico esisteva un immenso lago salato, che noi chiamiamo lago di Aral, ma che nella lingua locale è chiamato « mare di sole ».

Il suo bacino acquifero era grande tanto quanto la superficie dell’intera Svizzera. I pescherecci solcavano le sue acque, mentre nei porti ferveva l’attività dell’uomo.
Così, un bel giorno di primavera dell’anno 2018, mi ritrovai a 4’000 km da casa, nel Karakalpakstan, sulle rive di quello che, nei miei libri di scuola, veniva definito il quarto più grande lago al mondo.
Mi ritrovai sulle sponde di un deserto dove lo sguardo si perdeva nell’infinito alla ricerca di un orizzonte incerto.
Il lago del mio vecchio atlante di scuola era letteralmente evaporato.

Incontrai un ragazzino sveglio, che mi disse che lui il mare non l’aveva mai visto, ma a scuola gli avevano insegnato che, da qualche parte, il mare esisteva ancora e lui un giorno ci sarebbe andato. Fu così che partii in una sorta di pellegrinaggio alla ricerca del mare perduto.

Lungo il tragitto attraversai quello che era stato un borgo di pescatori, un villaggio oramai dimenticato dal resto del mondo e dalle mappe.
Le tracce di una qualche forma di sopravvivenza umana erano tristemente visibili.

Fu lì, che mi apparve una scuola frequentata da giovani, vestiti con cura, spensierati e divertiti dalla mia inattesa quanto improbabile presenza. Ritrovai i simboli di una mia quotidiana « normalità ». Vedevo una nuova generazione di giovani, simbolo di rinascita e di speranza, proiettata verso un futuro sicuramente diverso da quello dei loro padri e dei loro nonni che furono pescatori. Una nuova generazione che apprende dell’esistenza del mare dai libri di storia anziché dai libri di geografia.

Dopo svariate ore di fuoristrada, attraverso quello che fu il fondale del lago di Aral, i mi ritrovai davanti al « mare di sole ».
Una fangosa reliquia, che appartiene oramai ai libri di storia.

Foto e parole di Francesco Dolfi
https://www.facebook.com/francesco.dolfi.3
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/
Se vuoi partire con noi per l’Uzbekistan clicca su QUESTO LINK.

Pur ritenendomi una persona pacifica e contraria alla violenza in ogni sua forma, devo dire che ho sempre trovato nobile uno sport duro come la boxe. Questo porta gli atleti a contendersi gli esiti di un incontro con sonori pugni ben assestati sferzati all’avversario.
Da bambino ricordo le estati calde passate davanti alla televisione a vedere le Olimpiadi. Non c’erano condizionatori in casa, mia nonna che dormiva e io perfettamente attrezzato in bermuda e canotta come il miglior Fantozzi cercavo refrigerio rotolandomi sul pavimento di marmo in quei lunghi torridi pomeriggi nella città deserta il cui silenzio era rotto dall’assordante frinire delle cicale. E a quell’ora la televisione (c’era solo la RAI) passava solo la boxe, ore e ore di incontri, pugni e sudore.

Questa è stata quindi la mia iniziazione alla boxe: fu un pò una forzatura alla quale non potevo sottrarmi… Erano le Olimpiadi di Mosca 1980.
Fin da quella età mi chiedevo perché ci fossero persone disposte a prendere un sacco di pugni per il piacere di darne ad un altro che fondamentalmente non gli aveva fatto nulla di male se non aver scelto di fare lo stesso sport e di trovarsi per un caso del destino ad essere estratti come avversari.
Mi chiedevo insomma se fosse giusto tutto quello, se ne valesse la pena. Mi domandavo quale fosse il valore del denaro e se i soldi fossero una motivazione abbastanza valida per non scegliere un altro sport in cui non ci si facesse così male.
Tra una riflessione e l’altra sono diventato grande e ho iniziato a dare qualche risposta, o almeno qualche giustificazione, a quelle mie domande. Mi dicevo che già esisteva nell’antica Grecia come sport olimpico e che è meglio quello che delinquere in strada e… bla bla bla…
Sta di fatto che nella vita certi cerchi devono chiudersi, senti il bisogno di toccare con mano il fuoco per vedere se brucia, senti il bisogno di avvicinarti al drago per sfidarlo e vedere se è così cattivo.

Ho scelto quindi di avvicinarmi a chi fa questo sport e da bravo viaggiatore e fotografo non l’ho fatto alla palestra dietro casa, giusto per capire o per provare, ma sono andato a cercarmi le frange più estreme di questo sport. Sono andato fino in Thailandia dove è lo sport nazionale portato alla sua massima espressione.
Lì si chiama Muay Thai ed è la boxe thailandese tradizionale che non conosce esclusione di colpi: sono ammessi pugni, ginocchiate, gomitate e persino il temutissimo calcio al collo che può essere dato in modo tanto violento quanto coreografico addirittura facendo una piroetta che ne aumenta ancora di più la velocità e la forza di impatto.

Prima di partire mi misi a cercare una palestra in cui andare a fotografare gli allenamenti: volevo capire perchè questo sport fosse tanto sentito a Bangkok.
Volevo capire anche perchè così tante minute ragazzine di 18-20 anni con lo smalto alle mani e ai piedi andassero a vivere mantenendosi estremamente femminili in uno sport tanto duro che pensavo fosse quasi esclusivamente per veri uomini. Pregiudizi che volevo scardinare in me e per i quali ero disposto a rimettere in gioco tutte le mie convinzioni.
La prima palestra era di fatto una semplice tettoia, e ho capito subito perché ci andavano le ragazze carine. La palestra era gestita da due fratelli ormai in età avanzata che l’avevano aperta per insegnare agli altri la difficile arte del combattimento.
I due fratelli su un tappeto antiscivolo si riempiono di protezioni la testa, le mani le braccia e le gambe e di fatto diventavano due bersagli sui quali far sfogare la rabbia delle giovani ragazzine. Queste li riempirono di sonore raffiche velocissime di calci e pugni che senza le protezioni farebbero comunque male anche agli esperti maestri.
Di fatto un posto dove fare un pò di sport dopo le lezioni all’Università divertendosi a dare botte sapendo comunque di non prenderne. Gli allenamenti di boxe thailandese si svolgevano con il maestro che dava i comandi per farsi colpire dagli allievi e dava il ritmo per farlo, con brevi parole gli diceva se tirare un pugno sul guantone o un calcio che lui sarà pronto a parare per proteggersi.
Da quel posto gli unici campioni che ne sarebbero usciti erano i maestri la sera quando tornavano a casa dopo l’orario di lavoro.

Non ne rimasi deluso, ma al contrario fui soddisfatto di quella visione del mondo che non conoscevo. Di certo era una palestra in cui fare sport anche impegnativo, ma quello era un posto alla moda, non una fucina di atleti come quella che volevo io.
Capii però il perché questo sport sia tanto diffuso in Thailandia: perché in quel modo lo può fare davvero chiunque, è questo il motivo del suo successo.
Eppure mentre ero lì c’era una sensazione che non riuscivo a spiegarmi. Mi mancava qualcosa ma non capivo cosa fosse, me ne sono reso conto solo dopo essere rientrato in Italia riguardando le fotografie con una certa attenzione…Era una sensazione che lì sul momento non riuscivo a spiegarmi, qualcosa mi sfuggiva…
Ecco cosa era: mancava il ring!!! Mica una cosa secondaria: non ce ne era traccia, e quella fu la prova: era un posto per divertirsi e non un posto in cui combattere. La boxe è uno sport nobile, non dimentichiamocelo.
Il giorno dopo andai a cercare emozioni nuove in un’altra palestra di boxe thailandese. Anche qui persone di entrambi i sessi e con una età più allargata: c’era anche gente decisamente più grande di età. Qui finalmente c’era un vero ring!!!

Un grande spazio in cemento armato, decisamente più spartano nel quale finalmente sentivo l’odore acido delle persone che si mescolava con quello della pelle dei guantoni creando quel mix olfattivo deciso, forte, sofferto.
Anche qui mi avvicinai ad una ragazza molto carina, tonica, scattante, con dei guantoni più grandi di lei e le chiesi chi le avesse fatto quell’enorme livido grande come tutta la coscia destra.
Lei si girò verso un’altra ragazza e con un sorriso vero e sincero mi disse: “E’ stata la mia amica: è stata bravissima, molto più veloce di me, mi ha dato un calcio che non sono riuscita ad evitare. Ma la prossima volta sarò più veloce io”.
Non c’era vendetta né risentimento nelle sue parole. Ho visto il sorriso di chi sa di essersi difeso con onore dagli attacchi di un avversario più forte.
Gli allenamenti qui erano veramente seri: ci si allenava a colpire un sacco pieno di sabbia senza spaccarsi una mano, si facevano migliaia di salti con la corda ad un ritmo fittissimo. Qui si sollevavano manubri e bilancieri e non si colpiva il maestro per gioco o per sfogarsi.
Qui impari non solo a colpire ma anche a difenderti perché nella vita servono entrambe le cose.
Il mio viaggio qui iniziava a prendere un senso… Qui vedevo ciò che avrei voluto vedere. Quanto coraggio, mi chiedevo, quanto coraggio ci vuole a passare dall’allenamento al ring? Quanta forza e concentrazione ci vuole a liberarsi della sicurezza mentale che quelle piccole protezioni per le braccia e la testa danno a chi si allena?
E finalmente dopo le due palestre all’incontro ci sono andato davvero. Munito di un permesso speciale per entrare e uscire liberamente dagli spogliatoi. Avrei potuto assistere al sacro rituale preparatorio degli atleti prima di andare a combattere.
E nel fetido spogliatoio del palazzetto dello sport, tutto il mio viaggio ha trovato il senso che cercavo. Ho provato le emozioni più forti proprio in quel silenzio che precede l’incontro. Ragazzini, giovanissimi, muscolosi e definiti, agili e scattanti come molle, fisici asciutti ed esili, 15-20 anni…
Distesi su dei tavolacci lerci ci sono gli atleti completamente glabri che vengono unti e massaggiati dai loro preparatori prima del match. La cosa che mi ha colpito subito era il fatto che lo spogliatoio era lo stesso contemporaneamente per tutti gli atleti.
Non c’erano delle stanzette, ma un unico stanzone scarsamente illuminato dalla luce incerta di un neon schifoso coperto di ragnatele. Erano lì tutti insieme: pugili e allenatori… I secondi, il medico, gli amici dei ragazzi e tutto si svolgeva in un apparente clima di amicizia prima di darsele di santa ragione.

Mi piaceva studiare i loro sguardi persi nel vuoto, vedere nei loro occhi la concentrazione che precede i grandi momenti. Gli allenatori con una serie di gesti ripetuti e abituali, dosati e precisi andavano a preparare le mani dei loro campioni. Le riempivano di garze, cerotti e infilavano loro i guantoni che avrebbero dato l’ultimo dettaglio alla vestizione.
Negli spogliatoi la tensione era fortissima, si sentiva tutta l’emozione di quegli ultimi istanti che precedono la gara. Gli atleti sapevano di stare bene ma anche che da lì a poco, comunque vadano le cose, la lotta sarebbe stata durissima.
Qualcuno restava disteso sul tavolaccio a mandare un whatsapp all’esterno. Altri li vedevo tirare pugni e calci in aria in una specie di disimpegno prima del corridoio che porta sul ring. Nessuno sembrava accorgersi di me e della mia fotocamera. Tutti erano, giustamente, impegnati in ben altro tipo di ragionamenti tanto che io passavo del tutto inosservato.
Nell’aria adesso non c’era odore di sudore nè si sentiva quello dello scantinato in cui ci trovavamo. L’aria era invece piena di odore di olio canforato: un odore fresco e piacevole, stridente e inaspettato in quel luogo malsano in cui mi trovavo a vivere un’emozione fortissima condividendola con degli sconosciuti.
Ed ecco il grande momento: i combattenti vengono chiamati sul ring. Camminando all’indietro precedevo i contendenti vestiti con il loro tipico mantellino per fotografarli mentre si dirigevano verso il quadrato in cui il pubblico li aspettava. Ero emozionato più di loro: aspettavo quel momento da 40 anni. Stavo per chiudere il mio cerchio emozionale chiudendo la boxe tra le esperienze che ho vissuto da vicino seppur non in prima persona.
GONG!!!! L’incontro abbia inizio: vinca il migliore.
Foto e parole di Roberto Gabriele



Nel cuore della Basilicata esiste e resiste ancora un mondo lontano dai frenetici ritmi del modello economico che il turismo di massa ha ormai imposto da Matera fino alla costa pugliese.

La civiltà contadina, portata alla luce da Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato ad Eboli, qui esiste ancora. La si trova nel fragile equilibrio di una terra soggetta a siccità ed erosione.

E’ presente, seppur in forma ammodernata ed ancora saldamente legata ai vincoli e alla struttura del territorio, aspro e fragile.
Questo è delizia per gli occhi del visitatore occasionale ma anche condanna per chi lo abita da sempre.

E’ un mondo sospeso tra antiche tradizioni e dinamiche moderne, in cui il viaggiatore è ancora un ospite ben accolto e sinceramente gradito.

La terra si consuma, cede, scivola a valle trascinando pian piano i paesi, che giorno dopo giorno perdono pezzi fino a scomparire: Craco è l’esempio più famoso ma non certo un caso isolato.
Non è raro imbattersi in borghi fantasma disabitati ed abbandonati, testimonianze di un mondo non del tutto passato.

Fede, tradizioni e rispetto sono i cardini attorno cui si sviluppa la vita di chi, nonostante tutto, mantiene vivo questo territorio di rara bellezza, in cui il viaggiatore può ancora trovare la sua dimensione più vera.

Foto e parole di Ugo Baldassarre
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/


Sono rimasti in pochi i pescatori di “moeche” (granchi) e tutti concentrati nella laguna di Venezia. Il loro è un lavoro duro e impegnativo che si tramanda di padre in figlio.

Ci si sveglia molto presto, prima dell’alba, si inizia poi a navigare freneticamente in laguna per spostare i pali delle le reti o per tirarle su e controllare il bottino…granchi, crostacei e pesci grossi vengono tenuti, il resto torna in mare.

Durante un viaggio a Venezia, ho avuto modo di vedere all’opera questi pescatori.
Sono rimasto colpito dal contrasto tra questa frenesia nei loro spostamenti e la calma placida che trasmette il paesaggio circostante.

Questo contrasto è ancor più percepibile nei momenti di pausa lavorativa dei pescatori e che ho voluto rappresentare negli scatti che presento.

Foto e parole di Roberto Moreschi
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Viaggio fotografico sul Delta del Po 2021

L’Universo Elegante descritto da Brian Green con la Teoria delle Stringhe. Lo scontro secolare tra le leggi del grande (la relatività generale) e le leggi del piccolo (la meccanica dei quanti) viene superato a vantaggio di una superiore unità, basata sull’affermazione che tutti gli eventi dell’universo nascono da un’unica entità: microscopici cicli di energia nascosti nel cuore della materia.

Cuore e materia, corpo e anima.
Un luogo-non luogo con passato e futuro senza presente.
Dove non esistono confini tra SOGNI e illusioni,
Cielo e mare, mare e fiume, acqua e terra.

Dove si confondono uomini e animali, pesci e uccelli (“qui i pesci nuotano più in alto del volo degli uccelli”),
Dove si fondono storie e leggende, metafisica ed immanenza.

Dove esistono i vongolari ed i “vongoladri”, ed insieme giocano a carte al bar.
Dove la Romea sostituisce la Route 66 nell’immaginario dei popoli di destra e di sinistra (di sponda).

Dove i confini, se esistono, si intrecciano e si confondono, nascono, crescono e spariscono.
Foto e parole di Claudio Varaldi
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/
Se vuoi partire con noi per il Delta del Po clicca su QUESTO LINK.

Viaggio in Uzbekistan, durante il Navruz, la festa della primavera.

Tutto il paese, proprio lungo la mitica Ruta della Seta, è da raccontare perché è bellissimo. Ma mi fermeró soltanto all’esperienza eccezionale che ho vissuto quando ho assistito, vicino a Samarcanda, alla celebrazione del Kupkari, un antico gioco di cavalli tradizionale dei nomadi dell’Asia Centrale. Un bambino era stato circonciso e suo nonno aveva organizzato la festa in suo onore.
“Kupkari” significa “prendere la capra”. L’obiettivo del gioco è prendere la carcassa di una capra e muoversi in qualsiasi direzione fino ad allontanarsi dagli altri giocatori e portarla al posto indicato dalle regole del gioco.

Quando siamo arrivati sul posto centinaia di cavalieri con i loro cavalli si stavano preparando per la festa. Una moltitudine di uomini, bambini, cavalli, auto, furgoni, si riunivano in una mattina nuvolosa, povera di colori. Nessuna donna, nessuna bambina, solo le cinque donne del nostro gruppo di turisti.

Ci siamo sentiti trasportati in un’epoca passata, come in un film storico. Quei cavalieri con i loro vestiti tradizionali, montati sui loro cavalli ornati di attrezzi colorati…

Noi eravamo stupiti da quello che avevamo davanti, ma loro non lo erano meno. Chi guardava chi?
La guida ci ha detto che forse non avevano mai visto una donna occidentale lì, ad una festa per uomini. La polizia ci chiede di andarcene, troppi uomini, alcuni ubriachi, non era sicuro. Ci allontaniamo dallo sciame di uomini e ci mettiamo in un posto più lontano da dove guardare la festa.

Ben presto si sparse però la voce che c’erano dei fotografi stranieri sul posto. Credo che fossero curiosi quanto noi e non smisero di avvicinarsi al nostro gruppo, amabili ci sorridevano e ci salutavano con la mano sul cuore.
Un vecchio chiese alla nostra guida: Di dove sono? – Dall’Italia, rispose Bek, la nostra guida.- Dov’è, è oltre Mosca? Chiede il vecchio uzbeko con la sua innocenza.

Gli uzbeki ci dimostrarono la loro generosità quando i cavalieri fecero più d’una corsa verso di noi per mostrarci da vicino il gioco, tanto che la faccia del cavallo era proprio davanti alla nostra!
Gli spettatori, a volte estranei al gioco, facevano battute, mangiavano semi di girasole, bevevano. I cavalieri con la capra, una corsa di qua, una corsa di là, finirono esausti, pieni di sudore e polvere. Dopo diverse ore, finito il gioco, tornarono alle loro case, di nuovo a piedi, con i loro cavalli o nelle loro vecchie auto piene di gente.

Li abbiamo salutati anche noi con le nostre mani sui cuori. Loro ci hanno dedicato sorrisi e gesti di rispetto. Indimenticabile.
Foto e parole di Carmen Garcìa
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

La penisola di Yamal, in Siberia è uno dei luoghi più inospitali e desolati della terra. Ricoperto dal ghiaccio per molti mesi all’anno, è abitato da un silenzio surreale rotto soltanto dai forti venti. Il sole rimane basso vicino all’orizzonte per poche ore al giorno avvolgendo tutto con una magica e bellissima luce crepuscolare dalle sfumature delicate color pastello.

Lo sguardo volto all’infinito, a volte, non percepisce il confine fra il cielo e la terra. E’ confuso dai cristalli di ghiaccio che vengono sollevati dal vento. Durante le gelide notti la volta celeste è di una straordinaria bellezza cosparsa da migliaia di stelle. Se si è fortunati si può assistere ad uno degli spettacoli più belli che la natura possa offrire, l’aurora boreale.

La mente si perde come in una favola, come se si venisse catapultati in un mondo primordiale e surreale in cui sembra che il tempo si sia fermato e che solamente la morsa del freddo riesce a riportare alla realtà.

Anche se risulta difficile pensarlo, in questo aspro ambiente si sono insediati i Nenets, un popolo nomade che alleva renne.

I Nenets conducono una vita dura ed essenziale che ruota attorno all’allevamento delle renne e alla propria sopravvivenza, portando avanti con onore antiche tradizioni tramandate centinaia di anni fa.

Tuttavia i Nenets sono minacciati da alcuni fattori, come la loro complessa vita, il riscaldamento globale e l’estrazione del gas. Questo fa sì che sempre meno persone decidano di continuare a vivere nella tundra, costringendoli ad una vita ancora più difficile se non alla loro scomparsa.

L’opportunità di vivere con loro è emozionante e gratificante sia a livello culturale che umano. L’esperienza di poter incontrare persone così lontane dal nostro stile di vita, affrontando un viaggio non proprio semplice, fa riflettere su come si possa vivere in certe situazioni, regalando un’apertura mentale ed emozioni uniche che fanno apprezzare molto di più le piccole cose quotidiane.
Foto e parole di Alessandro Malaguti
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Nel corso della storia del Medio Oriente, il popolo curdo si è differenziato per il coraggio e l’onore dei suoi guerrieri. Per questo motivo ha acquisito una posizione di rilievo nella regione.
Questo ha comportato che i re, i sultani e i califfati di quel tempo prendessero di mira e utilizzassero i curdi per proteggere e sviluppare i loro confini e stabilizzare l’entità dei loro imperi.
Del resto, sono stati spesso esiliati e costretti ad emigrare, con molti esempi negli imperi ottomano e iraniano.

Quattro secoli fa, dopo la guerra caldea e la sconfitta dei Safavi contro gli ottomani, i curdi furono gradualmente e con la forza sfollati.
Più di 50.000 famiglie del Khurasan Kurmanji si diressero verso i confini orientali dell’Iran per proteggere i confini dagli uzbeki che avrebbero poi occupato l’area.
Dopo la fine delle guerre, i curdi sfollati sono rimasti bloccati in quei confini e non hanno potuto tornare nel loro territorio. Da allora i loro discendenti vivono nel nord dell’Iran e vicino al confine del Turkmenistan.

In questo progetto artistico, studierò alcune delle conseguenze di questo esodo forzato imposto ad alcune famiglie curde da Safavi in Iran. È per me motivo di riflessione costatare che durante questi secoli di migrazione forzata, sebbene molte delle loro tradizioni siano cambiate, si parli ancora curdo e kurmanji. I loro vestiti sono cambiati in un modo che non assomiglia a quello curdo, un misto di abbigliamento turco e abbigliamento persiano.

In generale, vivono una vita instabile e immigrata, molti di loro sono impegnati nell’allevamento. Questi curdi ancora non si considerano padroni di nessun luogo e hanno una vita semplice e difficile, che è sicuramente il risultato della separazione dalla loro patria.
A mio parere, questo problema merita di essere indagato e affrontato, quindi è fondamentale esaminarlo di più e renderlo uno dei miei progetti.
Ho ora dedicato questa collezione di opere d’arte a questo argomento che è parte di un progetto incompleto sempre più ampio. Questo sarà un tentativo di presentare e dimostrare le sofferenze e i dolori di queste famiglie curde e gli effetti di questo esodo sulla loro cultura, lingua e tradizioni.
Foto e parole di Younes Mohammad
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Acciughe e sardine sono pesci pelagici molto diffusi in tutto il Mediterraneo. In Italia le zone più frequentate da questi pesci “azzurri” sono la Sicilia e il medio e basso Adriatico. Un metodo per catturarli, ovvero una tecnica ancora in uso oggi é la pesca con la lampara . Questa viene effettuata da un’imbarcazione madre, e da 2-3 piccole barchette o gozzi. Ognuna di esse ha delle grosse “lampare” installate ed alimentate a batteria oppure a gas.

Arrivati sul luogo di pesca nottetempo, i marinai ammainano i piccoli gozzi e, a lento moto di corte bracciate, azionano la lampara per attrarre dal fondale marino. Banchi di sardine, piccoli sgombri, alici, acciughe, circuiti dal forte bagliore della luce artificiale della lampara.

Una volta “radunati” i diversi banchi di pesci sotto le loro chiglie, i gozzi si avvicinano quasi a toccarsi. A questo punto entra in gioco la barca-madre con il compito di gettare in mare il cianciolo: una rete tesa in verticale tenuta in superficie da sugheri galleggianti, mentre nella parte inferiore porta dei piccoli piombi che la stendono formando una parete mobile fino a quasi toccare il fondo che lentamente circonda il pesce ammassato in un piccolo spazio.

Chiuso il cerchio, le lampare spengono le luci ed escono dalla rete e il pesce rimane intrappolato.
Da bordo della barca-madre, tirano delle cime per chiudere la rete sul fondo e trasformarla in un sacco pieno di pescato che viene finalmente issato a bordo.
Foto e parole di Claudio Varaldi
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Focus del nostro viaggio è stata una missione umanitaria in Marocco. Dalle affollate medine di Marrakech attraversiamo le pianure desertiche del al-Rashidiyya dirigendoci verso est. Il passo obbligato è Merzouga, la prima tappa del nostro viaggio, da lì in poi solo le sabbie del Sahara. Questa terra attraversata un tempo da carovane di beduini a cammello, osserva oggi il passaggio di motociclisti da tutta Europa in cerca di avventura nelle dune sabbiose. Questa è stata la mèta del nostro viaggio umanitario; dove vivono le donne ripudiate ed i loro bambini.

Donne sole per lo più divorziate, vedove o abbandonate dai mariti e perciò ripudiate. Una volta che hanno perduta la loro dignità e il riconoscimento da parte dei loro uomini sono lasciate vivere in condizioni precarie al limite della sopportabilità.
Abbiamo incontrato alcune di loro, Kadija, Arkia, Labo, Zoara, Boulemane. Chi con un bambino e chi con anche 5 figli, abitano a sud-est delle dune di Merzouga senza alcun sostentamento se non di qualche associazione umanitaria.

Da tutta Europa, gli amanti dei tour di motociclismo che transitano per queste zone colgono sempre l’occasione di fermarsi per un tè e così di lasciare un dono al loro passaggio.
Queste donne non possono tornare nei loro villaggi di origine, la maggior parte sono di Tafroutein, ridotte a vivere in tende mal ridotte che non proteggono dal vento e dalla sabbia né loro né i loro bambini.

Ad ognuna, con il supporto di una ONG italiana, abbiamo avuto l’occasione di donare, merito di una raccolta fondi, fino a quattro capre per il loro sostentamento. In questo ambiente così difficile, nella povertà in cui vive questa gente anche una sola capra rappresenta una risorsa preziosa.

Le caprette sono state acquistate nel mercato locale con l’aiuto del capo del vicino villaggio. Una volta arrivate su un furgone, non è stato semplice distribuirle. Il nostro accompagnatore si è occupato di farci da interprete e di provvedere alla distribuzione degli animali, secondo i reali bisogni e il numero dei componenti di ogni tenda.
Inoltre, ad una di loro è stato anche donato un forno solare. Questo è stato progettato e realizzato da ingegneri italiani, trasportato smontato in aereo e installato sul luogo. Questo sfrutta direttamente la luce solare senza altri fonti energetiche quindi adatto a situazioni limite. E’ stato subito utilizzato per cuocere il batbout, il loro pane tipico, e con il tajine ed il thè alla menta. Ci hanno accolto nelle loro tende per ringraziarci a dimostrazione dell’ospitalità berbera.

La realtà rappresentata è certamente informazione ma anche il significato di questa informazione.
Il fine ultimo di questa serie avrebbe voluto essere di spiegare, nel gergo “umanistico”, l’uomo all’uomo. Solitamente le fotografie, nello specifico documentaristiche, constatano soltanto, non hanno velleità di cambiamento. Io vorrei invece mostrare che un cambiamento è possibile e noi dovremmo renderlo tale. E’ soprattutto in situazioni come quelle mostrate qui che possiamo rivalutare il nostro modo di pensare il presente, dove l’altro anche se non ha nulla, ci arricchisce della sua umanità.
A sera dopo le rituali foto di gruppo, tra saluti, sorrisi e benedizioni, abbiamo lasciato l’accampamento. Appena slegate alcune caprette hanno accennato ad un tentativo di fuga ma poco dopo si son fermate ad aspettare. Non c’era nessun posto dove andare.

Foto e parole di Luca Maiorano: https://www.facebook.com/luca.maiorano.57
Per saperne di più sul “Travel Tales Award” vai su: https://traveltalesaward.com/

Provo sempre piacere ogni volta che prendo la mia macchina fotografica e vado nella città murata di Lahore, in Pakistan, che è anche chiamata Old Lahore (Androon Lahore), per fare ritratti di persone anziane e bambini. La città murata di Lahore costituisce il nucleo storico di Lahore. Fu fondata intorno al 1000 d.C. nella metà occidentale della città murata che fu fortificata da un muro di fango durante l’era medievale.
Ho viaggiato in bicicletta. Mi sono sentito molto al sicuro durante il mio viaggio a Old Lahore (Pakistan). Questo posto, il loro cibo e le persone mi attraggono sempre a venire lì e a catturare le storie delle persone lì.

Per me i volti su cui ho cliccato non sono solo volti umani ma sono pieni di emozioni e storie. Possiamo vedere l’amore, la rabbia e le emozioni attraverso i loro occhi e la felicità, le sofferenze e le difficoltà della loro vita attraverso le rughe.
Era un novembre quando sono andato a Old Lahore per esplorare la bellezza di questo luogo storico. C’erano anche moschee e monumenti molto belli, ma dato che sono un fotografo ritrattista ho iniziato a cercare dei volti unici per catturarli nella mia fotocamera.
Non si tratta solo di scattare foto di volti unici di uomini o donne anziani. Si tratta di catturare storie, emozioni e momenti magici. Si tratta di catturare le emozioni che guardano sui loro volti e nei loro occhi. Per me le immagini sono film o canzoni fisse che esprimono tutto da sé.

Questa zona di Lahore ha strade molto strette con storie illimitate. Ho trovato molte storie diverse vedendo i diversi Uomini e Donne per le strade che poi ho cercato di catturare nella mia macchina fotografica e mostrare le loro emozioni e storie attraverso le mie immagini.
Ho sempre cercato di comunicarli bene attraverso gesti ed espressioni piacevoli e ho avuto un’ottima conversazione con loro.

Mi hanno raccontato molto delle loro vite e delle loro storie. Alcuni di loro mi hanno persino raccontato di come hanno viaggiato o sono emigrati dall’India al Pakistan dopo l’Indipendenza. Come hanno vissuto la loro vita qui e molto altro ancora.
Ho scattato tutte queste foto durante il mio viaggio ad Androon Lahore ed è stata davvero un’esperienza straordinaria catturare i volti unici di Lahore. La vecchia Lahore è sempre piena di queste storie. Possiamo vedere tutta la vita e le storie delle persone attraverso i loro occhi e le rughe dei loro volti.

Un’altra cosa è che quando ero in questo viaggio c’erano anche molti pellegrini sikh, che venivano dall’India per i loro riti religiosi. E ho anche trovato più interessante comunicare con queste persone e catturare anche le loro storie.
È stata davvero un’esperienza straordinaria lì. Voglio davvero andare in queste stradine di Lahore ancora e ancora per catturare storie belle e interessanti di persone.

foto e parole di Usama Khan
Per partecipare anche tu al”Travel Tales Award 2023″ vai su https://traveltalesaward.com/

Sono le quattro del pomeriggio e a Churchill ci sono 2 gradi. Considerando il posto in cui mi trovo e il periodo (fine ottobre), la temperatura è troppo alta e per l’ORSO POLARE, il più grande carnivoro del pianeta (motivo del mio viaggio) il clima è quasi afoso
E’ proprio qui nella Baia di Hudson nei pressi di questo paesino di circa 800 abitanti nella regione di Manitoba in Canada, gli orsi polari attendono che si formi la banchisa.

Le concentrazioni del ghiaccio marino negli ultimi decenni si sono ridotte drasticamente mettendo a rischio la sopravvivenza di questo splendido mammifero. La mancanza di ghiaccio impedisce loro di procacciarsi cibo e quindi l’orso si avvicina sempre più ai centri abitati. Il problema del surriscaldamento qui è una realtà tangibile con cui bisogna fare i conti e si percepisce appena si entra in questo villaggio.

Saliamo su un fuoristrada, accompagnati da una guida locale armata e iniziamo il nostro primo giro di perlustrazione attorno al villaggio. Ed ecco il primo avvistamento!! Rannicchiato nel verde si è alzato e il bianco del suo manto spiccava sopra ogni colore circostante.
Il giorno dopo alle otto eravamo già operativi, ma il re dell’Artide era poco attivo …ci osservava con aria annoiata e per nulla impaurita. A volte si spostava di poco e si rotolava in mezzo alla neve per pulirsi la pelliccia per poi rimettersi a dormire. A mezzogiorno c’erano 10 gradi sopra lo zero. Caldissimo!!!

Un’altra giornata volgeva al termine e nel tornare verso Churchill incontriamo un orso che camminava per strada in direzione del centro abitato. Riesco in qualche maniera a fotografare il momento, il cuore è a mille. Quell’orso in mezzo alla strada, impaurito e affamato mi ha portato alla dura realtà del momento.
Gli abitanti di Churchill sono ormai abituati a queste visite inaspettate. Tutti in casa hanno un fucile e non chiudono le porte di casa a chiave per salvarsi da possibili attacchi da parte degli orsi.

Non c’è ghiaccio e gli orsi non possono avventurarsi a caccia di prede; ho visto il più grande carnivoro della terra mangiare erba oppure avvicinarsi ai fuoristrada per cercare cibo o smarriti in discariche saltare da un fusto all’altro alla spasmodica ricerca di qualcosa per placare la fame.

L’episodio che però, più di tutti ha segnato questo viaggio è stato la cattura di un orso: ad un certo punto l’autista ha fatto un’inversione ad U e ci ha urlato che non potevamo perderci questo momento: stavano catturando un Orso. Ci dirigiamo verso quella che è considerata l’unica prigione al mondo di Orsi e abbiamo assistito a tutta la procedura di cattura .
Un elicottero stava inseguendo un orso perché c’erano state delle segnalazioni di avvistamento nel centro abitato. Lo hanno addormentato, messo in una rete e in seguito trasportato verso la prigione. Ci hanno raccontato che gli orsi vengono tenuti in cattività, in delle gabbie non troppo grandi e a digiuno e questo dovrebbe servire da deterrente per l’animale in modo da non farli avvicinare più al villaggio.

Fino al 1982 gli orsi che si avvicinavamo a Churchill venivano uccisi in quanto considerati pericolosi. Dal 1983 fu istituita la “prigione per gli orsi” dove squadre di professionisti si occupano di gestire gli ormai sempre più frequenti avvicinamenti degli orsi al centro abitato. Dopo la cattura e un periodo di stazionamento di 30 giorni gli orsi verranno liberati in un’area dell’Artide a circa 70 km da Churchill.
Il cambiamento climatico è stato devastante per questo ecosistema. Negli anni ’80 in questo territorio ci vivevano circa 1200 orsi, oggi sono 800 e si stima che nel 2050 ci sarà una riduzione di due terzi fino a scomparire del tutto alla fine di questo secolo.

Voglio chiudere questo racconto con delle foto che ho scattato i primi giorni del mio viaggio in cui nei miei occhi c’era ancora l’entusiasmo, la curiosità e l’emozione.
L’immagine che voglio associare a questo straordinario mammifero è la liberazione dalla “prigione”, anche se non ho potuto osservarlo direttamente, ma con i miei scatti ho cercato di far visualizzare questo momento negli occhi dell’osservatore. Voglio immaginarlo libero, coperto di neve e sdraiato sul ghiaccio a digerire il suo pasto e a rilassarsi nel fresco gelo della banchisa.
foto e parole di Giusy Scigliano



Vi presentiamo Cobra Grande, il racconto di viaggio con il quale Pierluigi Ciambra è stato selezionato come Finalista a Travel Tales Award 2021, la storia di una grande avventura amazzonica con la fotocamera in mano per raccontare esperienze ed emozioni irripetibili.

Manicoré, centro della foresta pluviale Amazzonica, agosto 2004.
Si arriva con il battello, lungo il Rio Madeira, in due giorni di navigazione da Manaus.

Varie tonalità di verde intenso e miriadi di fiumi e fiumiciattoli creano un panorama mozzafiato, la natura detta le proprie regole e determina la vita della popolazione, un’esistenza simbiotica tra uomo e natura.

Si vive per strada, le case sono troppo piccole e le famiglie troppo numerose, molti giovani migrano verso la città.
Il più delle volte è ancora più dura e allora si risale sul battello, a fendere le acque del fiume.

Ecco il link per scoprire tutto il lavoro di questo Autore sensibile e molto preparato: https://www.pierluigiciambra.com/ qui troverai tutti i suoi progetti, la bio, altre info e fotografie.

Questo racconto di viaggio è stato selezionato come Finalista tra i candidati di Travel Tales Award 2021. L’Autore Mario Cucchi ci parla del Popolo Saharawi che vive nel deserto del Sahara in una terra indefinita tra Marocco e Algeria. Una situazione di estrema povertà per una minoranza etnica che non viene accettata da nessuno ed è costretta a vivere lontana da tutti in territori disseminati di mine. Leggi questo articolo e infine scrivi le tue impressioni qui in fondo all’articolo.

Che ne sarà del popolo Saharawi costretto, ad un forzato esilio in una delle zone più inospitali del pianeta?
•Un muro lungo più di 2.700 chilometri nel deserto africano.
•10 milioni di mine.

•Una guerra di 15 anni che si è conclusa ma un conflitto che ancora non ha fine.

•Un referendum per l’indipendenza richiesto dall’Onu che non è mai stato fatto.
•E un popolo che vive da più di 45 anni nei campi profughi.

E’ la storia dell’ultima colonia africana, quella del Sahara occidentale, conosciuta come ex Sahara spagnolo e ora occupata dal Marocco.

Sarà la gioia di poter tornare nella loro terra che leggiamo nella speranza dei bambini, oppure continuerà la totale indifferenza della comunità internazionale che vediamo nella rassegnazione degli anziani? Il rischio è che la giustificata rabbia dei giovani porti al suicidio di una nuova guerra.

Infine il progetto, organizzato in dittici, vuole sottolineare i contrasti, a volte magnifici, più spesso terribili, che il popolo Saharawi vive.


Destino è il racconto di viaggio con il quale Nadia Cianelli ha partecipato a Travel Tales Award 2021
Ho attraversato la Patagonia in autobus, accompagnata dall’interminabile linea retta dell’orizzonte, la macchina fotografica e una busta: di quelle gialle, con stampato in alto a sinistra “Poste Italiane” e scritto a mano un improbabile indirizzo: “Por el Capitan del barco Barracuda – Ushuaia”.

Una persona incontrata per caso pochi giorni prima di partire mi aveva chiesto la “cortesia”. Non era quello il motivo del mio viaggio, ma da allora recapitare quella busta è diventata la mia missione.
Man mano che si scende verso sud la presenza umana si fa sempre più rarefatta. Le distanze tra le cittadine sono enormi, lungo il percorso di tanto in tanto si vede una estancia, o la carcassa di un guanaco rimasto intrappolato nel filo spinato delle recinzioni. Un gaucho a cavallo galoppa verso casa seguito dai suoi cani.

Puerto Madryn, la Peninsula Valdés, Puerto Piramides, Punta Ninfas, pinguini e leoni marini. Rio Gallegos, Cabo Virgenes e quel faro che guarda verso il Cile, fino a giungere alla fine del mondo: la Terra del Fuoco.
Il mio istinto di fotografa mi aveva suggerito un’intenzione: ad ogni tappa ho fermato persone e le ho fotografate chiedendo loro di posare con la busta gialla in mano.
“Cosa c’è dentro?” mi chiedevano stupiti. “Non lo so, decidi tu” rispondevo, allora si facevano seri, concentrati in qualche pensiero. E io scattavo.

Giorno dopo giorno quella busta diventava sempre più pesante nell’accogliere i pensieri di tutte le persone ritratte, e per me sempre più importante. Fino a pochi chilometri da Ushuaia non mi era mai venuto in mente che quel Capitano del barco Barracuda avrei potuto anche non trovarlo. Una volta arrivata in città vengo assalita da una frenetica urgenza. Consegnare quella busta ormai sgualcita per i passaggi in troppe mani ha assunto un’importanza vitale.
Ho il vento in faccia e la percezione quasi fisica di essere veramente alla fine del mondo, nell’ultimo lembo di terra abitato all’estremo sud del pianeta, più avanti solo i ghiacci dell’Antartide.

Al porto scopro subito che il Barracuda è ormeggiato sulla banchina, ma ormai non naviga più da tempo. “E il Capitano? Cosa ne è stato del Capitano?” chiedo all’uomo cui mi sono rivolta per avere informazioni.
“Chi, Danilo?” Sono fortunata, lo conosce ed è disposto ad aiutarmi. “Danilo? Ciao” non so spiegare la sensazione che provo quando comprendo che ci sta parlando al telefono. “C’è qui una signora che viene dall’Italia, ti cerca, ti deve consegnare una busta.
Prendiamo un appuntamento per il pomeriggio seguente. Temo fino all’ultimo momento che non venga, ma si presenta puntuale. Dopo un saluto imbarazzato saliamo sul relitto, impolverato e arrugginito, e finalmente gli consegno quel messaggio scritto solo per lui.

Di nuovo a terra lo invito a bere qualcosa insieme, Lui resta in silenzio per un poco, poi mi si rivolge con il volto serio: “La ringrazio, ma devo proprio andare. Ho un volo per il Cile tra poco più di un’ora. Lascio per sempre questo paese”.
Avevo consegnato quella busta appena un’ora prima che il destinatario scomparisse per sempre. La Patagonia è terra di magie, e con me non si è risparmiata.


Wakhan è un racconto che ha partecipato a Travel Tales Award 2021.
Un frammento del mio cuore è perso tra le montagne del Pamir è negli occhi delle persone che ho incontrato e dentro ogni ruga del loro viso che rimandano a quanto questa terra possa essere meravigliosa e terribile.
In Afghanistan ci sono stata per fotografare i Kyrgyzi. Una popolazione nomade che vive all’estremo nord e arrivarci non è stato semplice.

Per raggiungere la frontiera afghana ci sono voluti 2 giorni di macchina su strade sterrate, seguendo il fiume Pamir, passando tra gole di sorprendente bellezza e guadando corsi d’acqua. Passata la frontiera a Ishkashim, si attraversano le terre del Wakhan dove si vive di pastorizia, agricoltura e hashish.

Quello di cui vado orgogliosa è il rapporto che sono riuscita ad instaurare con le persone, una comunicazione fatta di gesti, sguardi ed espressioni.

Il percorso con la macchina termina a Sarhad, da qui, inizia l’ascesa verso le montagne del Pamir, si deve proseguire a cavallo e nei tratti più ripidi, a piedi.
Siamo a 3.200 metri. Passiamo i siti di Borak, Langar, Kashch Goz e arriviamo sull’altopiano. Cerco di imprimere nei miei occhi l’immagine di ogni singola vetta, di ogni altura,di sentire il vento, il sole e penso che tutto questo l’hanno vissuto anche Alessandro Magno e Marco Polo. Ci vogliono 5 giorni per arrivare a Bozai Gumbaz dove sono stati avvistati i Kirgyzi.

Tanto la popolazione dei Wakhy è aperta e socievole, tanto i Kirgyzi sono diffidenti e restii ai contatti con persone esterne. Il permesso di restare ci è accordato, però è stato vietato agli uomini di fare foto. Ma i soldi fanno comodo a tutti e così il divieto è sciolto e la sera è stata organizzata una cena che prevede capretto, pesce di fiume e naan, il tipico pane afgano, il più buono che abbia mai mangiato!

Mi aggiro tra le yurte e le costruzioni fatte di fango e pietra. Vedo solo donne. Le seguo mentre vanno a prendere l’acqua o fanno rientrare gli animali nei recinti, o cucinano per noi. La nostra guida ci spiega che il colore del copricapo che indossano, distingue le sposate dalle nubili: bianco per chi ha un marito; rosso per le nubili.

Siamo rimasti solo una giornata al villaggio. Sono stata fortunata a fotografare i Kirgyzi, poiché è una di quelle popolazioni le cui tradizioni sono a rischio di estinzione.

Mi piacerebbe tornarci una terza volta in questa terra e non per riprendermi il cuore che vi ho lasciato, ma per lasciarne altro.


L’arca è il progetto di Giulio Cesare Grandi che ha presentato a Travel Tales Award 2022 riscuotendo un successo unanime da parte dei Giurati.

Il fascino dell’India è la coesistenza, nella vita quotidiana, di passato e presente fusi nello stesso istante. E’ come se la ruota della storia girasse in continuazione e nello spazio di pochi metri si passa da un mondo primitivo all’era industriale, dal medioevo al mondo virtuale dell’informatica. Questo reportage vuole essere una piccola finestra sul mondo dei maestri d’ascia.

Forse NOE’, prima di costruire la sua Arca, è passato di qua! E’ il primo pensiero che mi sorge spontaneo arrivando, in un tardo pomeriggio di febbraio, in questo porto.

Una flotta di centinaia di navi di legno e la sensazione di essere finito sul set cinematografico di un film storico. Giganti in grado di solcare gli oceani. Sulla spiaggia un infinito cantiere ove ciascuna imbarcazione è costruita rigorosamente “a mano”,da uomini minuti, pezzo per
pezzo a partire dal singolo tronco di legno. Ogni nave è diversa dall’altra, vere e proprie opere d’arte, con un’ anima, una storia ancora prima di essere varata.

La costruzione è un insieme di tecnica, duro lavoro solo umano e preghiera per ingraziarsi ed invocare la protezione degli Dei.


Il Maramures è una regione a nord della Romania confinante con l’Ucraina.
In questa regione vi sono alcuni comuni in cui tutto il sostegno economico viene dall’agricoltura, ed è qui che sono state scattate queste fotografie.

In queste comunità, quello più mi ha colpito, è la vita delle donne, a cui è demandato non solo la gestione della casa e degli animali, ma in moltissimi casi accudiscono anche il marito.

Molte storie si assomigliano: Maria, che ha lavorato per anni in Italia come badante, è tornata ad accudire il marito molto malato; Ana vive sola dopo la morte del marito e continua ad accudire il bestiame di famiglia; Loana mi invita in casa ad assistere al funerale della loro regina trasmesso dalla televisione e mi parla del marito morto da poco per un tumore alla gola.

Tutte queste donne accumunate da una grandissima dignità e dalla voglia di farti sentire a casa. Donne come Gabriela che vive col marito e si prende ancora cura della casa e del figlio che sta tentando di aprire un museo di oggetti tipici e mi invita ad unirmi per pranzo, dopo esseri vestita in abiti tipici per una foto.
Questo sarà solamente il primo dei tanti pranzi fatti con diverse famiglie.

La cultura contadina è sempre presente e diverse donne mi mostrano orgogliose le loro pecore o le loro mucche ma, alla domenica, tutte in chiesa a pregare e partecipare alla lunga cerimonia ortodossa che a me sembra non finire mai.
Come da tradizione possono entrare in chiesa ma devono rimanere nella zona posteriore, possono andare nella zona anteriore solamente per baciare le icone.

La vita scorre lenta, al ritmo della vita contadina, ed alla sera, invece di stazionare davanti alla TV, ci si riunisce lungo la strada per scambiare due parole.

Dopo una settimana termina il mio viaggio e ne esco arricchito per aver trovato una ospitalità incredibile. Ripensando ai racconti su mio nonno, che di lavoro faceva il contadino, penso di aver visto come poteva essere la sua vita, molto più semplice ma decisamente più ricca della nostra.


La HW 61 da New Orleans a Saint Louis è un itinerario leggendario che accompagna il fiume Mississippi nel suo sonnacchioso scorrere verso il mare. Evoca nella mente e nell’anima quella fetta di terra Americana intrisa da quel genere musicale che è il blues del Delta.

Una strada è una strada, ma a volte è di più… una strada suona e canta. Ho guidato lungo questa pianura spesso simile alla mia terra, alla ricerca della sua musica, ho attraversato questi luoghi accompagnato dal Blues che usciva dalla radio costantemente ed ho raccolto immagini e parole testimoni di questo mondo che trasuda ancora del Blues.

Il blues nasce come canzone di protesta, nasce nelle piantagioni di cotone del delta Mississippi, dove le comunità di schiavi afroamericani lavoravano duramente, sottopagati e sfruttati.
Nasce al calar del sole nelle calde sere, nelle bettole dove s’incontravano per bere, suonare e cantare insieme.

I luoghi del blues sono parte inscindibile della tradizione e a livello storico sono una sorta di atlante, che si apre dinnanzi agli occhi di noi viaggiatori curiosi col suo patrimonio fatto di miti e leggende. In queste contrade sperdute nel nulla, questa musica è nata e cresciuta.

Il blues l’ho incontrato ovunque, al “Poor Monkey” al Reed’s o al Ground Zero, dove sul palco si esibivano bluesmen locali, ma anche al Lorraine Motel dove la storia dei diritti civili non si è fermata nemmeno davanti al brutale assassinio del Reverendo Martin Luther King. L’ho incontrato nei cimiteri dove i bianchi sono ancora da una parte e i neri dall’altra, sui murales che colorano le città che ti vedi passare lungo la “61”.

L’ho incontrato dal barbiere, perché è lì che lo si incontra veramente, oppure su quei divani sfondati che troviamo davanti alle case di legno, nelle vecchie piantagioni come fantasmi che non se ne vanno o lungo i binari di quella ferrovia che li ha portati via.
Questo è stato il mio viaggio e le sue sensazioni sono ancora dentro di me.


Certi viaggi fanno parte di noi ancor prima di partire. Fanno parte del nostro DNA da quando nasciamo, ci appartengono come se fosse un nostro diritto farli prima o poi, e quando riusciamo a partire per certe destinazioni non ci stupiscono neanche più di tanto perchè già ne conosciamo i dettagli, le cose che vediamo dall’altra parte del mondo appartengono già al nostro archivio dei sogni, alla galleria iconografica che giorno dopo giorno costruiamo nella nostra vita quando, dentro noi stessi, archiviamo le emozioni ed esse diventano il nostro modo di essere. Tutto questo è proprio quello che mi è successo quando sono partito la prima volta per l’Uzbekistan.

Chi se lo sarebbe mai immaginato: in due anni ci sono andato tre volte… Molte persone non sanno neanche dove si trovi questo Paese, alcuni non lo hanno neanche sentito nominare, altri non hanno neanche idea che la famosa Samarcanda si trova qui. Ma in Uzbekistan ci sono altre cose che abbiamo studiato sui libri di geografia come il Lago Aral, il quarto più esteso del mondo, che nel giro di soli trent’anni è stato completamente prosciugato da una scellerata politica agricola dei Bolscevichi che all’epoca governavano. Tanti altri hanno studiato a scuola la Via della Seta di Marco Polo e magari non sanno che una parte di quei 12.000 chilometri che uniscono Roma e Pechino passano proprio in territorio uzbeko. Adesso la situazione è forse più chiara per molti e tutti si sono fatti un’idea di dove cercare sul mappamondo…

Insomma siamo in Asia Centrale, circondati da Paesi ancor meno noti come il Tagikistan, il Turkmenistan, il Kazakistan e l’Afghanistan… Un territorio lontanissimo dal mare ma molto fiorente di commerci e scambi culturali… Culture sospese tra oriente e occidente, interi popoli che portano ancora ben chiare nella memoria storica recente le dominazioni sovietiche che ci sono state fino ai primi anni 90 del ‘900.
In tutta questa enorme area del mondo, ci sono montagne aspre e selvagge che hanno portato l’uomo a vivere a strettissimo contatto con le forze della natura e a vivere di pastorizia: il rapporto con gli animali diventa quindi quotidiano di rispetto e di sfruttamento. Gli animali vanno accuditi perchè forniscono carne, latte, uova, o forza lavoro. E in questa ottica va letto lo sport più diffuso e sentito da queste parti che non si trova in alcuna altra parte del mondo. Qui, nelle gole rocciose e aride dei monti del Pamir, tra gli sconfinati spazi del deserto del Kyzylkum o nella fertile valle dell’Amu Darya si svolge una competizione equestre chiamato Buzkashi, che letteralmente significa “Acchiappa la pecora” ed è proprio ciò che accade tra uomini e animali in un rito le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

Un’amica mi aveva segnalato questa sentita tradizione locale e in occasione del mio secondo viaggio in Uzbekistan ho deciso di uscire dal tipico itinerario turistico fatto tra le bellissime città di Samarcanda (quella famosa per la canzone), Bukhara (famosa per i tappeti) e Khiva (Patrimonio dell’UNESCO e nota per le sue mura) e di mettermi alla ricerca di un Buzkashi in giro da qualche parte per vivere in prima persona questo evento popolare e fare un pò di foto che si preannunciavano come un evento decisamente suggestivo..
Sapevo che era probabile che sarei riuscito a trovarne uno da qualche parte cercandolo bene perchè queste competizioni si fanno in occasione di feste nazionali o religiose, o per festeggiare un matrimonio o la circoncisione di un bambino. Nei giorni in cui ero lì si celebrava in Navruz per dare il benvenuto alla primavera e un Buzkashi sarebbe stato davvero la parte di programma più originale della giornata.

Ma la mia ricerca è stata tutt’altro che facile, perchè qui siamo in Uzbekistan e ad oggi ancora non esiste un sito che dia le date certe di queste gare che sono sempre affollatissime di persone che si danno un vero e proprio passaparola su gruppi di Whatsapp o di Telegram, ma che non comunicano con ufficialità l’evento che resta quindi assolutamente spontaneo e incontrollabile. La cosa incredibile sono proprio i numeri: si arriva facilmente a migliaia di persone che si incontrano in un posto non segnalato e non controllato in alcun modo. Ma la ricerca in loco, invece è stata difficile perchè cercavo un Buzkashi e la gente non mi capiva… Nessuno sapeva cosa fosse, nessuno poteva aiutarmi: il motivo l’ho capito dopo un pò che cercavo…. In Uzbekistan il Buzkashi si chiama Kupkari oppure Uloq, non Buzkashi che è proprio il nome afghano dello stesso sport!

Una volta svelato l’arcano del nome, la ricerca è stata più semplice, ero nei pressi di Samarcanda e la gente mi ha indicato un paesino in cui si sarebbe svolta la competizione. Mi sono avviato con la mia Guida Locale alla ricerca del posto… Ci avevano detto che era una specie di cava in campagna, ma non erano stati troppo chiari… La ricerca doveva ancora essere perfezionata e le sorprese ancora non erano finite: quel giorno era festa, il 21 marzo infatti si celebra in Navruz, la festa che da il benvenuto alla Primavera e mentre andavamo verso il campo di gara, siamo passati in un paesino sperduto, oserei dire un caseggiato senza nome, nel quale ci hanno letteralmente bloccati e fatti scendere dal pullman per invitarci a casa loro a mangiare e bere in compagnia. Volevamo andare via per non perdere la gara che era il motivo del nostro viaggio fin lì, ma loro sono stati irremovibili: “il Kupkari lo organizziamo noi e finchè noi siamo qui con voi la gara non ha inizio” e così è stato.

Alle 10,30 del mattino ci hanno portati di peso in casa ad offrirci vodka e cetrioli, fagottini di carne e intingoli vari. Ci ha accolti una donna dalla vistosissima arcata dentale superiore interamente ricoperta di oro (da questa parte è un vezzo estetico che amano ostentare per motivi economici) che parlava un discreto inglese perchè era la professoressa di lingue della scuola. Lei ha fatto gli onori di casa offrendoci ogni genere di cibi, vodka e cognac che non potevamo rifiutare e che cercavamo di stemperare alternandoli con una tazza di the.
Qui la vita scorre lentamente, siamo a mezz’ora dal caos di Samarcanda ma qui il tempo sembra si sia fermato: la gente veste ancora in modo molto tradizionale con gli uomini che indossano il loro tipico berretto ricamato e le donne vestono con ampie gonne di velluto nero con fiori policromi e un evidente “stile Matrioska” completato con delle scarpe rigorosamente a sabot, aperte dietro come una elegante pantofola…

Mentre parlavamo con la padrona di casa il marito era fuori sotto al portico che gioca a scacchi con un suo amico incurante di tutto ciò che gli gira intorno come siamo ad esempio noi che benchè fossimo andati lì per fotografare eravamo invece noi i soggetti preferiti dalla popolazione locale che volevano farsi i selfie con noi non avendo praticamente mai visto dei pazzi turisti avventurarsi fino al loro villaggio per nessuna ragione e men che meno per andare a vedere il Kupkari! Noi eravamo per loro il vero elemento di attrazione e questo mi sembra chiaro e comprensibile.
Altri uomini sul retro di casa erano lì a fare scommesse ma non puntavano sugli esiti del Kupkari che ci sarebbe stato di lì a pochi minuti, ma facevano un gioco che ricorda molto da vicino il nostro gioco delle tre carte… Per queste persone il tempo non è un fattore importante, per loro la vita scorre senza grossi cambiamenti, per cui noi eravamo una vera attrattiva per tutti loro che venivano a guardarci con amichevole sincerità.
Ritirati i bicchieri del thè ci hanno finalmente detto che stava per iniziare il Kupkari e che dovevamo seguire una certa strada a piedi per arrivarci perchè lì non c’è altro modo per raggiungere i terreno di gioco.

Un chilometro a piedi e siamo arrivati: un enorme campo di terra grezza circondato su due lati con un terrapieno che serve agli spettatori come tribuna per godersi lo spettacolo a costo zero ma seduti a terra.
Le regole sono presto dette: un numero indefinito di cavalli e cavalieri (possono arrivare a 100 partecipanti su altrettanti cavalli) si contendono la carcassa di una povera pecora sgozzata per l’occasione e abbandonata a terra. I cavalieri non sono divisi in squadre, ma giocano ciascuno individualmente. Partono al galoppo verso il povero corpo che giace a terra senza vita e senza fermare la corsa nè scendere devono prendere il corpo della pecora (circa 35-50 chili), caricarselo sul cavallo e consegnarlo in un punto convenuto per prendere un piccolo premio in denaro (20 Euro circa) e un regalo di modesto valore come potrebbe ad esempio essere una camicia di imitazione italiana o un tappetino da preghiera.

La competizione è molto dura, forte da vedere, il corpo morto della pecora viene conteso senza esclusione di colpi tra i cavalieri che possono letteralmente strapparlo di mano all’altro contendente che lo aveva preso e sperava di riuscire a difenderlo… Al nostro occhio occidentale di certo può sembrare un maltrattamento nei confronti degli animali, anche e soprattutto dell’uso che viene fatto della pecora morta, ma occorre tenere presente che lì il rapporto tra uomini e animali non è fatto di amore ma di necessità.
Prima di iniziare l’Imam della Moschea benedice i partecipanti che se la rischiano anche in certi momenti di lotta corpo a corpo, poi parte la sfida con numerosissime cariche al galoppo che vanno a raccogliere la povera pecora che viene straziata durante il trasporto e le dispute tra i cavalieri.

La partecipazione ad un evento del genere è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, non si può rimanere indifferenti, si vive ogni istante in un modo immersivo: le urla della gente, la puzza dei cavalli che si mescola con i fumi della carne grigliata, il sole che batte sulla testa e il sapore della polvere che arriva fino in gola, gli occhi che osservano attraverso l’obiettivo della fotocamera.
Non si può stare in un Kupkari senza sentirsene parte integrante, senza vivere in prima persona il brivido di una carica di 30 cavalli che ti corrono incontro al galoppo e rischiano di travolgere chiunque pochi istanti prima si sentisse al sicuro in un’area protetta… E anche ad un osservatore esterno come può essere un occidentale, di questa giornata resta molto di più delle foto scattate, restano i sorrisi e l’ospitalità dei locali, resta il segno indelebile del cuore che batte quando ci sentiamo in pericolo, resta l’assaggio di una grande cultura.
Prima di partire mi ero documentato moltissimo sul web e avevo persino trovato un film afghano bellissimo: Buzkashi Boys che racconta la storia di questo ragazzino che sogna di salire su un cavallo e andare a prendere la sua pecora e vincere, un corto di 27 minuti che però mi fece emozionare non poco quando vidi come era girato, la forza delle immagini che conteneva…
Cercando in internet mi è capitata un’altra scena di un film molto più famoso: Rambo 3 girata in cui il protagonista Sylvester Stallone irrompe con il suo cavallo in mezzo al deserto a gareggiare al galoppo per prendere la malcapitata pecora.
Fatti i convenevoli, quando vengono ritirati i bicchierini del the, l’ospite deve capire che il padrone di casa lo sta invitando ad alzarsi per iniziare a prendere congedo. Ci si ringrazia a vicenda per l’ospitalità e la compagnia, ma quando arriva il momento bisogna salutarsi e andare. Non è mai l’ospite ad andare, ma il proprietario della casa a prendere l’iniziativa.
Foto e parole di: Roberto Gabriele

Se ami viaggiare, ma viaggiare veramente, Samarcanda non può mancare tra i viaggi che devi fare, o che hai già fatto. E anche se non ci sei mai stato, sai già che Samarcanda si trova lungo l’antica Via della Seta, la strada carovaniera che univa l’Oriente e l’Occidente, Pechino a Roma passando per tutta l’Asia Centrale, la Turchia, i Balcani per arrivare in Italia. La via percorsa da Marco Polo.
Samarcanda quindi non è solo il titolo di una famosa canzone nè di una città mitica e ormai scomparsa, anzi… Samarcanda oggi è una città frizzante, piena di vita e di turismo, che mantiene integra la sua bellezza antica insieme ad uno stile di vita occidentale ma allo stesso tempo molto legato alle tradizioni.
Siamo in Uzbekistan, molti di noi non lo hanno neanche studiato a scuola, semplicemente perchè all’epoca non esisteva neanche sulle carte geografiche, era ancora una delle tante, sconosciute, Repubbliche Sovietiche.
Vedere questa città per molti viaggiatori è vivere un sogno che magari attende da 10 o 20 anni di essere realizzato. Arrivare qui ed entrare nella Piazza Registan illuminata al tramonto è un’esperienza che ti lascerà senza fiato, sentirai un senso di appartenenza a qualcosa che già faceva parte del tuo DNA.
A Samarcanda la cosa più famosa sono le tre enormi madrasse, ossia le scuole coraniche che con i loro minareti costituiscono i tre lati di una piazza di rara bellezza. Le madrasse sono aperte al pubblico dei visitatori anche non musulmani: qui l’Islam è una religione molto sentita perchè moderata, pacifica e accogliente. Gli Uzbechi sono un popolo sorridente, e sorridendo mostrano con orgoglio i denti d’oro che nella loro cultura vengono apprezzati come un vezzo estetico e come status symbol del livello sociale.
Il periodo d’oro di questo Paese fu quello di Tamerlano, un conquistatore che creò un regno enorme ed efficientissimo, la Via della Seta qui mostra ancora i suoi antichi splendori con edifici decorati con maioliche coloratissime e disegni geometrici che a ben guardare sono versetti del corano stilizzati. Sono stato già 3 volte in Uzbekistan a fare foto: la lunga strada che attraversa il Paese, i suoi caravanserragli, le stazioni di sosta degli animali, i mercati straordinari di scambio delle merci ancora oggi si distinguono per la varietà dei prodotti che si possono trovare. Dai tappeti alle sete più raffinate, dall’artigianato al pane che si presenta in ogni forma e viene cucinato con le tecniche più diverse che merita un’attenzione particolare.
I commerci nei secoli hanno unito culture lontane, hanno fatto incontrare viaggiatori lungo le loro strade, hanno portato benessere a chi li ha praticati e a chi di essi si è giovato per migliorare la propria vita. In effetti qui la gente sta bene, c’è una cultura molto pacifica e accogliente nei confronti di chi passa in viaggio da queste parti e si ferma anche solo per un thè prima di riprendere il suo cammino.
Viaggiare lungo la Via della Seta ti fa sentire molto forte proprio questa “presenza” di altri viaggiatori che prima di te hanno percorso quella strada, trovandola nei secoli sempre uguale a sè stessa, con le sue moschee e minareti, le stazioni di posta, le botteghe degli artigiani che ancora oggi si affacciano su di essa. La Via della Seta va vissuta dai viaggiatori di oggi come quelli del passato nel ricordo e nella percezione della sua importanza storica e culturale.
In tutto l’Uzbekistan, il 21 marzo si celebra il Navruz: la festa più importante dell’anno che in tutto il Paese da il benvenuto alla Primavera. In ogni quartiere, in ogni città, in ogni villaggio del Paese ci si riunisce per festeggiare con riti che richiamano alla tradizione uzbeka.
I festeggiamenti possono essere celebrati in vari modi a seconda delle usanze del luogo. Mi è capitato di vedere due volte questa festa, in un villaggio piuttosto isolato nei pressi di Samarcanda. Occorre arrivarci, sapere dove si trovano certi eventi perchè assistervi non è così semplice, spesso si rischia di arrivare solo ad una tavolata comune a cielo aperto, una sorta di pranzo di quartiere… Io invece con la mia guida sono riuscito ad arrivare in questo posto nel quale più che una vera piazza come la intendiamo noi c’era uno slargo sterrato tra le casette dell’agglomerato urbano e lì si svolgeva la festa.
Gli uomini, riuniti in quadrato intorno ad un grande tappeto da gara imbottito come una sorta di tatami artigianale, si esibiscono rigorosamente tra loro in un torneo di Kurash, la lotta libera locale nella quale sono fortissimi. Gli incontri durano pochi minuti, il giudice di gara non è una persona ma è tutto il pubblico che testimonia la regolarità dell’incontro. Gli atleti si presentano scalzi sul campo di gara indossando i vestiti di tutti i giorni, quelli con i quali vanno al lavoro nei campi, niente divise, nessun abbigliamento da gara, niente rituali di preparazione: la lotta non è violenta e non prevede colpi, ma solo leve di forza per mettere l’avversario con le spalle a terra. Il vincitore dell’incontro porta a casa premi in natura come ad esempio una gallina viva, o un sacco di 25 chili di riso.
Mentre gli uomini lottano, sul lato opposto della piazza, le donne sono invece tutte vestite a festa con abiti coloratissimi dai tipici disegni uzbechi che ricordano molto da vicino le matrioske con i loro fazzoletti annodati sulla testa e un tipo di trucco che unisce le sopracciglia rendendo sul viso l’effetto di una specie di onda molto caratteristico. I loro vestiti sono pieni di merletti, di ricchi copricapo decorati, a vestire con grande eleganza e femminilità. Si esibiscono in danze e improvvisate, sfilate di moda che servono alle ragazze anche per trovare marito mostrandosi nel migliore dei modi a quelle che sono le loro potenziali future suocere che potrebbero intercedere a loro favore nei confronti dei figli maschi. Non pensare a matrimoni combinati, a obblighi di sposarsi con persone stabilite dalla famiglia, vedila piuttosto come una presentazione informale tra le famiglie che esprimono in partenza il loro gradimento per il formarsi della coppia che poi è completamente libera di piacersi o no.
Le donne danzano con grazia e con gioia mentre i loro uomini combattono. Questo è il Navruz, ma non finisce qui. In altri villaggi la disputa si fa con uno sport chiamato Buzkashi. Si tratta di una gara piuttosto cruenta nella quale la palla è sostituita da una pecora decapitata che ha le modalità di contesa tipiche del rugby fatto però a cavallo e la pallacanestro poichè per segnare punti il malcapitato animale viene gettato in una buca o in un pneumatico di camion. Si tratta di feste davvero isolate, momenti di grande tradizione e storia ai quali è difficile assistere sia perchè lontani dai normali percorsi turistici, sia perchè occorre avere una buona guida che sappia trovarli e anche questo non è assolutamente facile, nè è sicuro che si riesca ad assistervi.
Per tutti , poi, il Navruz termina con una enorme tavolata in strada a cui prende parte tutto il villaggio e i fortunati ospiti che sono riusciti ad arrivare fino a lì come è stato nel mio caso. Anche questa va vista con un occhio attento alla cultura, la tavolata infatti si fa nelle case, non in strada, ed è rituale: ha una apparecchiatura estetica e molto curata con cibi che hanno un valore simbolico, come ad esempio i dolci che sono l’augurio ad un anno dolce, un piatto con germogli di grano fioriti che rappresentano la fertilità della terra, i frutti della campagna che sono arance e mele che per il loro odore rappresentano il piacere e la frutta secca, tipico cibo dei viandanti. Il tutto accompagnato rigorosamente da una tazza di thè caldo. Nelle tavolate in piazza invece mangerai grigliate di pecora, maiale, manzo e salsicce tipiche, il tutto condito con buonissime salse di ceci o di sesamo.
In alcuni casi, infine, potrà ancora capitarti di vedere i salti rituali del fuoco a fine serata. Sono dei riti di passaggio e prove di ardimento, viene celebrato l’alternarsi delle stagioni saltando dei falò che vengono arsi in strada. Oggi questo tipo di rito è più raro da vedersi perchè ci sono normative di sicurezza che in città impediscono di appiccare incendi nelle strade, può capitare di vederli ancora ma sempre più raramente nelle campagne.
E se vuoi seguire le mie tracce alla ricerca delle particolarità più belle dell’Uzbekistan, devi proprio uscire dagli itinerari tradizionale turistici, lasciare la Via della Seta alle tue spalle e proseguire verso nord, seguendo la strada diretta in Kazakistan, e arrivare sulle sponde di quello che fu il Lago Aral, lì ci sarai solo tu. Ci vuole un intero giorno di auto da Khiva per arrivare fino qui. Un angolo di mondo completamente sconosciuto al turismo che è il teatro di uno dei più grandiosi scempi ecologici della storia: un intero lago di 300 chilometri di diametro è stato completamente prosciugato per irrigare i campi di cotone che si trovano a monte del fiume immissario.
Oggi il lago Aral è un deserto arido e salato sulle cui sabbie giacciono centinaia di barche arrugginite ormai definitivamente arenate su quello che un tempo era il fondo. Dal punto di vista fotografico è una situazione bellissima in cui scattare, ma dal punto di vista sociale ed economico questa è una piaga della quale dopo più di 30 anni ancora non si riesce a riprendersi, ormai il lago è definitivamente morto. La gente che viveva di pesca sulle sue sponde, di commercio e trasformazione del pesce è rimasta senza lavoro e la vecchia enorme fabbrica in cui veniva inscatolato, è ormai un luogo decadente e abbandonato, nella città semideserta restano ormai solo pochissime persone. Per arrivare fin qui occorre un intero giorno di auto da Khiva, poi occorre cambiare i mezzi e prendere i fuoristrada per poter entrare in sicurezza sul fondo ormai desertico del lago e spostarsi alla ricerca dei vecchi relitti navali.
Dopo il lago Aral, inizia il rientro verso casa, in aereo si ritorna alla capitale Tashkent per poi tornare con un volo via Mosca. La Via della Seta è ormai lontana, ma sento ancora la grande influenza che ha avuto nella mia vita e nella mia voglia di conoscere, scoprire e fotografare il mondo.

Sono a Paro (Bhutan) per assistere allo Tsechu 2019, una delle festività religiose più importanti del Buddismo Tibetano.
Mi ritrovo catapultata in un mondo fuori dal tempo, inizialmente l’obiettivo è quello di documentare l’esibizione di teatro/danza dei monaci che si svolgerà davanti al Tempio. Dopo pochi minuti sono talmente assorbita, nel vero senso della parola, dalla calca sugli spalti che finirò per dimenticarmi dello spettacolo.

Non è facile muoversi ne’ camminare liberamente, la gente è tanta e tende ad aumentare con il passare delle ore, per lunghi momenti sono bloccata in mezzo ad una folla eccitata e coloratissima in cui a causa del mio abbigliamento scuro non riuscirò mai a mimetizzarmi, non mi resta altro da fare che immergermi in questa colorata umanità.

Accade tutto nella maniera più spontanea, ogni gruppo di persone presso le quali mi fermo mi accoglie come una di loro. La caratteristica degli Tsechu è che non ci sono quelli che noi chiamiamo “punti di ristoro” tutto il necessario per la giornata è portato da casa, io sono piuttosto impreparata e ho con me solo la macchina fotografica, così mi ritrovo a condividere snack e succhi di frutta potendo ricambiare solo con un sorriso.

Non avrò più modo di guardare l’esibizione dei monaci, un muro umano si frappone tra me e le danze, il mio spettacolo inaspettato sarà la gente, farò parte delle loro risate, dei loro momenti di gioco, delle loro arrabbiature, delle loro preghiere e anche dei loro malori; è una tipica giornata dell’autunno Himalayano, si passa in un attimo dalla pioggia al sole battente ed è facile rimanere storditi senza la possibilità di trovare un riparo.

Continuo ad avanzare lentamente tra le famiglie in festa, scattando foto non a tutto quello che vedo ma a tutto quello che vivo, sentendomi parte integrante di questa straordinaria comunità chiamata mondo.

Mi piace immaginare che per le persone che ho conosciuto quel giorno, lo Tsechu 2019 verrà ricordato anche per l’incontro con uno strano personaggio che si aggirava sugli spalti con una macchina fotografica. Ero senza cibo ne’ acqua ma cercavo di interagire con tutti attraverso gesti gentili e sorrisi.

Mettersi in viaggio in fondo vuol dire entrare per assistere ad una rappresentazione teatrale e ritrovarsi a partecipare ad uno spettacolo di vita.


Alla fine del 2019, inizio a viaggiare per le città e i villaggi Kurdi documentando i sacrifici dei peshmerga curdi nella lotta per reprimere l’ISIS.

Il progetto mi ha portato nelle province del Kurdistan iracheno a parlare con diverse centinaia di Peshmerga, scattando ritratti intimi dei combattenti feriti, delle loro famiglie e documentando sia le storie della battaglia che le loro continue lotte per navigare nella vita post-conflitto.

Attraverso il lavoro ho trovato storie di immensa sofferenza. Combattenti che hanno imbracciato le armi, non perché fossero obbligati a farlo, ma perché era giusto ed era quello che si doveva fare.

Questi uomini, spesso combattendo fianco a fianco con fratelli, zii, cugini, padri e figli, sapevano che era in gioco la libertà e la sopravvivenza del loro popolo.

Mentre raccontavano le storie di aver visto la famiglia e gli amici uccisi davanti a loro, e di battaglie a cui non si aspettavano di sopravvivere, piangevano contemporaneamente per le perdite e per l’orgoglio di ciò che i loro compagni avevano fatto.

Quasi tutti gli uomini hanno mostrato gravi lesioni fisiche. Braccia, gambe e occhi persi. Corpi così crivellati di ferite da proiettili e schegge che il semplice movimento creava un dolore tremolante.

Questi uomini mostravano anche i segni del pesante fardello dei traumi mentali, del disturbo da stress post-traumatico e dei ricordi che non li avrebbero abbandonati. Nonostante tutto quello che hanno sofferto, hanno spesso detto che sarebbero tornati di nuovo alla lotta se mai fossero stati chiamati a farlo. Lo farebbero per i loro figli, per le loro famiglie, per la loro gente e per il resto del mondo.

Tragicamente, la loro sofferenza non finisce con il ritorno a casa poichè lì gli uomini affrontano nuove sfide, come ottenere arti protesici, cure continue e devono provvedere alle loro famiglie nonostante le lesioni debilitanti e altro ancora.
Inoltre è questo il momento in cui si chiedono se darebbero tutto per aiutare a proteggere il mondo, se il mondo li aiuterà o li dimenticherà ora che hanno riposto le loro armi.

Infine spero che, attraverso questo lavoro di esplorazione delle questioni umanitarie di conflitto e postbellico, il mondo possa capire meglio ciò che i Kurdi, la loro terra e le loro famiglie hanno subito e con loro, di fatto, tutto il resto del mondo.
Finalista al Travel Tales Award 2021

Trovati gli sponsor, ricevute le Yaris gentilmente offerte da Toyota, eccoci al via verso la Russia. Siamo in tre: il grande viaggiatore, io ed il cameramen.

Questa volta andiamo alla ricerca di Rasputin. Il tempo sembra porti neve quando raggiungiamo Tyumen , siamo poco distanti da Porovoskoe, la nostra meta.
Il tempo psembra essersi fermato. Le casette colorate, ma sbiadite, non danno segni di vita. Un piccolo market sembrerebbe essere l’unica cosa nuova. L’emozione è grande.

Il sogno è diventato realtà. Siamo a Porovoskoe, il villaggio in cui Rasputin nacque e da cui un giorno partì a piedi per San Pietroburgo, anzi alla sua conquista. Noi abbiamo però un compito, trovare Victor, e lo troviamo.

E’ lui il frutto del peccato tra la sua bisnonna e Rasputin, ecco il legame che lo lega e lo fa assomigliare al mitico consigliere mistico russo. Ci accoglie, si traveste e ci racconta la sua storia. Impreca, gesticola, chiede sigarette, ci sfida ma non ha timore delle nostre macchine fotografiche.

La strada ci aspetta, dopo questo fantastico incontro il nostro compito è quello però di ripercorrere a tappe il suo percorso verso San Pietroburgo.
Raggiungiamo così Kurgan per arrivare a notte fonda a Celjiabinsk. Grande città ricca di palazzoni tristi…

Gli Urali ci attendono… il viaggio è ancora lungo. Arriviamo a NiznyNovgorod dopo una tappa di 12 ore di guida, di neve e di ghiaccio. Siamo stanchi ma non molliamo. Ecco all’orizzonte a San Pietroburgo.

Visitiamo la città, si respira il Natale. La neve la rende più bella, romantica, misteriosa. Ripercorriamo i luoghi storici a completamento della storia di Rasputin: la casa Jusupov e il fiume Neva dove lo hanno gettato dopo averlo assassinato. Chiediamo di Rasputin a tutti, ma le risposte sono forzatamente poche.

Il mistero continua. Santo o avventuriero, profeta o visionario, bandito o gentiluomo, non sapremo mai chi era veramente Rasputin, credo sia giusto così. La storia deve continuare con i suoi segreti, con i suoi dubbi, con le nuove scoperte… A noi rimane il ricordo d’aver toccato la Siberia, la terra che dorme, e forse senza volerlo ci ha cambiati dentro.


Questa è la storia dell’Ultimo Zampognaro d’Italia. Dicembre è il mese di Natale, e mentre la tradizione anglosassone porta l’immaginario collettivo tra renne e abeti innevati accompagnati dal suono di jingle e campanelle, le atmosfere legate al Natale italiano si caratterizzano con presepi, paesini illuminati e per il caratteristico e inimitabile suono delle zampogne.
In Molise c’è Scapoli, il paese delle zampogne: qui persino la musica di attesa del centralino del Comune è suonata con la zampogna.

Scapoli è il tipico paesino appenninico adagiato sul costone della montagna: ci troviamo in Provincia di Isernia, ai piedi del Monte Marrone, nella catena delle Mainarde, teatro dell’omonima Battaglia del 31 marzo 1944 che servì a far indietreggiare la linea Gustav dell’esercito tedesco arroccatosi sulla cima. Oggi solo 600 anime popolano questa piccola località che in 20 anni si è quasi dimezzata per numero di abitanti.
Scapoli è una località fuori dal tempo che cerca di resistere alla fuga dei giovani verso le città: il centro storico ha solo una strada che è il corso del paese, l’ufficio postale, il Comune e 2 bar che sono il vero centro centro di aggregazione sociale degli Scapolesi, ovviamente c’è la chiesa, un minimarket e un camioncino che porta la frutta fresca in piazza ogni giorno. Alla sommità del paese ci sono i bastioni fortificati della città vecchia e il Cammino di Ronda che ancora oggi costituiscono la passeggiata da fare nelle sere d’estate.
A metà aprile a Scapoli può anche nevicare: siamo alti in quota e siamo lontani dal mare, le stradine sono deserte e silenziose, tra i suoi vicoli si sentono solo i garriti delle rondini che riempiono il cielo, nessuna voce, nessuna auto, nessuna musica: a Scapoli si può perdere l’equilibrio perchè il silenzio è talmente profondo da essere destabilizzante.

Ma il paese si riempie di orgoglio due volte all’anno: a Carnevale quando viene fatta la festa del Raviolo Scapolese, e d’improvviso il paese si riempie di migliaia di persone che vengono a mangiare questa specialità che non ha uguali nella cucina italiana: è un raviolone enorme, la porzione normale ne prevede solo 3 in un piatto. Poi per mesi, si ritorna nel silenzio fino a fine luglio quando c’è il Festival Internazionale della Zampogna (da due anni sospeso a causa del covid) il quale raccoglie ancora più persone che arrivano fino qui per partecipare a questo evento unico al mondo. Poi di nuovo il silenzio e la vita tranquilla con i ritmi di una volta, quelli che mancano a chi vive in città…

Nel 2014 alla zampogna di Scapoli è stato persino dedicato un francobollo di Poste Italiane proprio per celebrare il valore culturale di questo strumento musicale, inoltre qui si trova il Museo Internazionale della Zampogna, purtroppo anche questo al momento è chiuso a causa della pandemia e per successivi lavori di ristrutturazione che promettono saranno finiti nella primavera 2022.
Ma la zampogna non va vista in una bacheca, va ascoltata, va vissuta come i pastori, insieme ai pastori: è uno strumento che non può prescindere dalle sue origini. Strumento antichissimo, usato già dagli antichi romani (che all’epoca lo chiamavano Utriculus ossia “otre”), la zampogna è parte integrante del rapporto tra l’uomo e le sue greggi. L’esperienza più straordinaria alla quale si possa assistere è ascoltare il suono della zampogna in montagna, con i musicisti vestiti da pastori con i loro gilet di pelliccia, i camicioni bianchi o a quadri, i pantaloni di velluto alla zuava infilati nei calzettoni di lana e con le tipiche “ciocie” ai piedi e annodate sui polpacci: La ciocia è la scarpa che qui un tempo era così diffusa tra la gente da dare il nome di Ciociari a tutti quelli che le indossavano e anche la Ciociaria (che si stende in tutto il basso Lazio tra le provincie di Frosinone e Latina) prende il nome da questa gente e dalle loro calzature. Tutti vecchi ricordi, tradizioni ancora vive nel cuore della gente che però li ha persi nel loro valore di quotidianità…

L’unico eroe che è rimasto attaccato in tutti i sensi alla cultura della sua terra è il Maestro Franco Izzi. Un uomo, un pastore, l’ultimo zampognaro rimasto che ha deciso di vivere e lavorare costruendo zampogne, altri artigiani realizzano zampogne, ma lui è l’unico che ancora lo fa per professione.

Sono stato un paio di giorni con questo uomo forte e deciso, di solidi principi e dal carattere apparentemente introverso. In realtà Franco Izzi dietro la sua coriacea scorza da pastore, da montanaro, nasconde una grandissima voglia di socializzare e di condividere il suo sapere, la cultura popolare nella quale è cresciuto e della quale è un vero ambasciatore con noi “gente di città”.
Ero andato fino a Scapoli per intervistarlo, per fargli un pò di domande sulla sua musica, sul suo lavoro, sulle zampogne… Al primo incontro mi ha spiazzato: non ci eravamo mai visti ma lui mi ha accolto come un vecchio amico invitandomi a pranzo, un indimenticabile pranzo frugale e straordinario: si mangia quello che c’è, come si farebbe con un ospite di famiglia.
Capii subito che c’era molto da imparare da quest’uomo. Un bel piatto di pasta, una bistecca di bovino allevato in libertà e una bella insalata mista. Semplice e naturale. Osservai le grandi mani di Franco abbracciare il pane e tagliarlo con cura, con il rispetto rituale che si ha per le cose sacre. Quelle mani sagge mi davano sicurezza, mani forti di campagna abituate a lavorare: mani da zampognaro, così diverse da quelle di un pianista.

La casa di Franco la trovai bellissima, senza tempo, il calendario in cucina fermo a dicembre 1956, tutto era semplice e incredibilmente accogliente, senza fronzoli: pietre a vista sui muri, un tavolo, le sedie, una poltroncina e il caminetto che, oltre a riscaldare l’ambiente, ci è servito per cucinare la bistecca. Davanti a noi i suoi quattro cani, ordinatamente seduti sul divano, ci osservavano armeggiare per preparare il pranzo.

Franco è un filosofo, ha il buon senso tipico della brava gente, di quelli che vivono tra regole dalle quali vorrebbero scappare. Il tempo a tavola con lui è volato veloce: i sapori, i profumi, gli argomenti di discussione sono stati vari ma ancora non riuscivamo a parlare di zampogne… Ero venuto apposta per parlare di questo, ma mi accorsi che c’era molto di più in quest’uomo da ascoltare, da imparare… Dopo pranzo, verso le 15, mi fece fare il giro di casa: nell’altra camera c’era il pc, la tastiera con la quale studia musica…

Ad un certo punto si allontanò e quando ritornò era vestito da zampognaro: quello era il momento di parlare di musica e Franco iniziò ad indossare i panni del grande esperto: mi parlava di toni, semitoni, ottave e chiavi, mi spiegò esattamente come funziona la zampogna, la sua storia, le dimensioni, le difficoltà per suonarla e gli accorgimenti costruttivi per costruirla, mi parlava di bordone e di canto, di otre e di campana…
Io lo ascoltavo affascinato senza purtroppo riuscire a capire altro che la sua enorme passione, la competenza che metteva e mette ancora oggi nel suo lavoro. Mi rendevo conto di avere davanti a me una pietra miliare, un testimone e un protagonista della storia della musica tradizionale italiana, questo clima di armonia mi ispirava a fotografare ogni cosa che avevo davanti ai miei occhi in quel momento.

Franco mi parlava con comprensibile orgoglio del suo “Bordone Modulabile” da lui inventato e poi brevettato a Campobasso: una innovazione che ha portato la zampogna a diventare uno strumento completo, ovvero con la possibilità di avere tutto il giro armonico della propria tonalità. Una lezione di musica, di scale, di tonalità e armonie… Pur non capendo restavo incantato ad ascoltare il suo modo di esporre i concetti.

Ma in casa si parla tra persone, ma per parlare di musica siamo scesi dove la musica si costruisce, ossia nella bottega. “Casa e bottega” si dice, e qui è davvero così: alla bottega si accede direttamente dalla scala interna di casa.

E mentre io impazzivo in quella bottega profumata di essenze di legno stagionato e per quella luce con intensità variabile “a zone” diversa in ogni angolo della stanza, Franco mi mostrava con le sue mani forti tutti i procedimenti costruttivi delle sue zampogne. Eccolo quindi a raccontarmi della realizzazione dell’ancia e la tornitura delle canne. Poi mi mostrava i suoi legnami invecchiati per 8 lunghi anni prima di poterli lavorare per farli diventare canne o bordoni di una zampogna…

Franco il suo museo della zampogna privato se lo è fatto nel laboratorio e tra una spiegazione e l’altra mi portò fuori, nel vicoletto, poi si mise nascosto dietro una delle finestre del Cammino di Ronda che faceva da cassa armonica e abbracciando la sua zampogna da 32 iniziò a suonare riempiendo delle sue note tutta la valle.
Una sorta di flash mob con il quale marca di tanto in tanto il territorio: il suo concerto improvvisato serviva a ricordare a tutti che lui è veramente l’ultimo zampognaro.

Ma l’indomani Franco mi invitò di nuovo a pranzo: per me aveva ancora qualcosa di veramente speciale, prima di salutarci decise di esibirsi in un concerto privato solo per me al Monumento ai Caduti di Monte Marrone. Un momento veramente toccante, vibrante, un grande omaggio a tutte le Vittime della guerra cadute da ambo le parti.
Franco non esitò neanche un attimo: si arrampicò a diversi metri di altezza su una serie di blocchi di cemento sovrapposti (uno per ciascuna Regione Italiana) e da lì sopra iniziò a suonare le sue note: la “Ninna nanna del bambino” un pezzo appositamente composto da lui per questo luogo. Salì in alto perchè il vento potesse portare la sua arte lontano e donarla a chi non ha potuto ascoltarla in vita…

E sulle note potenti e acute delle ance della zampogna arrivò per me il momento di tornare a casa. Grazie, Maestro: mi hai donato la tua amicizia, la compagnia dei tuoi cani, la luce del tuo laboratorio che odora di legno resinoso… E infine mi hai regalato l’arietta fresca delle tue verdi montagne molisane.

Foto e parole di Roberto Gabriele


Comunque sia, l’epica (o più correttamente la contro-epica) della sconfitta è ciò che rende umani quegli eroi originariamente predestinati, ma che alla fine non ce l’hanno fatta, come accade a volte “all’uomo qualunque che è il vostro papà”( BattistiMogol) nell’affrontare certi giorni della vita.
“Elogio della sconfitta” lo ha definito una maestra, Rosaria Gasparro, in piccolo testo dal senso educativo che circola da un po’ sulla rete, memore di quella “nobiltà della sconfitta” pubblicato da Ivan Morris negli anni ’70. E probabilmente è quella fragilità del perdente che ci fa sentire umanamente vicini ad uno come il capitano della marina inglese Robert Falcon Scott.

Se possibile, uno al quale è andata ancora peggio di un leggendario secondo come Dorando Pietri: oggi, 14 dicembre 2021, ricorrono i 110 anni dalla conquista del Polo Sud da parte di Roald Amundsen, che precedette di soli 34 giorni la spedizione guidata appunto dal capitano Scott. Il quale, dopo aver perso il primato, nel viaggio di ritorno perse anche la vita per una serie di circostanze avverse insieme ad altri 4 compagni, Edgar Evans, Edward Wilson, Henry Bowers e Lawrence Oates.

“Dal 21 abbiamo avuto una tempesta da ovest-sud-ovest e sud-ovest – si legge nell’ultima pagina del diario di Scott datata giovedì 29 marzo 1912 – avevamo combustibile per fare due tazze di tè a testa e cibo per due giorni, il 20.
Ogni giorno eravamo pronti a partire per il deposito a sole undici miglia da qui, ma fuori della tenda infuria la tormenta.
Non penso che si possa più sperare. Lotteremo fino all’ultimo, ma stiamo diventando sempre più deboli e, naturalmente, la fine non può essere lontana.
Peccato, ma non credo di poter ancora scrivere. Abbiamo corso dei rischi. Sapevamo di correrli. Le cose si sono rivoltate contro di noi. Non abbiamo motivo di lamentarci. Se avessimo vissuto, avrei avuto un racconto da fare sulla durezza, resistenza, e coraggio dei miei compagni che avrebbe commosso il cuore di ogni inglese. Queste rozze note e i nostri corpi morti dovranno raccontare questa storia.”

E poi l’ultima nota, lucidamente rassegnata, “Per l’amor di Dio, pensate ai nostri parenti.”

Eppure, nonostante il fallimento della missione, è proprio Robert Scott piuttosto che Amundsen ad essere circondato da un’aura leggendaria . A lui sono dedicati libri, fra i quali “Ultimo parallelo” di Filippo Tuena, uno dei romanzi italiani più importanti degli anni Duemila, una canzone certamente non indimenticabile (www.youtube.com/watch?v=YM7oBjeQuyQ) , e un profilo Twitter (https://twitter.com/captainrfscott) che in 2797 tweets tratti dai diari di Scott ne ripercorre tutta la vicenda, fino a quell’ultimo “tweet” del 29 marzo. I diari di Scott, appunto: se l’uomo che accetta di perdere suscita simpatia, questo comunque non basta alla costruzione del mito, c’è dell’altro.

A differenza di Amundsen, un ordinario elencatore di eventi, Scott era molto bravo con la parola scritta, un autentico narratore che ha reso i suoi diari avvincenti, oltre che ricchi di informazioni preziose. Ma soprattutto, per comprendere la fortuna postuma di Scott basta guardare queste foto, che ci catapultano immediatamente nel cuore di una storia simile a un film, resa ancora più affascinante dalla consapevolezza dell’epilogo tragico.
Se Amundsen portò con sé una macchina fotografica che si ruppe abbastanza presto durante il viaggio, per cui la maggior parte delle foto sopravvissute sono quelle scattate da Olav Bjaaland con la propria macchina fotografica, certamente non un fotografo esperto, Scott, già consapevole della grande efficacia comunicativa della fotografia, portò con sé il fotografo professionista e direttore della fotografia Herbert Ponting.

E proprio le foto di Ponting si possono considerare le principali artefici della costruzione di un monumento alla memoria della spedizione Scott, un documento di grande bellezza formale oltre che di narrazione non convenzionale per l’epoca, fatto soprattutto di momenti in-between. Come non sentirsi coinvolti dalla calda atmosfera di chiacchiere miste all’odore di tabacco che si crea davanti alla stufa a legna, o dei momenti di relax nella stanza delle cuccette; come non immaginare i momenti di solitudine di quegli uomini dai pensieri rivolti ai propri cari lontani mentre coltivano una strana normalità, suonando un pianoforte o giocando con dei pinguini.

Scott e gli altri 4 compagni furono ritrovati un paio di settimane più tardi dai sopravvissuti della spedizione, che per commemorarli eressero una croce di legno con l’iscrizione di un verso dell’Ulisses di Tennyson: “Lottare, cercare, trovare e non arrendersi”.

Facebook: https://www.facebook.com/attilio.lauria


Lisbona è una Capitale a misura d’uomo, una città “mediterranea” che si affaccia sull’Oceano Atlantico, questo che sembra un ossimoro geografico in realtà non lo è dal punto di vista culturale! Pur essendo lontana dai nostri mari, Lisbona già esisteva in epoca Romana e ha mantenuto nella gente molto del carattere latino a partire dalla lingua che ancora oggi qui si parla. Ma qui ci si sente come a casa, il calore delle persone è quello tipico nostrano: si viene sempre accolti con la sincera schiettezza di un sorriso.

Una città romantica nelle cui stradine è bello “perdersi”. Nei vicoletti silenziosi in cui si ode il vociare operoso della gente locale ci si sente come a casa. Si sente il rumore dei passi che echeggiano tra le casette basse e si è lontani dal traffico e dalle auto. Qui è difficile per loro circolare a causa delle scale che sostituiscono le strade nei tratti più ripidi in salita. A Lisbona, il rumore più forte che si sente è quello del frullino di un muratore che sta ristrutturando un appartamento per farlo diventare un B&B con vista sulla città.
C’è poi il rumore piacevole dello sferragliare del tram della linea 28 che attraversa la città e si arrampica su ardite salite con strettissime curve. Passa sfiorando gli angoli delle case a pochi centimetri. Se si evitano le strade della movida, le uniche cosa che si sentono sono il rumore dei passi, la musica gracchiante di una radiolina che arriva da una finestra aperta o lo struggente Fado che arriva da qualche locale di Chiado.

E’ bello camminare a piedi e scoprire degli angolini deliziosi dovunque: Lisbona non ha la grandeur parigina, nè l’imponenza imperiale di Vienna nè il brulichio impiegatizio dei manager nella city di Londra. Questa è una città per sognare e rilassarsi. Andando ad esplorare i suoi vicoletti, ci si rende conto che la gioia è nelle piccole cose, nello scoprire qualcosa avendo l’impressione di essere stati i primi ad accorgersene.
C’è una certa decadenza che non è mai abbandono, è il fascino del tempo che segna questa città i cui palazzi sono ben restaurati accanto ad altri che mantengono la loro dignità nobiliare pur essendo caduti in disgrazia. E’ quello che è accaduto al Convento do Carmo la famosa chiesa rimasta poi per sempre totalmente senza tetto in seguito ad un terremoto e mai più ricostruita: inarrivabile la bellezza delle sue navate gotiche attraverso le quali è possibile vedere la meraviglia del cielo.

Anche i tram e le teleferiche portano il fascino delle cose vecchie che ancora sono belle e funzionanti e che nessuno ha voglia di sostituire. La linea 28 è la più famosa di Lisbona, a bordo ci sono forse più borseggiatori che passeggeri, ma un giro sul più famoso tram del mondo è impossibile da perdere.

Spesso in fondo alle strade del Bairro Alto si scorge il mare: una presenza costante in tutta la città, di cui è impossibile non tener conto. E se Roma è famosa per i suoi Sette Colli, anche Lisbona è famosa per le sue alture (decisamente più ripide) e per i suoi innumerevoli belvedere dai quali godere di scorci indimenticabili a qualsiasi ora del giorno.
Miradouro da Graça, Miradouro de São Pedro de Alcântara, Miradouro do Castelo de S. Gorge, tanto per citare i più famosi che si affacciano sul centro città, ma il più originale è anche il meno conosciuto e meno turistico: il belvedere è quello che si gode dal camminamento in cima alle arcate del vecchio Acquedotto delle Acque Libere con la vista che spazia fino al Ponte 25 de Abril.

Ogni quartiere è un micromondo ben caratterizzato, con una sua storia e personalità. Si parte dal centro nei pressi della metropolitana Rossio ed è il classico cuore pulsante della città, la parte più turistica e animata, e ci sono una serie di altri quartieri deliziosi come l’Alfama che è il quartiere più tradizionale anche questo arroccato sulla sua collinetta panoramica. Da non perdere il Barrio Alto famoso per la sua vita notturna e il quartiere Oriente nato in occasione dell’Expo ‘98 con le sue architetture moderne e persino una funivia panoramica che corre sul mare.

Poco staccato dal centro, c’è il quartiere che sorge intorno alla Torre di Belem, una zona ad altissima densità turistica ma davvero interessante per il Monastero dos Jerónimos e il panorama della città che si gode dalla cima della torre.
Infine, per i veri intenditori, c’è l’Almada un quartiere di straordinaria bellezza che si trova di fronte a Lisbona, raggiungibile con un comodo battello sulla sponda opposta della grande foce del Tago: è un tipico borgo marinaro con ristorantini tipici sulle sponde del porticciolo e che offrono una vista bellissima sulla città.

Lisbona non sarebbe la stessa se non avesse una costante fissa: ovunque si vada si trovano i suoi famosi Pastis: i tipici dolci alla crema che si vendono ovunque in città.
I Pastis si mangiano uno dopo l’altro: difficile resistere, impossibile non provarli in una famosa pasticceria nel quartiere di Belem dove si può fare una fila di un’ora per aggiudicarsene uno.
E per rimanere in tema gastronomico, l’altra costante è il Bacalao, ossia il baccalà che da queste parti preparano in ogni modo possibile con un occhio alla tradizione e uno all’innovazione.

Lisbona resta nel cuore anche per la sua musica, che come la colonna sonora di un film vissuto in prima persona dal viaggiatore, resta attaccata ai ricordi che lo legano a questa città.
Il Fado con le sue sonorità nostalgiche e raffinate è la musica perfetta per questa città calda, passionale e magnificamente decadente. Ci sono decine di locali in cui è possibile cenare (a base di Bacalao e di Pastis) o bere qualcosa ascoltando il fado cantato dal vivo.
Una serata di fado è indelebile nel dna di chi l’abbia vissuta almeno una volta: i musicisti su una pedana allietano gli ospiti ai tavoli di localini poco illuminati con una musica notturna di grande eleganza apprezzata tanto dai locali, quanto dai turisti.

E per ultimo non si può dimenticare un altro elemento caratteristico della città: le sue maioliche azzurre chiamate Azulejos. Tutt’altro che paccottiglia turistica per vendere souvenir cinesi in Portogallo, queste da sempre vengono usate come elemento decorativo delle facciate dei palazzi più belli ed eleganti: un segno distintivo e caratterizzante di tutta la città e dei suoi dintorni.

Oltre al centro città, intorno a Lisbona ci sono due località imperdibili che meritano sicuramente la visita e si trovano a meno di un’ora di treno dal centro città.
La prima cittadina da visitare è Sintra a cui conviene dedicare una giornata intera: caratteristica non solo per la sua urbanistica e il cinquecentesco Palácio Nacional in stile manuelino con i suoi comignoli conici alti 33 metri e divenuti il simbolo della città, ma anche e soprattutto per il Castelo dos Mouros in stile moresco e Patrimonio UNESCO. E’ una roccaforte adagiata sulle ripide creste di un monte e dai cui camminamenti merlati si domina tutta la città di Sintra fino a Lisbona che si scorge in lontananza all’orizzonte guardando in direzione sudest.

Per finire in bellezza la giornata a Sintra, bisogna necessariamente dedicare un oretta al bizzarro Palácio Nacional da Pena, anche esso Patrimonio UNESCO. Un edificio decisamente originale con i suoi colori decisi e le decorazioni che sono un insolito mix di vari stili rivisitati: neogotico, neomanuelino, neoarabo, neorinascimentale e neobarocco. E’ un luogo fatto per stupire, ironico e divertente. Camminando tra le sue scalette, affacciandosi ai suoi balconcini, esplorando i suoi interni sembra di vivere nelle irreali prospettive di Escher o nei colori fiabeschi di Walt Disney.

La seconda cittadina alla quale non si può mancare è la deliziosa Cascais. A questa si può dedicare almeno una mezza giornata e concluderla con la relativa cena a base di bacalao tra le sue stradine nei ristorantini all’aperto. Il ritorno in treno fino a Lisbona è garantito fino a tarda sera.

Cascais è l’affaccio di Lisbona sull’Oceano: da qui si sente indissolubile il legame con il mare. Da non perdere, con una bella passeggiata che parte dalla stazione dei treni, sono il porticciolo con le sue spiaggette. Il suono della risacca arriva fino alle stradine dei bastioni con vista sul mare. Il faro bianco e blu che si infuoca di rosso al tramonto. I vicoli tipici da borgo marinaro che conducono il visitatore tra tantissimi palazzi decorati con le Azulejos blu come i colori del cielo e del mare che esaltano la bellezza del borgo.

Ora che si può ricominciare a pensare a viaggiare, Lisbona è una meta ideale e facilmente raggiungibile.
Con circa 3 ore di volo e una manciata di Euro (In questo periodo si fa Andata e Ritorno con la Compagnia di Bandiera a 70-80 euro in tutto), è quindi alla portata di tutte le tasche. Si può persino spendere ancora di meno volando con le low cost. Una destinazione così vicina ed economica diventa automaticamente parte dei “luoghi del cuore” per molte persone: si va a scoprirla per innamorarsene. Molti sono gli aeroporti italiani collegati con voli diretti.

Il modo migliore per muoversi a Lisbona oltre a camminare tanto a piedi, non sono i tram, ma la sua fitta rete di treni e metropolitane. Con le sue 4 linee permette di raggiungere ogni luogo di interesse turistico e tutti i quartieri anche più lontani dal centro. Un abbonamento giornaliero a corse illimitate è comodo per muoversi ovunque ad un costo irrisorio.

Per un bel giro della città fatto con calma e approfondito nei contenuti bastano 4-5 giorni pieni più il viaggio, si riuscirà così a vedere un pò tutto ciò di cui abbiamo parlato fin qui e facendosi un’idea del rapporto di questa città con l’Oceano sul quale si affaccia…

Questo Articolo con foto e parole di Roberto Gabriele è stato pubblicato sulla rivista Acqua & Sapone diretta da Angela Iantosca nel numero di ottobre 2021

Oggi ci troviamo in Molise, deliziosa Regione italiana poco più grande della Valle d’Aosta ma quasi totalmente sconosciuta al turismo. In tutta la Regione vivono circa 400 mila abitanti, grosso modo quelli di un popoloso quartiere di una città come Roma o Napoli.
L’ambiente (a parte pochi chilometri di costa adriatica) è quello delle montagne appenniniche, la Maiella è poco distante, il territorio è totalmente verdeggiante con boschi a perdita d’occhio e si trova qualche campo coltivato anche se l’agricoltura non è la principale forma di economia rurale da queste parti.

Ma il Molise non è solo Paesaggi, riesce a stupirci con paesini arroccati e scenografici come Pescopennataro che sembra circondata dalla Dolomiti, o il Teatro Italico di Pietrabbondante che è ancora perfettamente conservato nonostante i suoi 2000 anni di storia. E poi ci sono tradizioni culinarie sempre legate alla società agropastorale e alle vecchie tradizioni come i celebri Ravioli Scapolesi, i sughi fatti con il ragù di pecora, la pasta fatta in casa e salumi locali di produzione artigianale introvabili nei negozi…
Si arriva in Molise in circa 3 ore di auto da Roma, ma vale la pena dedicare a questi luoghi almeno un week end lungo: 4-5 giorni sono l’ideale per scoprirli con la giusta calma, anche perchè le strade anche extraurbane spesso sono strette e la velocità media di spostamento è di circa 50 chilometri orari.

In questa Regione, ci sono -come spesso accade in Italia- delle eccellenze uniche al mondo; una di queste su tutte, vale il viaggio fino a qui. Stiamo parlando della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli che dal 1924 con una Bolla di Papa Pio XI è l’unica al mondo ad avere l’onore di potersi fregiare dello Stemma Pontificio per rappresentarlo nel volto delle campane che qui vengono fuse.
Entrando in questo luogo si sente subito qualcosa di diverso. Già il museo della campana ha cimeli che raccontano 700 anni di storia: qui è conservata la più antica campana firmata Marinelli della quale si abbia data certa che risale al 1339 ad opera di Nicodemo Marinelli (detto Campanarus), ma notizie non provate fanno risalire le prime notizie intorno all’anno 1000…

Dopo la seconda guerra mondiale i Marinelli costruirono il concerto di campane per la Cattedrale di Montecassino, distrutta dai bombardamenti. Il legame di Marinelli con la Santa Sede viene poi ulteriormente celebrato con la storica visita del 19 marzo 1995 di San Giovanni Paolo II. Ma il fascino di questo stabilimento non è tanto la sua storia, quanto la sua sacralità…

L’antica città sannita di Agnone è giustamente nota per essere il “Paese delle campane”, ma il merito della sua fama lo deve proprio alla famiglia Marinelli che da 10 secoli tramanda di padre in figlio la difficilissima arte campanaria e pare che questo sia il più longevo stabilimento al mondo per la fabbricazione delle campane.
Una campana non è e non può in nessun caso essere vista “solo” come un prodotto artigianale. E’ un prodotto che nasce appositamente per creare un legame tra l’uomo e il divino a tal punto che qualcuno dice che le campane sono “la voce di dio”. Ed in effetti, il loro suono che riecheggia anche a grande distanza nasce proprio per chiamare i fedeli ai momenti di rapporto con Dio.
 Anche il momento della fusione del bronzo è qualcosa che va molto oltre la metallurgia ma che rientra nel rituale sacro. Le campane non vengono mai prodotte in serie nè per fare magazzino di pronta vendita, ogni pezzo viene realizzato su commissione con una attenta scelta anche degli elementi decorativi e delle scritte che andranno a rifinire la superficie. Al momento della fusione del bronzo nel suo stampo a cera persa, ci sarà un sacerdote per effettuare la Benedizione del Fuoco. Ecco quindi che anche nelle fasi più concrete e materiali della produzione, c’è la sacralità rituale del momento che viene celebrato con una profondità e una spiritualità che non si trovano in nessun altro procedimento industriale o artigianale.
Anche il momento della fusione del bronzo è qualcosa che va molto oltre la metallurgia ma che rientra nel rituale sacro. Le campane non vengono mai prodotte in serie nè per fare magazzino di pronta vendita, ogni pezzo viene realizzato su commissione con una attenta scelta anche degli elementi decorativi e delle scritte che andranno a rifinire la superficie. Al momento della fusione del bronzo nel suo stampo a cera persa, ci sarà un sacerdote per effettuare la Benedizione del Fuoco. Ecco quindi che anche nelle fasi più concrete e materiali della produzione, c’è la sacralità rituale del momento che viene celebrato con una profondità e una spiritualità che non si trovano in nessun altro procedimento industriale o artigianale.

Dal bronzo fuso nasce la campana benedetta con l’acqua santa che si mescola al fuoco in un rito ancestrale di grande suggestività fatto di arte e preghiera. Molto spesso a questo evento partecipano intere comunità parrocchiali che vanno ad assistere alla nascita della loro campana.

Qui tutto è rituale, ogni gesto sa di antico, è misurato, tramandato di padre in figlio da secoli. Entrare nella sala dei calchi di gesso che andranno a formare le decorazioni che appariranno in bassorilievo sulle campane è un’esperienza mistica. Ci sono migliaia di immagini sacre che possono essere applicate sulla campana a seconda delle necessità. Si possono scegliere immagini della Trinità, della Madonna e praticamente di tutti i Santi, degli angeli e di tutta la simbologia legata alla cristianità. Ma la personalizzazione viene completata con scritte e date commemorative, con preghiere e versetti biblici. Ogni scelta è definitiva, resterà per sempre scolpita sulla campana e anche questo ci fa sentire la sensazione di qualcosa che nasce per essere eterno.

Per creare la campana occorre innanzitutto scegliere la nota, perchè entrando qui la prima cosa che si impara è che il detto “essere stonato come una campana” è del tutto falso! E’ vero l’esatto contrario: le campane sono intonatissime, ciascuna suona una sola nota ma lo fa in modo perfetto seguendo la Scala Campanaria che è un insieme di regole e misure relative allo spessore, al peso, alla circonferenza e all’altezza che sono rapportate tra loro in base al timbro sonoro che si vuole ottenere. E’ possibile calcolare con assoluta precisione il suono che emetterà una volta finita e senza bisogno di ulteriori intonazioni. L’armonia, la matematica e la perfezione divina trovano un punto di incontro nella costruzione di una campana.

Armando e Pasquale Marinelli con i loro figli guidano un’Azienda che esporta eccellenza in tutto il mondo, ma parlando con loro ci si sente a casa, accolti come in una famiglia. Qui non ci sono i ritmi frenetici e l’ansia di fatturato e di produttività di una multinazionale, qui c’è il rispetto per le persone, per i loro gesti, per il tempo che dedicano al lavoro. In questa fucina tutto è etico, sostenibile, naturale, sequenziale. Anche i dialoghi tra le persone sono misurati: qui si parla a bassa voce, non serve urlare perchè non ci sono macchine al lavoro, ma solo uomini e donne che hanno gesti misurati, rituali.
Si percepisce a pelle la passione e la dedizione di tutti per il lavoro che fanno insieme fianco a fianco. Una intera azienda al lavoro per mesi per realizzare un solo pezzo che non ha elettronica per funzionare, che non ha bisogno di essere progettato e disegnato perchè la sua forma è talmente perfetta da non poter essere cambiata in alcun modo. Un solo pezzo di bronzo in grado di essere un prodotto finito la cui nascita, per quanto è perfetto, è già un miracolo. Qui sono la passione e la fede a muovere tutto: un binomio inscindibile.

Parliamo di passione perchè questa Azienda ha un Museo grande esattamente quanto la superficie dedicata alla produzione. Una scelta coraggiosa e generosa quella di dedicare così tanto spazio alla propria storia, a raccontare le proprie origini ma che ha portato Marinelli a produrre anche la campana commemorativa dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Stato e Chiesa si… “fondono” in questo posto.

Entrando nella Fonderia Marinelli si percepisce subito un forte odore di officina, di fumo e terra bruciata e di metalli limati, di concretezza e operosità. Il processo di produzione di una campana è affascinante e dura diversi mesi. Si inizia dalla creazione dell’Anima alla realizzazione del Mantello e della Falsa Campana che è un’intercapedine perfettamente identica alla campana che vi verrà fusa all’interno mediante un procedimento a Cera Persa.
Non è uno spazio silenzioso come potrebbe essere un luogo sacro, ma qui anche i pochi, pochissimi rumori che si sentono sembra che servano a scandire il tempo, il tempo della giornata, il tempo di una vita e di una tradizione plurisecolare.

Nello stabilimento potrà capitare di sentire qualcuno che batte con un martello per togliere l’argilla residua all’interno della campana appena fusa, ma è un rumore ovattato, lento, mai fastidioso, è più vicino ad un tonfo pesante che esce dalle sapienti mani di chi lavora da quando è nato in questa fonderia sospesa tra l’umano e il divino. E ogni tanto il silenzio viene rotto dal Campanaro che verifica con il suo diapason la perfetta intonazione della campana prima di spedirla a destinazione. E’un suono divino, mai fastidioso: che si sia credenti o no, il fascino di questo opificio che trasuda di storia e di qualità è percepito da chiunque.

Benvenuti in Molise, terra di zampogne e campane, di tradizioni ed eccellenze tutte da scoprire. “Il Molise esiste e mena duro” ha detto Maria Centracchio, molisana, quando ha vinto il bronzo nel Judo alle ultime Olimpiadi di Tokyo: una Regione tutta da scoprire.

Questo Articolo con foto e parole di Roberto Gabriele è stato pubblicato sulla rivista Acqua & Sapone diretta da Angela Iantosca nel numero di ottobre 2021


Un’altra occasione di presentazione del TTA, TRAVEL TALES AWARD, sarà Giovedi 11 Novembre alle ore 19.30 da NOC – New Old Camera, in Viale S. Michele del Carso, 4 a Milano presenteremo il progetto e gli output editoriali connessi; i Tre portfoli selezionati da Il Fotografo e pubblicati nel numero di luglio / agosto della rivista, le 4 storie che compongono la sezione Travel Tales sul numero 9 di CITIES, le 21 storie che compaiono nel libroTravel Tales a cura di Simona Ottolenghi. Qui potrete vedere tutte le storie premiate a https://traveltalesaward.com/storie-premiate/
Mostreremo anche le Storie premiate con la mostra attualmente allestita a Roma da Otto Gallery.
Ospitati da Giordano Suaria saranno presenti Angelo Cucchetto, Simona Ottolenghi, Roberto Gabriele, Giovanni Pelloso, Federica Berzioli e alcuni degli Autori selezionati, tra cui Mario Cucchi, Roberto Manfredi, Giuseppina Di Falco, Alessandro Castiglioni e Tania De Pascalis.
Ricordiamo il grande successo del Travel Tales Weekend, 1,2 e 3 ottobre 2021, che è stato il momento conclusivo di una serie di eventi nati per la promozione di progetti autoriali legati alla Fotografia di Viaggio, lanciata da Starring con Photographers.it e Isp in collaborazione con la rivista Il Fotografo, con il supporto tecnico di Viaggio Fotografico.it e di NOC e con il supporto operativo di OTTO Rooms e OTTO Gallery
Saremo a Milano in Viale San Michele del Carso 4 presso New Old Camera.
Oppure clicca su questo link: https://goo.gl/maps/FWfdHbtewbK3XmEq8

“Vanno le carovane del Tigrai…” recitava il ritornello di una canzone scritta durante l’invasione italiana dell’Etiopia, che a ritmo di foxtrot descriveva la discesa delle carovane tigrine verso la Piana del Sale, in Dancalia, il deserto Etiope al confine con l’Eritrea. La canzone dipingeva i nostri soldati non come invasori ma come soccorritori di un popolo che “… giammai conobbe libertà …” e che grazie a noi avrebbe potuto “… andare incontro alla civiltà …”. L’unica verità che traspare tra le molte inesattezze del testo, è la descrizione delle durissime condizioni di vita dei raccoglitori e dei trasportatori del sale.

Le carovane raggiungono all’alba, dopo essersi messe in movimento il giorno precedente, la Piana del Sale. E’ l’ampia area pianeggiante formatasi nella depressione dancala per effetto dell’alternanza, governata dai fenomeni di sollevamento tettonico e di variazione del livello del mare, dei periodi di invasione delle acque del Mar Rosso e delle successive fasi di essiccamento. I sedimenti di questa piana, di spessore variabile da 1 a 3 km, sono tuttora teatro dell’estrazione delle lastre di sale destinate al consumo animale.

Il sale viene cavato dalla superficie e tagliato in forma di tavolette trasportate dalle carovane di dromedari fino alle alture del Tigrai. E’ un’attività che viene svolta per un periodo limitato di tempo nell’anno, tra ottobre e marzo: prima e dopo il caldo è insopportabile anche per gli Afar, l’etnia etiope che cava e dà forma alle tavolette. Oltre al caldo i cavatori devono affrontare l’abbacinante luce riflessa dalla superficie salata, motivo per cui gradiscono particolarmente l’omaggio di occhiali da sole.

Non si sa quanto potrà ancora durare la loro attività, minacciata dall’avanzare di nuove strade realizzate da imprese cinesi che porteranno sulla piana del sale camion in grado da soli di svolgere il lavoro di più carovane, in una frazione del tempo impiegato dal trasporto animale.



Foto e parole di:
Riccardo Panozzo
https://www.facebook.com/riccardo.panozzo.1

Per un viaggio di incontri e foto in Cina, ho scelto il Guizhou. Non avevo interesse per le grandi citta “modernizzate” e neanche per le antichità più note al turismo. Il Guizhou è una regione rurale, dove tuttora l’agricoltura costituisce la base essenziale dell’economia locale. Una regione che vede la presenza di molti piccoli villaggi le cui tradizioni e abitudini stanno si cambiando ma più lentamente rispetto ad altre parti del paese; villaggi con una popolazione media anziana, perché anche qui i giovani, come succede in tutto il mondo, preferiscono trasferirsi nelle grandi città, alla ricerca di modernità e di lavori diversi da quello nei campi.


Complessivamente, ciò che più mi ha colpito in questi piccoli villaggi, e che rimane ben evidente nelle foto scattate, è stata la facilità del rapporto umano con chiunque abbiamo incontrato. Superando spesso a gesti o con l’aiuto della guida la barriera della lingua, quando abbiamo bussato a una porta ci è stato sempre aperto e ho potuto fotografare quanto non mai le persone, sempre ospitali e disponibili, pronti a offrirti una sigaretta, un thè o una parte del loro pranzo, all’interno delle loro abitazioni.

Le prime foto riguardano i Long Form, una tribù dell’etnia Miao, che si caratterizza per le vesti colorate e, soprattutto, per i tipici copricapi di legno ricoperto da matasse nere. Vivono in un’area remota, lontana dai flussi turistici e mostrano con orgoglio i simboli della propria tradizione.


Le altre foto riguardano le attività quotidiane più elementari, spesso legate al pranzo o a un momento di riposo. Ho partecipato anche a un matrimonio, semplice ma incredibilmente rumoroso: di fronte agli sposi un signore accendeva in continuazione batterie di “miccette”, piccole ma in quantità incredibile, e il cui intenso baccano è percepibile anche solo dal fumo ben visibile nella foto e dall’enorme scatola che ne conteneva solo una parte.


In nessuno dei miei viaggi precedenti avevo fotografato così tanto in interno e soprattutto persone. Un viaggio che ha cambiato il mio modo di fotografare e che ha trasformato ogni scatto, preceduto e seguito sempre da un partecipato scambio umano, in una testimonianza di comunanza con il soggetto fotografato; ogni foto rappresenta un volto e una storia a sé stante, con l’unica eccezione dell’ultima, il “villaggio”, necessaria a mostrare il contesto esterno dei posti visitati.






Travel Tales Weekend, è il momento conclusivo di una serie di eventi nati per la promozione di progetti autoriali legati alla Fotografia di Viaggio, lanciata da Starring con Photographers.it e Isp in collaborazione con la rivista Il Fotografo, con il supporto tecnico di Viaggio Fotografico.it e di NOC e con il supporto operativo di OTTO Rooms e OTTO Gallery a cui si aggiunge per l’iniziativa Officine Fotografiche Roma, una delle maggiori strutture dedicate alla Fotografia.
Rispettando lo schema di iniziative previste dall’Award la commissione composta da Angelo Cucchetto, Giovanni Pelloso, Roberto Gabriele, Simona Ottolenghi, Loredana De Pace e Paolo Petrignani ha selezionato 50 Storie tra tutte quelle che hanno partecipato all’Open Call dell’Award, e tra queste sono infine state scelte le storie poi premiate con le varie possibilità previste, che potete vedere a https://traveltalesaward.com/storie-premiate/
 È quindi arrivato il momento di festeggiare, e per farlo degnamente abbiamo strutturato un’iniziativa dedicata a Roma, TRAVEL TALES AWARD WEEKEND, grazie al supporto dei nostri partner. La festa inizierà venerdi 1 ottobre con la serata di premiazione dedicata da Otto Gallery, e proseguirà sabato da Officine Fotografiche.
È quindi arrivato il momento di festeggiare, e per farlo degnamente abbiamo strutturato un’iniziativa dedicata a Roma, TRAVEL TALES AWARD WEEKEND, grazie al supporto dei nostri partner. La festa inizierà venerdi 1 ottobre con la serata di premiazione dedicata da Otto Gallery, e proseguirà sabato da Officine Fotografiche.
Per il week end (vedi programma qui sotto) abbiamo previsto una grande mostra finale con una selezione di Autori che verranno esposti a Roma dal 1 ottobre al 30 novembre 2021, la letture di portfoli di viaggio, la presentazione di Cities 9 e del libro “Travel Tales – Storie di viaggi e di viaggiatori“, una tavola rotonda e un tour fotografico a Roma con Roberto Gabriele.
Una grande festa nella quale tutti gli eventi SONO GRATUITI MA E’ NECESSARIO PRENOTARE con il form qui sotto, nel rispetto delle norme anti covid.
 Mostra:
Mostra:Gli Autori (e i loro viaggi) esposti in mostra presso OTTO Gallery saranno: Maurizio Trifilidis (Cina), Ilaria Miani (Afghanistan), Alessandro Zaffonato (Romania), Alessandro Castiglioni (Siberia), Tania De Pascalis (Marocco), Roberto Manfredi (India), Laura Loiotile (Cuba), Lia Taddei (Uzbekistan), Roberto Malagoli (luce del Mondo), Laura Pierangeli (Bhutan), Giulio Cesare Grandi (India). La curatela della mostra è di Simona Ottolenghi che ha progettato anche l’allestimento dello spazio.
 Letture Portfolio:
Letture Portfolio:Due mattinate (sabato 2 e domenica 3 ottobre) interamente dedicate alla lettura dei portfoli. Giovanni Pelloso, Angelo Cucchetto e Simona Ottolenghi saranno disponibili gratuitamente per esaminare progetti e fare consulenze gratuite di Autori che si sono dedicati alla Fotografia di Viaggio. L’attività è completamente gratuita ma occorre prenotarsi con il form qui in basso.

Il libro “Travel Tales – Storie di viaggi e di viaggiatori” edito da Starring ha selezionato 21 progetti autoriali di fotografia di viaggio e li ha pubblicati in un prezioso volume che presenteremo sabato pomeriggio presso Officine Fotografiche. Questi gli Autori presenti: nel volume a cura di Simona Ottolenghi: Milot market di Stefano Bianchi, Nel segno di Evo di Massimiliano Cambuli, Siberia on the road di Alessandro Castiglioni, Rasputin di Alessandro Castiglioni, Cobra Grande di Pierluigi Ciambra, Che ne Saharà di noi di Mario Cucchi, Kupkari di Carmen Garcia, Quel treno Asmara – Arbaroba di Gualtiero Fergnani, I colori della luce di Roberto Malagoli, The Shoe Factory di Marco Marcone, I suoni del silenzio di Jessica Melluso, Ebano di Adriana Miani, Tracce di Blues di Gigi Montali, Carovane del Tigrai di Riccardo Panozzo, Iran di Diego Pedemonte, Color Mundi di Laura Pierangeli, viaggiare in Italia di Vito Raho, Dolomiti on the road di Francesco Sammarco, Eagle’s Festival di Maurizio Trifilidis, Guizhou di Maurizio Trifilidis, Donne del Maramures di Alessandro Zaffonato
Ecco il programma previsto salvo ulteriori modifiche e restrizioni imposte dal COVID-19:
10,00 – 13,00 presso Otto Gallery
17,00-19,00 Presso Officine Fotografiche
9,00-13,00 uscita fotografica gratuita a Roma con Roberto Gabriele, si scatta!
10,00 – 12,00, da Otto Gallery Consulenze progettuali gratuite in slot di 30 minuti, con Giovanni Pelloso, Simona Ottolenghi e Angelo Cucchetto, focus sullo story telling (ingresso scaglionato con prenotazione obbligatoria)
Partecipare all’evento è COMPLETAMENTE GRATUITO, è però NECESSARIO PRENOTARE con il form qui di seguito e mostrare il GREEN PASS prima di entrare.
Scegli il tuo orario in base alle tue esigenze: abbiamo messo un orario esteso dalle 15 alle 20 proprio per evitare assembramenti e dare a tutti la possibilità di godere al meglio della mostra e di scambiare due chiacchiere con gli Autori o gli altri visitatori. Abbiamo previsto uno slot di 30 minuti che saranno più che sufficienti per fare tutto, volendo potrai intrattenerti ancora dopo la fine del tuo orario in base ai flussi di persone del momento.

Sui Monti dell’Altaj della Mongolia vivono i pastori dell’etnia kazaca; per motivi tradizionali e culturali profondamente radicati, praticano la caccia con l’aquila, le cui tecniche e conoscenze vengono tramandate con orgoglio tra le diverse generazioni.

La caccia si svolge principalmente nel periodo più freddo, quando la terra è coperta di neve e le greggi richiedono meno attenzione. Un periodo in cui la rigidità del clima impedisce la mobilità dei pastori e le poche occasioni di incontro con altre famiglie possono anche essere a ore di viaggio. Le volpi sono la principale preda dei rapaci; il cacciatore trattiene la pelliccia della preda, che usa per il suo vestiario, e ne lascia la carne al rapace.

Alla fine di settembre i pastori si radunano per sfidarsi in una serie di gare di abilità e destrezza in un evento per tutti noto con il Festival delle Aquile.
Il campo di gara si trova in un altopiano a 2.000 metri, in una area priva di qualsivoglia abitazione, lontana dal più vicino centro abitato. I cacciatori arrivano a cavallo anche da zone molto distanti, sfoggiando abbigliamento e accessori tradizionali.
L’aquila, con la testa protetta da un cappuccio di cuoio, è posata sul braccio o su un bastone legato alla sella. Il rapporto tra il cacciatore e il suo rapace è esclusivo e dura molti anni.

Il Festival è una importante, e quasi unica, occasione d’incontro collettivo, l’ultima prima dell’inverno. Alle gare partecipano cacciatori di diverse età. Parenti e amici assistono con passione e forte coinvolgimento. Tra i spettatori, gli stranieri sono ben accetti. Vicino al campo di gara, si montano le tende pronte a fornire cibo e ospitalità, facilitando la socializzazione tra i presenti.

Le gare principali consistono proprio in una simulazione dell’azione di caccia: in una il cacciatore lascia la sua aquila su una collina, le toglie il cappuccio e poi, raggiunto un punto distante un centinaio o più di metri, la richiama, la invita a raggiungerlo e a posarsi sul suo braccio.

In una altra l’aquila deve catturare una preda, generalmente un pellicciotto di volpe trascinato dal cavallo del suo cacciatore, e posarsi su di essa.
Il cacciatore richiama l’aquila lanciandole una preda e urlando l’ordine con suoni gutturali. Velocità, obbedienza e precisione dell’aquila sono gli elementi di giudizio per vincere.

I pastori mongoli sono tutti eccellenti cavallerizzi e tra le gare più spettacolari, vi è quella della raccolta da terra di piccoli oggetti da parte di cavalieri lanciati al galoppo: velocità e numero degli oggetti raccolti sono gli elementi di vittoria.

Alla fine della seconda giornata, i cacciatori, sempre a cavallo, tornano a casa; per loro inizia un lungo periodo di solitudine. Anche io devo tornare: ho l’impressione di esser entrato in un altro secolo, per poi uscirne malvolentieri ma certo più ricco di emozioni e suggestioni.


“Carrasegare” significa carne viva da smembrare. Il ciclo della morte e della rinascita: la fine dell’inverno e l’inizio della stagione agricola.
Uomini vestiti di orbace e pelli, carichi di campanacci, con il volto annerito che sembrano venire dalla preistoria ripetendo gesti e movenze millenarie.
Il richiamo ai riti pagani, legati alla rappresentazione della morte del Dio Dionisio e della sua rinascita, portatrice dell’energia che attraverso il sangue rende fertile la terra e ne fa maturare i frutti.
Testi e foto di Andrea Del Genovese
Per partire con noi per la Sardegna dal 16 al 26 settembre 2021: https://viaggiofotografico.it/product/sardegna-pastori-e-pescatori/
Per Carrasegare, ossia per Carnevale: https://viaggiofotografico.it/product/carnevale-sardegna/











In un paese lontano lontano, famoso per i sigari, il rum e la rivoluzione, si lavora duro. Ovviamente parliamo di Cuba, patria della boxe dilettantistica. Si stima che un ragazzino su due pratichi quella che per i cubani è una nobile arte e non una lotta.

A sette/otto anni inizia la formazione in palestre di quartiere volute e finanziate dagli stessi abitanti. Ci si dedica anima e corpo per rincorrere il sogno olimpico e rappresentare così il proprio Paese.

Una volta conclusa la propria carriera si diventa allenatori e il ciclo continua con le generazioni successive. La dedizione, la tradizione storica e il ritmo che i cubani hanno nel ballare li rendono pugili forti che poi hanno trionfato nel corso della storia.

Percorrendo le strade dell’Avana con sorpresa e gioia mi sono infilata (cogli l’attimo) in questa palestra di boxe e ho assistito all’allenamento dei ragazzi, guidati sapientemente dall’esperienza dei maestri.

È stata una bellissima esperienza che mi ha portata a riflettere sulla semplicità con cui questi ragazzi vengono tolti dalla strada ed educati allo sport come palestra di vita.

Ho immaginato che il sogno del bimbo coi guantoni sia quello di salire sul ring, di combattere, di far diventare il suo sport una vera e propria professione, ma questo a Cuba non è previsto per nessuno.

Per il momento la magia racchiusa nei guantoni dei cubani resterà una riserva e un privilegio di quella bella “Signora” chiamata Cuba.
L’Avana 2020
Testi e foto di Laura Loiotile


Partecipo al concorso Travel Tales Award con un racconto sul viaggio in Afghanistan e India, tratti dal mio diario. Le foto sono in parte in bianco e nero, quelle del viaggio tra gli incontri e i torrenti del Badoskan. Quelle dei Buddha e della valle di Band-i-Amir le ho lasciate a colori come dalle originarie diapositive.

Le fotografie sono in parte del Sottoscritto Francesco Carmignoto e in parte dell’amico Francesco Ghion che ci ha lasciati quattro anni fa. Il suo ricordo mi riempie sempre di affetto e di nostalgia per il tempo passato. Foto e racconti vogliono essere un omaggio alla sua gioia per la vita e alla sua bravura.
Il testo ci vede già arrivati in Afghanistan con le nostre due piccole Fiat e non descrive il lungo percorso, bensì la atmosfera e le impressioni riportate sul diario.
Introduzione dall’Autore Francesco Carmignoto
Francesco Carmignoto

Da Kabul abbiamo deviato per la pista di Charikar, nel Nuristan. Qui il gruppo del Koh-i-Baba domina l’imponente fuga dei “colli” del Badokskan, nell’Hindu Kush, con cime superiori ai 6000 metri.

Un grande silenzio. Solo il torrente Kunduz, ricolmo di acqua cristallina, gorgoglia verso Est, verso l’Amu Darya. Più avanti formerà i sette laghi blu di Band-i-Amir.


Le rovine della “città rossa”, la fortezza che ha resistito a Tamerlano, sono ancora imponenti e dominano il villaggio. La gente della tribù hazara sorride e saluta. Ha i tratti mongoli ereditati dalle orde che Gengis Khan spingeva lungo queste valli al centro dell’Afghanistan alla conquista della Persia.
Da una curva della pista, come da un belvedere, l’alta parete rosata appare traforata a perdita d’occhio. Innumerevoli grotte, rifugio per secoli dei monaci, fanno da cornice a due nicchie con statue maestose, i Buddha di Bamiyan.
Sono scolpiti nell’arenaria, in piedi, appena coperti da un leggero mantello che scende in pieghe sottili. Ricordano le statue dei grandi condottieri greci e romani. Sono la testimonianza più bella dell’arte di Gandhara, l’incontro tra gli artigiani greci al seguito di Alessandro Magno e l’arte indiana. In alto, sulla volta della nicchia si intravvedono vecchi affreschi.
Le immagini di Bodhisattva e dei fedeli intenti alla preghiera hanno aureole dorate attorno al capo, come quelle delle icone del Cristo bizantino e dei santi nella pittura del Trecento.


Il buddismo era giunto in questa valle con i pellegrini nepalesi, attorno al terzo secolo d. C. e qui era sorto un monastero con migliaia di monaci. Il buddha più grande, alto più di 50 m, è già molto rovinato, forse dai tempi delle scorrerie di Gengis Khan o dalla conquista dell’Islam. La faccia è mezza cancellata e le gambe erose.
Eppure emana una suggestione sottile, una sensazione di pace e di tolleranza. Il braccio destro, velato dal manto leggero sembra ancora accogliere con la forza tranquilla di un tempo immutabile.
Verso sera ci avviamo verso i laghi di Band-i-Amir. Passiamo steppe infinite e aride colline dai colori bruciati. Dall’alto vediamo una serie di laghi azzurri illuminati dal tramonto rosato. Scendiamo fino ad una grande spianata sotto una falce di luna che scompare dietro le alte montagne.
Siamo soli, mentre il cielo si riempie di stelle nelle ultime luci viola. Le miriadi di stelle palpitanti nel blu evidenziano ancor più la Via Lattea luminosa come seta. I picchi altissimi sono rosati anche di notte.
Una incredibile magia trovarci sperduti quassù, tra le montagne più misteriose del mondo.




Partecipo al concorso Travel Tales Award con un racconto sul viaggio in Afghanistan e India, tratti dal mio diario. Accompagnano le fotografie scattate per la maggior parte dal mio caro amico Francesco Ghion, che ci ha lasciati quattro anni fa. Il suo ricordo mi riempie sempre di affetto e di nostalgia per il tempo passato. Foto e racconti vogliono essere un omaggio alla sua gioia per la vita e alla sua bravura.
Il testo ci vede già arrivati in Afghanistan con le nostre due piccole Fiat e non descrive il lungo percorso, bensì la atmosfera e le impressioni riportate sul diario.
Il racconto si riferisce a Kabul e alla sua gente di antica fierezza.
La Foto 14 relativa a Kabul ci mostra tutti a cena con il segretario d’Ambasciata, la 15 Francesco Ghion con il parroco della chiesetta all’interno dell’ambasciata. La sua parrocchia era l’Afghanistan.
Kabul ci accoglie con il solito caos delle città orientali, nel gran brulicare di gente a piedi e di tanti calessi trainati da un cavallo. Qui li usano come taxi.


Le nostre due piccole Fiat, che da Padova hanno già percorso più di 10.000 km, creano sorpresa e curiosità. Al centro di un incrocio un vigile dall’uniforme senza più colore è immobile e osserva il via-vai da una piccola pedana.
Si rianima appena vede le nostre auto che si fanno largo a stento. Scende deciso nel “traffico”, si mette a fischiare come un’orchestra, intima l’alt ad un vecchietto con l’asinello, ai carretti e ai numerosi pedoni pieni di fagotti multicolori e poi, con gesto magniloquente ed il volto illuminato dal suo più bel sorriso, ci indica che la via è libera.
Il bello è che ad ogni incrocio c’è lo stesso tipo di vigile, che esegue le stesse grandi manovre solo per noi.

La città vecchia è un groviglio di viuzze dove si affacciano botteghe di ogni genere. L’affollamento è straordinario, carretti, asini, capre, qualche fuoristrada scassato e tanta gente con vesti fantasiose. Gli uomini usano vesti e mantelli sovrapposti e turbanti colorati in testa. Alcuni ostentano lunghi fucili, piuttosto vecchi e scassati. Forse solo decorativi.


Impariamo a distinguere le tante etnie. I pashtun della zona di Kandahar portano un grande turbante bianco. I borghesi di Kabul un elegante berretto in pelliccia di karakoul. Gli afghani del Nord indossano il pakol, un berretto marroncino che sembra una padella con il bordo ingrossato. Assomiglia al copricapo dei Signori del Rinascimento italiano.
Davanti ad un cinematografo nel bazar, una piccola folla commenta sorpresa i manifesti del film americano Cat Ballou, in cui Jane Fonda si mostra in una posa curiosa.


Seduto a terra, un erudito legge il Corano ad un devoto accovacciato di fronte. L’afghano sembra un po’ perplesso.


Un venditore d’acqua porta un otre ricolmo. La barba è tinta di rosso con l’hennè. E’ vestito di una stoffa ricavata da un sacco, ma con taglio quasi occidentale. Orologio al polso e toppe sui gomiti ne fanno un elegantone.

Al mercato le donne con il burqa appaiono silenziosi fantasmi colorati. Da lontano vedi volteggiare un leggero mantello dai colori tenui dell’azzurro e del rosa. Scende dalla testa ai piedi e le mille pieghe si muovono sinuose. Un bimbo in braccio si nasconde tra le pieghe.

Ne siamo veramente affascinati. Nella immaginazione dei nostri vent’anni, così tutte le donne diventano belle, una immagine fluttuante, un corpo etereo che il vento si diverte a nascondere ed evidenziare, un balenare di occhi neri che ti osservano curiosi. Poi il capo si abbassa e il burka scompare tra la gente in un leggero fruscio.
Francesco Ghion



Durante un viaggio in Albania ho visitato il caratteristico mercato di Milot, cittadina situata circa 50 Km a nord di Tirana.
Si tratta di un mercato che dai primi anni del secolo scorso si svolge ogni domenica mattina e che richiama moltissime persone che vengono a Milot dai paesi e dalle campagne circostanti attratte dalla notevole varietà di mercanzie in vendita.
È possibile acquistare di tutto: nella zona ovest del mercato, la più lontana dal centro della cittadina, vengono venduti, in condizioni igieniche molto discutibili, animali di molte specie. Nella zona centrale vengono venduti prevalentemente abiti, calzature, casalinghi, attrezzi da lavoro e oggettistica di vario tipo ed inoltre iniziano le bancarelle che vendono generi alimentari.
Nella zona nord-est, quella più vicina al centro di Milot, vengono venduti soprattutto prodotti della terra e generi alimentari (miele, marmellate, ecc.) prodotti artigianalmente dagli stessi venditori.
Le persone sono cordiali e molto ben disposte verso gli stranieri e in particolare verso gli italiani, anche se in molti casi non vogliono essere fotografate; alcune donne indossano abiti tradizionali.
Stefano Bianchi ha di recente partecipato a Travel Tales Award Edizione 2021 la grande iniziativa che premia i migliori Racconti fotografici di viaggio. Oltre 150 Autori si sono confrontati sul tema unico proposto e organizzato da Angelo Cucchetto con Italian Street Photography, Photographers, Cities e la collaborazione della Rivista IL FOTOGRAFO che ha dato ulteriore grande visibilità a tutta l’iniziativa.
Tra i partner promotori di tutto l’evento ovviamente non potremmo che esserci anche noi di Viaggio Fotografico e in collaborazione con gli spazi espositivi di OTTO Gallery
Puoi vedere tutto il lavoro di Stefano Bianchi pubblicato sul sito ufficiale di Travel Tales Award: https://traveltalesaward.com/2021/05/25/milot-market-di-stefano-bianchi/
Guarda le foto e lascia un commento nello spazio in fondo a questa pagina.













“Cara” è il racconto di un viaggio nello spazio della selvaggia Islanda e nel tempo della memoria; il viaggio come occasione per perdersi, ritrovarsi e ridisegnare la propria identità.
In questo percorso, fotografia e scrittura si contaminano per mezzo di alcune cartoline scritte a me stessa per ricordare piccoli o grandi momenti della mia vita, per percorrere idee semplici o complesse ed esplorare nuovi orizzonti.

Questo lavoro di Daniela Giannangeli fa parte dei lavori selezionati dalla giuria del primo contest fotografico Travel Tales Award Edizione 2021 nel quale oltre 150 Autori si sono confrontati sul tema unico dei racconti fotografici ci viaggio.
L’intervista che potete vedere qui di seguito è stata fatta all’Autrice da Loredana De Pace per NOCSensei ed è stato uno dei Riconoscimenti speciali offerti dalla nostra grande iniziativa organizzata da Angelo Cucchetto con Italian Street Photography, Photographers, Cities e la collaborazione della Rivista IL FOTOGRAFO che ha dato ulteriore grande visibilità a tutta l’iniziativa.
Tra i partner promotori di tutto l’evento ovviamente non potremmo che esserci anche noi di Viaggio Fotografico e in collaborazione con gli spazi espositivi di OTTO Gallery
Puoi vedere tutto il lavoro di Daniela Giannangeli pubblicato sul sito ufficiale di Travel Tales Award: https://traveltalesaward.com/2021/05/24/cara-islanda-di-daniela-giannangeli/
Guarda le foto e lascia un commento nello spazio in fondo a questa pagina.
Cara D,
quella notte c’era la luna piena e la cometa Hale-Bopp. Notte luminosa: tuo figlio nasce ed entra a far parte del grande ciclo cosmico! Miscellanea di emozioni, immagini, sentimenti: il tutto della vita in pochi istanti. La summa.

Cara D,
sono passati venti anni! Mi viene in mente una vostra vacanza in Grecia, nel 1999. Era l’undici agosto ed il sole cominciò a diventare quasi nero. L’atmosfera era metallica e la testa girava un po’. Tuo figlio iniziò ad urlare con un pollice alzato ed un’ape ben salda sopra. La luce grigia rendeva il tutto molto surreale, con una certa carica di tragicità, ma attenuato il dolore del suo mini dito e tornato il sole, cominciaste a ridere di gusto di niente, abbracciati, come succede ancora e ancora…
D

Cara D,
qualche volta, pensi ad una breve conversazione con una tua ex alunna. Giulia ti gironzolava intorno, durante un momento libero dalle lezioni e tu le chiedesti se avesse bisogno di te, lei rispose di no ma non si allontanava, quindi, le domandasti se fosse stata sicura e le dicesti:
“Ti ascolto! “
“Lo so, maestra! “
Poche, preziose parole: il senso che hai cercato di dare al tuo lavoro di tanti anni che non hai soltanto concepito per insegnare a “leggere, scrivere e far di conto”, ma per esserci, come adulto affidabile su cui contare lungo un pezzo di strada, sempre!
D

Cara D,
“Tutti i dossi del podere salteranno fino in cielo e tutti i pantani sprofonderanno all’inferno prima che io rinunci ai miei diritti e alla mia indipendenza.” Laxness, Gente Indipendente.
Storie. Storie di lotte e di salite, di orgoglio e fede. Fede nella propria indipendenza. Non puoi non ricordare quando tuo padre combatteva contro i preti-padroni per rivendicare i suoi diritti. C’eri. Stavi sempre attaccata ai suoi pantaloni, nonostante non fossero faccende da femmine e, men che mai, da bambine; ma tuo padre era un contadino illuminato e ti lasciava vivere quelle storie. Capisti presto da che parte stare e non fu così difficile…
D

Cara D,
certe volte, girovaghi nei tuoi pensieri alla ricerca delle tue radici. È proprio come un viaggio nel tempo a caccia dei ricordi più antichi. I primi che riesci a ritrovare nella tua memoria sono legati al verde di prati freschi e all’arancio del fuoco caldo. Il verde e la mano di tuo nonno che ti conduceva negli amati campi, in quelle passeggiate senza fretta, lente e lunghe, dove lo spazio sembrava sovrabbondante e le risate dei suoi occhi trasparenti erano semplici, profonde.
L’arancio e la voce di tua nonna che ti raccontava storie accanto al maestoso fuoco della cucina. Ricordi l’odore di quella grande stanza e dei libri che lei ti riportava tutte le volte che si recava in paese.
Aspettavi il suo ritorno alla finestra. La vedevi arrivare da lontano, in sella alla sua bicicletta, mentre pedalava insicura sulla strada bianca e polverosa che portava al casolare e poi, seduta sulle sue ginocchia, partivate insieme per un bel viaggio, accompagnate da fate, lupi, eroi…
D

Cara D,
non credi di aver impiegato troppo tempo per concludere quella storia? Già, il tempo… Sei solita prenderti quello che ti serve, quasi a centellinare i momenti, forse per renderli unici o, forse, è il caso che ci mette la sua mano. In fondo, non ti interessava più laurearti, però volevi chiudere quella questione che sentivi sospesa e allora hai deciso di imprimere un’accelerazione repentina al tuo tempo lento ed è arrivato quel quattro luglio: sei andata a discutere la tua tesi, scritta di getto in una settimana perché nella tua testa era già stata concepita e c’era anche lui: tuo figlio. A quel tempo, aveva otto anni. Stava impettito in prima fila e ascoltava che la mamma raccontasse come vedeva un mondo possibile, dove le culture si intrecciassero, generando un potente ibrido di vita. E lo tenevi per mano, quasi stritolandola, mentre il presidente di commissione assegnava, assecondando un bel gioco, centodieci a te e la lode a lui, a cui la tesi era dedicata…
D

Cara D,
so che ti trovi nella terra del ghiaccio e del fuoco, dove il mondo sembra appena nato. La senti quasi cedere sotto i tuoi passi, mentre il vento gelido ti penetra negli occhi e le fulminee sterne artiche ti sfiorano la testa, liberando un canto acido. Tutto è puro. Non c’è nessuno. Più in là, rare pecore solitarie si proteggono dal freddo fra le dune di una lunga spiaggia chiara, dove soltanto il mare borbotta insieme al fiato dell’aria.
Te ne stai immobile, guardando in direzione della Groenlandia e allenti gli ormeggi della tua mente di fronte al sole di mezzanotte…
D

Cara D,
ti piace camminare, lo so. È così che fai pace con il mondo che ti circonda, quando ti sembra che questo diventi cattivo con te.
Allora, vai lungo le tue strade bianche; vai a trovare i “tuoi” due pini sulla collina che, come sentinelle, proteggono il tuo passaggio; ritorni dentro i tuoi paesaggi identitari che ti hanno vista crescere, ridere ma anche piangere. Sali sulla groppa del Monte Subasio che odora di narciso selvatico in primavera, dove i cavalli e le mucche brucano l’erba nuova in libertà, ciondolando.
E tutto sembra tornare al suo posto…
“Soltanto solo, sperduto, muto, a piedi riesco a riconoscere le cose.” Pier Paolo Pasolini.
D


Le chiese di campagna, ch’erbose hanno le soglie…Così nei versi di Pascoli. La chiesetta di Madonna della strada, una frazione di Scoppito, aveva la soglia invasa dai rovi, la porta divelta a metà, pochi vetri alle finestre. L’interno era tutto imbiancato a calce, salvo una sparuta immagine di madonna che sovrastava il misero altarino. La chiesetta era la casa dei rondoni che vi avevano nidificato numerosi e che stridevano acutamente sotto il tetto, volitando in un intreccio di traiettorie mirabili, per poi uscire a guadagnare la pura aria, lanciati nel cielo turchino a compiere più ampie volute. Quell’anno era venuto, sul piazzaletto della chiesa, un operatore a proiettare su uno schermo di tela tirato su alla meglio, una serie di vecchie comiche di Ridolini, tutte spezzettate. Una seconda volta, invece, fummo fortunati ad assistere, non so come, ad un film abbastanza recente intitolato “Sabotatori”, film che io vidi da una posizione molto defilata da cui le figure apparivano appiattite e allungate.
Era trascorso solo qualche anno da quando avevano spesso di transitare, sullo stradale davanti alla chiesetta, tutti quegli autocarri militari scoperti, carichi di soldati armati, uomini scuri di pelle, tutti con turbanti sul capo. Uno di quegli anni vi era passata la Mille Miglia, che avevamo ansiosamente atteso in molti, restando ad aspettare il passaggio di Tazio Nuvolari e seguitando poi a parlarne per molti giorni. Era quello il tempo in cui la figura di uomo ideale era per me il meccanico. Alla fornace ce n’era uno di nome Dante, un uomo che stava tutto il tempo a manovrare su una moto, che provava da ferma facendone andare il motore a tutta callara, come diceva lui, spandendo intorno un odore acuto di olio di ricino fritto. Mi faceva impazzire la sua tuta tutta d’un pezzo, frusta e sporca d’olio, con la chiusura-lampo di traverso. Dante aveva mani forti, che serravano gli strumenti con calma abilità; quando aveva le mani occupate ad aggeggiare, teneva la sigaretta tra le labbra nell’angolo sinistro della bocca, strizzando l’occhio per evitargli il fumo.
 Dell’Abruzzo ricordo queste cose scabre, questa gente di campagna, i paesaggi invernali e la neve calpestata delle strade sassose, una immensa selva di biancospino, il canto dei contadini sulle aie al tempo della trebbiatura, il loro duro lavoro intorno al frumento, che lanciavano in alto con quel grande setaccio per liberarlo dalla gluma. Ecco, l’immagine dell’Abruzzo, che a scuola la maestra diceva “Abruzzi”, per noi inspiegabilmente al plurale come “le Calabrie” e “le Puglie”, l’immagine dell’Abruzzo era proprio una immagine scabra, come ho detto. Il solo fatto che quella possente montagna, quel massiccio imponente fosse semplicemente chiamato “sasso”: il Gran Sasso, mi testimonia oggi di un atteggiamento chiuso, di una inclinazione a risparmiar persino le parole, a ridurne la portata al puro significante. Questo atteggiamento, che è nella sostanza un profilo spirituale, significa alla fine una integrità, che dura sia pure per poco, il tempo che dura una favilla, ma che resta come percezione forte di un mondo costituito di pochi elementi semplici, naturali, piccoli doni dati a tutti, ma che poche volte, o una soltanto, riusciamo a vedere come grandi tesori e che, una volta intravisti per tali, restano in noi come indelebile idea del mondo, una fra le tante, bella come tante. Un mito, il “Sasso”, il sasso grande. Un altro mito di questa terra resta per me il lupo, discorro dell’epoca immediatamente post-bellica, parlo delle stragi di pecore e dello sconforto susseguente, parlo dei lupari che venivano riconosciuti come meritori difensori della comunità pastorale, tantoché riscuotevano mance in natura, alquanto risicate in verità, come sempre mi è capitato di osservare, conducendo in giro il lupo ucciso, messo di traverso su un somaro, a mostrarlo alla gente.
Dell’Abruzzo ricordo queste cose scabre, questa gente di campagna, i paesaggi invernali e la neve calpestata delle strade sassose, una immensa selva di biancospino, il canto dei contadini sulle aie al tempo della trebbiatura, il loro duro lavoro intorno al frumento, che lanciavano in alto con quel grande setaccio per liberarlo dalla gluma. Ecco, l’immagine dell’Abruzzo, che a scuola la maestra diceva “Abruzzi”, per noi inspiegabilmente al plurale come “le Calabrie” e “le Puglie”, l’immagine dell’Abruzzo era proprio una immagine scabra, come ho detto. Il solo fatto che quella possente montagna, quel massiccio imponente fosse semplicemente chiamato “sasso”: il Gran Sasso, mi testimonia oggi di un atteggiamento chiuso, di una inclinazione a risparmiar persino le parole, a ridurne la portata al puro significante. Questo atteggiamento, che è nella sostanza un profilo spirituale, significa alla fine una integrità, che dura sia pure per poco, il tempo che dura una favilla, ma che resta come percezione forte di un mondo costituito di pochi elementi semplici, naturali, piccoli doni dati a tutti, ma che poche volte, o una soltanto, riusciamo a vedere come grandi tesori e che, una volta intravisti per tali, restano in noi come indelebile idea del mondo, una fra le tante, bella come tante. Un mito, il “Sasso”, il sasso grande. Un altro mito di questa terra resta per me il lupo, discorro dell’epoca immediatamente post-bellica, parlo delle stragi di pecore e dello sconforto susseguente, parlo dei lupari che venivano riconosciuti come meritori difensori della comunità pastorale, tantoché riscuotevano mance in natura, alquanto risicate in verità, come sempre mi è capitato di osservare, conducendo in giro il lupo ucciso, messo di traverso su un somaro, a mostrarlo alla gente.
 Il paesaggio dell’Abruzzo, quello che io ricordo. I prati smaltati di pioggia, l’odore della terra intrisa, l’umido respiro della terra, l’odore delle pecore; il vello folto scosta l’acqua ma esala un fortore selvatico, il pastore ha l’odore, lo stesso, delle sue pecore, il pastore vive in un cerchio di pioggia, resta sotto la pioggia senza neppur aprire l’ombrellaccio che porta a tracolla, e non cerca ricovero nella capannuccia di rami, gli bastano l’incerata e il suo feltro a punta; il pastore fischia i suoi acuti richiami da pecoraio, che servono solo a far compagnia a se stesso e a farne alle pecore, anche se sono chiuse, aggruppate strette nello stabbio di corda, al cane bianco che non ha riposo attorno al gregge, come se fiutasse continuamente un pericolo. Il pecoraio guarda in giro all’orizzonte sotto la tesa di feltro, anche se non dà a vederlo e sembra che guardi fisso alle sue pecore, invece conosce gli alberi e vede le volpi passare lontano e a notte parla alle stelle.
Il paesaggio dell’Abruzzo, quello che io ricordo. I prati smaltati di pioggia, l’odore della terra intrisa, l’umido respiro della terra, l’odore delle pecore; il vello folto scosta l’acqua ma esala un fortore selvatico, il pastore ha l’odore, lo stesso, delle sue pecore, il pastore vive in un cerchio di pioggia, resta sotto la pioggia senza neppur aprire l’ombrellaccio che porta a tracolla, e non cerca ricovero nella capannuccia di rami, gli bastano l’incerata e il suo feltro a punta; il pastore fischia i suoi acuti richiami da pecoraio, che servono solo a far compagnia a se stesso e a farne alle pecore, anche se sono chiuse, aggruppate strette nello stabbio di corda, al cane bianco che non ha riposo attorno al gregge, come se fiutasse continuamente un pericolo. Il pecoraio guarda in giro all’orizzonte sotto la tesa di feltro, anche se non dà a vederlo e sembra che guardi fisso alle sue pecore, invece conosce gli alberi e vede le volpi passare lontano e a notte parla alle stelle.
Il paesaggio contiene poche cose disegnate, dovunque si guardi, quello che c’è è venuto su naturale, soltanto gli steccati sono fatti dagli uomini ma sono grezzi, intrecciati di rami storti come storti sono i muriccioli di pietre a secco; la strada asfaltata è l’unico vero disegno, la strada con la casina rossa del cantoniere, con le piazzole di materiali messe a intervalli regolari, dove dagli stradini sono stati ammonticchiati, in cumuli a forma di perfetta piramide tronca: i sassi e la ghiaia grigia per le toppe, per le riparazioni da fare usciti fuori dall’inverno. E i fontanili, sì anche i fontanili che rispecchiano il cielo sono costruiti dagli uomini, e così i calzini messi agli alberi, la fascia bianca di calce dipinta ai piedi dei tigli che seguono la strada e nella notte segnano il cammino. Tutto il resto, le macchie degli abeti le siepi fitte di rovi gli arbusti i meli selvatici i prati di fragole ribes lamponi uvaspina il ruscello il profilo dei monti, tutto è un capriccio di forme come le nuvole e la loro ombra, come i massi sparpagliati sul terreno e ricoperti di licheni e di muschio.
L’Abruzzo! Uno stato d’animo speciale, influenzato certamente dal carattere non solo fisico del luogo, che mi ha fatto provare a lungo e molte volte quel brivido metafisico, effetto della mia natura contemplativa e della mia sensibilità panica. Così una stagione di vento, le sempre mutevoli strade che esso percorre, come le strade del cuore. Il vento soffiava quella stagione, lassù sull’Altopiano delle Rocche, in una maniera nuova per me. Era un vento strapazzone e ridente che spirava nei golfi del mio cuore e io ero pieno di vento e facevo parte del vento. Il vento, spirito della notte, sorvolava i tetti frusciando e io con esso perdevo a tratti la memoria nel sonno e a tratti la ritrovavo. Il fruscio lene di altri mondi, di mondi remoti. Avevo allo stesso tempo una sensazione di familiarità con me stesso e di estraneità. Andavo con il vento, come i nugoli di polvere vanno, come le foglie a mulinelli. Udivo il vento urtare sui vetri con violenza, sulla carta incatramata messa a riparo dove mancava una lastra. Il vento passava sotto le porte e spifferava nelle stanze…Quella fu anche la stagione delle lucciole nelle notti serene. Le vedevi per un attimo, vedevi la loro tenue luce solo per un attimo in un punto del buio e un istante dopo in un altro punto. Ma era la stessa luce, la stessa lucciola? Non vi è nella notte un maggior intenerimento che la sorpresa di guardare una lucciola accendersi indifesa sul palmo della tua mano e volare subito via. E non c’era in quelle notti sull’altopiano una visione più alta della Via Lattea, dove la mia ossessione di infinito si placava. Potevo guardare all’infinito, potevo vederlo. Una cosa nebulosa, l’infinito, una cosa imprecisa: ci sono fiamme accese a distanze siderali dove l’occhio non arriva. Ma sai che ardono malgrado i tuoi occhi.
Abruzzo © Renato Gabriele
Facebook: https://www.facebook.com/RenatoGabrieleScrittore


Per rivivere insieme a noi i luoghi di questa “prosa poetica” di Renato Gabriele puoi seguirci nel nostro Viaggio Fotografico che faremo in Abruzzo dal 21 al 26 giugno 2021, poi per chi vorrà il tour prosegue direttamente per il Molise e chi si iscrive ad entrambi i viaggi risparmia 100,00 Euro sul totale. Info, costi e iscrizioni sul sito: https://viaggiofotografico.it/product/abruzzo-aquila-e-pecore/


«Le rovine non sono il passato, sono il futuro che ci invita all’attenzione e a godere del presente» così Josef Koudelka ci presenta il suo lavoro Radici esposto in questi giorni a Roma nel Museo dell’Ara Pacis fino al 29 agosto 2021.
Sono andato a visitare questa questa mostra straordinaria per la sua originalità che è stata riaperta in questi giorni (dopo la chiusura causa covid delle scorse settimane) e per fortuna l’esposizione è stata prolungata: hai tempo fino al 29 agosto per vederla, salvo nuove chiusure e restrizioni che speriamo non ci siano!

“Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza” questo è il titolo della mostra ed è l’unica occasione in Italia per apprezzare da vicino oltre 100 fotografie in formato gigante da Josef Koudelka, il fotografo Magnum stranoto per i suoi reportage (come quello sulla Primavera di Praga del 1968) che in questa occasione ci mostra il suo lavoro che in oltre 30 anni ha dedicato a fotografare i siti archeologici di tutto il Mediterraneo. Tutte le foto hanno incantevoli tagli panoramici e anche le poche in verticale usano questo formato allungato che si presta perfettamente alla narrazione degli scorci raccontati dall’Autore. Le stampe, tutte in bianco e nero sono provengono dagli scatti realizzati dall’Autore tra Siria, Grecia, Turchia, Libano, Cipro, Israele, Giordania, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo, Spagna, Francia, Albania, Croazia e, naturalmente, la nostra Italia.

Koudelka definisce questo i suoi tagli “Prospettive instabili” ed in effetti guardandole si ha un senso di disorientamento perchè in alcune occasioni gli orizzonti sono volutamente e visibilmente inclinati per rendere più dinamica l’immagine, per enfatizzare il senso della millenaria storia di questi luoghi testimoni del tempo. Non tutti sanno che Koudelka ha una formazione da Ingegnere aeronautico e queste immagini (insolite per un Autore come lui) rendono il senso del volo radente acrobatico.
La mostra RADICI allestita all’Ara Pacis è una scelta precisa per integrare il senso dell’archeologia in un museo che è un ponte ideale di collegamento tra l’antico monumento romano e l’edificio costruito per conservarlo dall’architetto Richard Meier. Le immagini di Koudelka dialogano con la struttura che le contiene e allo stesso tempo è contenuto e contenitore della grande storia di Roma.

Quello che mi è piaciuto di questa mostra è il suo senso immersivo, il suo valore di testimone della storia e dei luoghi. Entrando nei bellissimi spazi allestiti si viene proiettati in un mondo inaspettato, senza tempo. Apparentemente immutato da oltre 20 secoli. Le stampe, bellissime, sono tutte in bianco e nero di grande formato e panoramiche. Il visitatore ha l’impressione di osservare il mondo attraverso una fessura che gli permette di “spiare” un mondo che da solo, non sarebbe in grado di vedere. E la fotografia in quanto tale ha questo grande potere: mostrare agli altri ciò che ha visto l’Autore, ciò che era lì in quel momento ma che nessun altro ha avuto la sensibilità e l’acume di rilevare.
 In alcuni casi con queste immagini si sfiora l’astrattismo. La purezza delle forme viene sintetizzata in un bianco e nero che per la sua semplicità tende a farle diventare opere grafiche che sembrano disegnate dalla mano dei secoli. Ed è così che un anfiteatro assume le sembianze di cerchi concentrici disegnati nella roccia, che i frammenti di una colonna sembrano essere una serie di ruote dentate di un antico meccanismo.
In alcuni casi con queste immagini si sfiora l’astrattismo. La purezza delle forme viene sintetizzata in un bianco e nero che per la sua semplicità tende a farle diventare opere grafiche che sembrano disegnate dalla mano dei secoli. Ed è così che un anfiteatro assume le sembianze di cerchi concentrici disegnati nella roccia, che i frammenti di una colonna sembrano essere una serie di ruote dentate di un antico meccanismo.
Koudelka, da bravo fotografo, si serve della luce per “dipingere” le sue creazioni prima sulla pellicola, adesso sul sensore della sua fotocamera. La luce fornisce i contrasti, i volumi, ci da il senso della materia e ci permette di toccare ciò che possiamo solo vedere. “Radici” esprime perfettamente tutto questo. Alcune opere sono state montate su dei cubi di legno: l’osservatore per vederle deve chinarsi su di esse proprio come farebbe per osservare un reperto ritrovato in un sito archeologico.
 Un viaggio virtuale nel tempo e nello spazio: camminando tra le opere ci si perde nel cercare di riconoscere i luoghi dell’iconografia classica e restare colpiti da come la capacità di un grande Artista abbia saputo interpretarli rendendo iconica ogni pietra. Ci si immerge in una sorta di bagno rituale nel quale il viaggiatore trova un onirico oblio dei propri pensieri.
Un viaggio virtuale nel tempo e nello spazio: camminando tra le opere ci si perde nel cercare di riconoscere i luoghi dell’iconografia classica e restare colpiti da come la capacità di un grande Artista abbia saputo interpretarli rendendo iconica ogni pietra. Ci si immerge in una sorta di bagno rituale nel quale il viaggiatore trova un onirico oblio dei propri pensieri.
Non perdetevi questa mostra, sarà l’occasione per ri-vedere Roma e ri-scoprire un grandissimo Fotografo che sicuramente non conoscevate in questa veste.

SITO UFFICIALE: www.arapacis.it
DOVE: Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli) . Museo dell’Ara Pacis,
QUANDO: Fino al 16 maggio 2021, PROROGATA FINO AL 29 AGOSTO 2021
CATALOGO: Contrasto – Radici.
ORARI: Dal lunedì al venerdì, ore 9.30-19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima).
BIGLIETTI: “solo Mostra” intero € 11; ridotto € 9; € 22 biglietto speciale Famiglie; integrato Museo dell’Ara Pacis+ Mostra per non residenti a Roma intero € 17 (€ 16 per residenti); ridotto € 13 (€ 12 per residenti).
NORME COVID: Verificare sempre gli orari sul sito con le nuove disposizioni per Covid-19
PREVENDITA OBBLIGATORIA: turni di ingresso contingentati salvo differenti disposizioni dell’amministrazione di Roma Capitale. Info tel. 060608 (tutti i giorni ore 9 – 19) PER LA PREVENDITA OBBLIGATORIA CLICCA QUI.


Se esiste una strada epica è proprio la Route 66 negli Stati Uniti. Epica perché il solo nome la lega ad una serie di miti che hanno influenzato non solo il nostro modo di viaggiare ma anche quello di essere e di pensare. “The mother Road”, la chiamano, ossia “la strada Madre” quella da cui tutte le strade hanno origine mentale. I cartelli lungo i locali storici la chiamano con tutti gli altri aggettivi possibili: “Legendary” oppure “Historic” o amichevolmente “Old”.
Ma andiamo per ordine e iniziamo proprio dalla fine: La Route 66 non esiste più. E forse proprio questo è servito ad aumentarne il fascino e la notorietà, a renderla immortale nonostante sia stata ufficialmente dismessa e sostituita dalla più moderna Interstate 40, una enorme autostrada a 6 corsie che segue grosso modo il vecchio tracciato e collega ora come allora Chicago a Los Angeles, anzi, a Santa Monica, per essere precisi.
 Gli americani hanno spazio e soldi: preferiscono rifare una strada che ampliarla, e i criteri di costruzione della Route 66 (risalivano a circa 100 anni fa ) oggi non sono più validi: c’erano troppe salite, troppi villaggi, troppa strada fatta per aggirare una montagna. Oggi i tracciati sono diversi, si punta tutto a risparmiare tempo, soldi, benzina e quindi la strada è morta fisicamente ma il suo spirito è vivo più di prima nell’immaginario collettivo di milioni di viaggiatori in tutto il mondo.
Gli americani hanno spazio e soldi: preferiscono rifare una strada che ampliarla, e i criteri di costruzione della Route 66 (risalivano a circa 100 anni fa ) oggi non sono più validi: c’erano troppe salite, troppi villaggi, troppa strada fatta per aggirare una montagna. Oggi i tracciati sono diversi, si punta tutto a risparmiare tempo, soldi, benzina e quindi la strada è morta fisicamente ma il suo spirito è vivo più di prima nell’immaginario collettivo di milioni di viaggiatori in tutto il mondo.
Perchè il mito? Perchè le sue 2138 miglia (circa 3400 chilometri) sono state percorse da milioni di camionisti e automobilisti che la percorrevano in modo pionieristico nei decenni che andavano dagli anni ‘20 ai ‘70 del secolo scorso. Occorreva affrontare la strada: sedimentare dentro di sé la distanza e i tempi necessari a percorrerla e afferrare il volante per mettersi alla guida. I primi anni, ovviamente non c’era neanche l’asfalto: era un vero e proprio rally da fare, e il premio era già il solo arrivare a destinazione. Le figure più importanti legate alla strada erano proprio i meccanici e i gommisti insieme ai benzinai che avevano un ruolo più sociale che economico: senza di loro il viaggio non sarebbe arrivato a destinazione.
 Dato che ci volevano giorni per percorrerla interamente, come nelle nostre moderne autostrade le altre tappe obbligate in cui fermarsi erano i motel ed i ristoranti disseminati lungo tutto il percorso. Migliaia di avamposti sparsi nel nulla, nel bel mezzo di un deserto o in cima ad un valico di montagna sul quale, una volta arrivati, occorreva far riposare i motori per abbassarne la temperatura che saliva in proporzione allo sforzo dovuto alla pendenza e alla quota. Le soste non erano tutte uguali, c’erano dei posti che vivevano di una loro notorietà dovuta a qualcosa che li distingueva da tutti gli altri e la gente era disposta ad allungare le proprie tappe per arrivarci: la più buona torta di mele della Route 66, oppure la più bella cameriera del Missouri, o la famosa bistecca di manzo del Big Texan da 72 once (circa due chili di carne) che si può mangiare gratis ma solo per chi riesca a finirla in 60 minuti, entrando poi di diritto nell’Albo d’Oro del ristorante di Amarillo.
Dato che ci volevano giorni per percorrerla interamente, come nelle nostre moderne autostrade le altre tappe obbligate in cui fermarsi erano i motel ed i ristoranti disseminati lungo tutto il percorso. Migliaia di avamposti sparsi nel nulla, nel bel mezzo di un deserto o in cima ad un valico di montagna sul quale, una volta arrivati, occorreva far riposare i motori per abbassarne la temperatura che saliva in proporzione allo sforzo dovuto alla pendenza e alla quota. Le soste non erano tutte uguali, c’erano dei posti che vivevano di una loro notorietà dovuta a qualcosa che li distingueva da tutti gli altri e la gente era disposta ad allungare le proprie tappe per arrivarci: la più buona torta di mele della Route 66, oppure la più bella cameriera del Missouri, o la famosa bistecca di manzo del Big Texan da 72 once (circa due chili di carne) che si può mangiare gratis ma solo per chi riesca a finirla in 60 minuti, entrando poi di diritto nell’Albo d’Oro del ristorante di Amarillo.
 La Route 66 era una sorta di lungo villaggio su strada in cui ciascuno degli esercenti conosceva bene i propri vicini e aveva almeno sentito parlare di tutti gli altri; con alcuni si era in amicizia, con altri in guerra commerciale. Nessuno era mai veramente da solo lungo quella strada, anche quando intorno non c’era anima viva. Quei locali, a volte fetidi altre volte delle vere a proprie oasi di pace, erano sempre da qualche parte dietro ad una curva, in fondo al rettilineo, in cima alla salita per dare conforto o aiuto ai viaggiatori.
La Route 66 era una sorta di lungo villaggio su strada in cui ciascuno degli esercenti conosceva bene i propri vicini e aveva almeno sentito parlare di tutti gli altri; con alcuni si era in amicizia, con altri in guerra commerciale. Nessuno era mai veramente da solo lungo quella strada, anche quando intorno non c’era anima viva. Quei locali, a volte fetidi altre volte delle vere a proprie oasi di pace, erano sempre da qualche parte dietro ad una curva, in fondo al rettilineo, in cima alla salita per dare conforto o aiuto ai viaggiatori.
 E tutto questo ben lo sapevano Jack Kerouac e gli altri poeti della Beat Generation che vedevano nella grande strada la realizzazione di un ideale di libertà, il mezzo per vivere il grande sogno americano. La strada come metafora della vita, non solo come percorso fisico su un nastro di asfalto, ma come un vero esercizio di stile filosofico. La strada era, ed è ancora, il mezzo con il quale spostare il pensiero dall’orizzonte in cui è rinchiuso dentro casa. Ecco quindi che il solo fatto di percorrerla è già una crescita personale, un arricchimento interiore. “On the Road”, era il titolo del libro che ha ispirato tutto questo movimento di pensiero: essere sulla strada è la condizione necessaria per avvicinarsi fisicamente e mentalmente a tutto questo.
E tutto questo ben lo sapevano Jack Kerouac e gli altri poeti della Beat Generation che vedevano nella grande strada la realizzazione di un ideale di libertà, il mezzo per vivere il grande sogno americano. La strada come metafora della vita, non solo come percorso fisico su un nastro di asfalto, ma come un vero esercizio di stile filosofico. La strada era, ed è ancora, il mezzo con il quale spostare il pensiero dall’orizzonte in cui è rinchiuso dentro casa. Ecco quindi che il solo fatto di percorrerla è già una crescita personale, un arricchimento interiore. “On the Road”, era il titolo del libro che ha ispirato tutto questo movimento di pensiero: essere sulla strada è la condizione necessaria per avvicinarsi fisicamente e mentalmente a tutto questo.
 La strada è luogo di incontro con gli altri e con se stessi, un posto di scambio di merci e di esperienze. La sosta in un locale era l’occasione per sapere le condizioni meteo, o di eventuali incidenti, frane ecc. Così come avviene nella vita di tutti i giorni quando ci si ferma a riflettere su cosa ci accade intorno, altrettanto il viaggio on the road è l’occasione per incontrare tutto questo e il modo migliore per farlo è di sicuro una scoppiettante moto Harley Davidson che è la realizzazione meccanica di uno stile di vita basato su grandi ideali di pace e libertà.
La strada è luogo di incontro con gli altri e con se stessi, un posto di scambio di merci e di esperienze. La sosta in un locale era l’occasione per sapere le condizioni meteo, o di eventuali incidenti, frane ecc. Così come avviene nella vita di tutti i giorni quando ci si ferma a riflettere su cosa ci accade intorno, altrettanto il viaggio on the road è l’occasione per incontrare tutto questo e il modo migliore per farlo è di sicuro una scoppiettante moto Harley Davidson che è la realizzazione meccanica di uno stile di vita basato su grandi ideali di pace e libertà.
 Poi è arrivata la modernità, la Route 66 ha perso velocemente la sua utilità di collegamento ma non il suo fascino. Oggi è stata sostituita e coperta dal nuovo tracciato che in alcuni tratti la lascia ancora visibile al Viaggiatore in tutta la sua bellezza. In alcuni tratti, sì… Oggi la strada ci appare come una viuzza di campagna con una sola corsia per senso di marcia, i locali che un tempo erano brulicanti di vita, di lavoro, di persone e di servizi ora sono chiusi, decadenti, abbandonati e pieni di fascino senza tempo. Alcuni di quelli che si trovavano nelle città ancora riescono a restare aperti, sono diventati dei “musei”, vere istituzioni che ancora funzionano a pieno ritmo, alcuni sono stati rinnovati o lasciati al loro destino, altri infine sono diventati negozietti in cui si vendono souvenir turistici legati alla strada: antiche targhe di automobile originali, giubbotti da motociclisti, insegne di vecchi ristoranti o marche di benzine e pneumatici degli anni ‘50 mischiati a paccottiglia di produzione seriale cinese.
Poi è arrivata la modernità, la Route 66 ha perso velocemente la sua utilità di collegamento ma non il suo fascino. Oggi è stata sostituita e coperta dal nuovo tracciato che in alcuni tratti la lascia ancora visibile al Viaggiatore in tutta la sua bellezza. In alcuni tratti, sì… Oggi la strada ci appare come una viuzza di campagna con una sola corsia per senso di marcia, i locali che un tempo erano brulicanti di vita, di lavoro, di persone e di servizi ora sono chiusi, decadenti, abbandonati e pieni di fascino senza tempo. Alcuni di quelli che si trovavano nelle città ancora riescono a restare aperti, sono diventati dei “musei”, vere istituzioni che ancora funzionano a pieno ritmo, alcuni sono stati rinnovati o lasciati al loro destino, altri infine sono diventati negozietti in cui si vendono souvenir turistici legati alla strada: antiche targhe di automobile originali, giubbotti da motociclisti, insegne di vecchi ristoranti o marche di benzine e pneumatici degli anni ‘50 mischiati a paccottiglia di produzione seriale cinese.
Nonostante tutto, la strada mantiene ben vivo il suo mito, di strade famose per i Viaggiatori ce ne sono tante in tutti i continenti: dalla Transandina alla Panamericana, dalla Transtibetana alla Carretera della Muerte o alla Great Ocean Road, ma la Route 66 le batte tutte per fascino e notorietà, a parte la nostra Via Appia, l’antica Regina Viarum che da 2000 anni assolve a questo ruolo per noi italiani.

La cosa che lascia stupiti è che anche nei tratti urbani le strade sono vuote, le auto sono pochissime e non esistono file ai semafori. Le cittadine che si incontrano lungo il percorso, anche quelle abitate, hanno strade sono enormi anche in pieno centro e sempre vuote, la gente non cammina a piedi, l’America non è un posto dove si può camminare a piedi, le distanze sono troppo grandi. L’impressione che si ha è quella di vivere in un vecchio film western nel quale le case non sono più di legno ma di cemento armato e i cavalli ora hanno quattro ruote ed un motore.
Lungo “La Strada” si ha ancora quel senso di vuoto che provava James Dean in Gioventù bruciata, ed è ancora possibile sentirsi liberi come Dennis Hopper e Peter Fonda in Easy Rider. Questa strada è stata la la musa ispiratrice di film anche più recenti come Thelma e Louise nella loro fuga dalla vita, e persino di Cars, un film di animazione della Pixar in cui le auto prendono vita e anche questo è ambientato sulla “sixtysix”. Impossibile viaggiare senza sentire di vivere come in un film, impossibile non riconoscere un po’ di noi stessi in ciascuna di quelle storie; guidando su quelle strade si rivivono quelle emozioni in prima persona. Come in un film.

Così come nella vita ci sono periodi in cui ci si ferma a pensare, anche le soste fanno parte del viaggio, ed è possibile scegliere il posto giusto per farlo: ci sono locali che mantengono il loro fascino inalterato, in cui è ancora possibile mangiare un hamburger ascoltando la musica nostalgica e intramontabile di Bob Dylan o le note del rock texano e incalzante dei barbuti ZZ Top. Questa strada ha ispirato artisti di ogni genere; i musicisti non potevano rimanere insensibili al suo fascino, pensando ad essa hanno scritto gli evergreen che oggi tutti cantano a squarciagola nella radio della macchina noleggiata per viaggiare da quelle parti. Musica e cibo in viaggio sono elementi di fortissima ispirazione e mescolati insieme sono in grado di moltiplicare le emozioni, si mescolano con la nostra anima, con la nostra cultura e fanno poi parte di noi. Nessuno mai potrà dimenticare il sapore della senape sulle patatine mangiate in auto guidando e ascoltando Elvis o i Rolling Stones nel deserto del New Mexico. Una emozione forte non si dimentica, più emozioni forti vissute contemporaneamente rimangono profonde ed evidenti come una cicatrice della quale andare fieri, come un enorme tatuaggio da esibire in strada.
 Oggi percorrere quello che resta della vecchia Route 66 è ancora un’impresa: la strada non è tracciata, occorre avere una buona mappa e seguire (dove ci sono) le indicazioni per la “Historic Route 66”, sono delle stradine secondarie desolate e piene di fascino, a volte si interrompono nel nulla e occorre tornare indietro perchè non si innestano con nessuna altra strada. Occorre armarsi di pazienza e di un certo spirito di avventura per “sentire” la strada; il bello è proprio scoprirla miglio dopo miglio, accorgersi di scorci mozzafiato o di noiosissimi passaggi nel vuoto assoluto del grande continente americano. Questo è il viaggio dei viaggi, quello che si fa per esserci, per sentire di far parte di qualcosa, di un luogo, di una storia che non finirà mai. La Route 66 è l’essenza stessa del viaggio, è il viaggio fatto per viaggiare, per scoprire se stessi sulla strada della vita.
Oggi percorrere quello che resta della vecchia Route 66 è ancora un’impresa: la strada non è tracciata, occorre avere una buona mappa e seguire (dove ci sono) le indicazioni per la “Historic Route 66”, sono delle stradine secondarie desolate e piene di fascino, a volte si interrompono nel nulla e occorre tornare indietro perchè non si innestano con nessuna altra strada. Occorre armarsi di pazienza e di un certo spirito di avventura per “sentire” la strada; il bello è proprio scoprirla miglio dopo miglio, accorgersi di scorci mozzafiato o di noiosissimi passaggi nel vuoto assoluto del grande continente americano. Questo è il viaggio dei viaggi, quello che si fa per esserci, per sentire di far parte di qualcosa, di un luogo, di una storia che non finirà mai. La Route 66 è l’essenza stessa del viaggio, è il viaggio fatto per viaggiare, per scoprire se stessi sulla strada della vita.
 Si impiegano circa 2 settimane a percorrere tutta la strada che separa il lago Michigan dall’Oceano Pacifico. Per fermarsi a vedere qualcosa come per un selfie vicino ad un motel storico, si impiega del tempo che va aggiunto ai tempi di guida e questo va sommato ai tempi di un riposino o di una visita ad una delle “Ghost Town”, le tante cittadine rimaste abbandonate intorno ad un distributore di carburanti in disuso. Camminando in questi luoghi si sente un silenzio che va oltre il non sentire rumori, questo è qualcosa di più profondo, quasi il rispetto che si deve ai luoghi sacri o ai cimiteri. La sensazione che spesso si prova è quella di una grande anima che aleggia ancora in quei posti che prima erano così pieni di vita, di gente, di lavoro.
Si impiegano circa 2 settimane a percorrere tutta la strada che separa il lago Michigan dall’Oceano Pacifico. Per fermarsi a vedere qualcosa come per un selfie vicino ad un motel storico, si impiega del tempo che va aggiunto ai tempi di guida e questo va sommato ai tempi di un riposino o di una visita ad una delle “Ghost Town”, le tante cittadine rimaste abbandonate intorno ad un distributore di carburanti in disuso. Camminando in questi luoghi si sente un silenzio che va oltre il non sentire rumori, questo è qualcosa di più profondo, quasi il rispetto che si deve ai luoghi sacri o ai cimiteri. La sensazione che spesso si prova è quella di una grande anima che aleggia ancora in quei posti che prima erano così pieni di vita, di gente, di lavoro.
 Questo viaggio deve essere preparato non sul web e sulle migliaia di libri che ne parlano dal punto di vista turistico, questo è un viaggio dell’anima, occorre prepararsi spiritualmente ad una esperienza che sarà forte e travolgente, nulla sarà più come prima. Partire per la Route 66 significa documentarsi su chi l’ha percorsa prima di noi, ascoltare musica, guardare foto e film, leggere romanzi. Significa guidare con il finestrino abbassato, senza l’aria condizionata, solo così la strada potrà essere un’esperienza di vita e non “solo” un grande viaggio.
Questo viaggio deve essere preparato non sul web e sulle migliaia di libri che ne parlano dal punto di vista turistico, questo è un viaggio dell’anima, occorre prepararsi spiritualmente ad una esperienza che sarà forte e travolgente, nulla sarà più come prima. Partire per la Route 66 significa documentarsi su chi l’ha percorsa prima di noi, ascoltare musica, guardare foto e film, leggere romanzi. Significa guidare con il finestrino abbassato, senza l’aria condizionata, solo così la strada potrà essere un’esperienza di vita e non “solo” un grande viaggio.


Andiamo per ordine: il nome corretto di questo piccolo stato himalayano è Bhutan e non Buthan, in poche persone lo conoscono, molti non lo hanno neanche mai sentito nominare, eppure esiste sulle mappe di Google, sugli Atlanti moderni ed è uno dei Paesi al mondo con la miglior qualità della vita…
Il Bhutan è l’unico Paese al mondo ad avere il Ministero della Felicità! Lo ha voluto il Re per i suoi Sudditi e funziona benissimo: la gente sta davvero bene e si vede… Il nome Bhutan è incerto, c’è chi dice derivi dal sanscrito Bhota-ant, ossia “la fine del Bhot” cioè del Tibet, oppure dal sanscrito Bhu-uttan che significa “alte terre” poichè siamo alle pendici dell’Himalaya.
La bandiera è rettangolare ed è divisa in due triangoli con il giallo che rappresenta la monarchia, e l’arancione che rappresenta la religione buddhista; sulla bandiera campeggia un drago simbolo di benessere.

Ho chiesto alla mia guida se fosse vera la voce che ci era giunta che in Bhutan esiste il ministero della felicità o fosse solo una fake news che corre tra noi Viaggiatori occidentali alla ricerca di esotiche stranezze. Ebbene si, il Ministero della Felicità esiste ed è un ministero unico che si occupa a livello centralizzato di tre cose ritenute fondamentali per il benessere dei Sudditi del giovane Re: Pubblica Istruzione, Sanità e Lavoro.
L’Istruzione viene garantita gratuita ed è obbligatoria per tutti fino alla scuola superiore, poi chi vuole frequentare l’Università deve andare all’estero grazie a progetti finanziati dalla Cooperazione Internazionale. Il Ministero si occupa poi della salute, e anche questa viene ad essere gratuita per tutti. In Bhutan ci sono pochi piccoli ospedali e vanno bene solo per il pronto soccorso e per i reparti di Ostetricia, per tutto il resto il Paese paga le cure all’estero per i suoi cittadini (mandandoli a curare soprattutto in India). Infine il Ministero della Felicità provvede al Lavoro di tutti: chi non ha come sostentarsi può fare richiesta di un terreno demaniale da coltivare: una concessione gratuita cui hanno diritto coloro i quali non hanno altri modi per sostentarsi.

Il sovrano illuminato sostiene che quando i suoi Sudditi hanno istruzione, sanità e lavoro hanno tutto il necessario per essere felici. E in effetti non sbaglia perchè camminando per le vie della Capitale Thimpu si percepisce un clima di serenità sui visi delle persone.
Ma per essere un Re amato e rispettato davvero dal suo Popolo ci vuole coerenza ed empatia con il Popolo. Qui in Bhutan il sovrano gira in città a piedi senza scorta e guida personalmente la sua auto (un normalissimo SUV), e ha l’Autista solo nei momenti Ufficiali come ad esempio le visite di altri Capi di Stato… Il padre dell’attuale sovrano, ha abdicato il Regno a favore del figlio Jigme Khesar Namgyel Wangchuck perchè a soli 53 anni sentiva che un giovane di 18 anni, meglio di lui, avrebbe saputo condurre il Paese.

Quando viaggio, mi piace guardare i numeri che mi danno la dimensione delle cose, un’idea, dei riferimenti, per capire cosa accade intorno a me. Un Regno con soli 800.000 abitanti: uno Stato intero che è popoloso come un quartiere di Roma…
Viene da chiedersi come gestire un territorio che comunque non è piccolo, con così poche risorse…. Ne esce un problema di Finanza anche perchè, qui non si pagano le tasse! Come fa lo stato a finanziarsi? Fortunatamente il Bhutan si trova ai piedi dell’Himalaya e grazie allo scioglimento delle nevi, i suoi fiumi sono sempre in piena e hanno una portata di acqua enorme: le potenti dighe quindi producono energia elettrica che viene venduta alla Cina e all’India e gli incassi che ne derivano sono sufficienti e sostentare la macchina statale senza che le persone siano obbligate a pagare le tasse.
Le tasse le pagano solo le grosse Compagnie straniere e la gente vive con uno stipendio comunque dignitoso che gli permette di vivere ed essere realmente felici.

In Bhutan c’è l’obbligo, per tutti i dipendenti pubblici, di vestire con gli abiti tradizionali, e nei giorni di festa l’obbligo è esteso a tutti i Cittadini, e siccome ci sono decine di giorni di festa ogni anno in tutto il Paese, da queste parti è più facile vedere le persone vestite con abiti tradizionali che con abiti moderni! Tutto questo è previsto dal “codice delle buone maniere” che qui chiamano Driglam namzha.
Il vestito tradizionale maschile si chiama Gho, è una sorta di lunga vestaglia e lascia le gambe coperte dai lunghi calzettoni neri, la parte alta, con il bavero abbondante, viene usata come se fosse un grosso tascone, una sorta di marsupio nel quale ciascuno può tenere oggetti, documenti, cibo, attrezzi e tutto ciò che in essa può essere trasportato. La cintura nera che li cinge in vita è la Kera ed è fondamentale proprio perchè fa da “fondo” al tascone. Per le donne c’è invece la Kira, un vestito lungo fino alle caviglie fatto con tessuti colorati e decorato con disegni geometrici tradizionali.

Ma in Bhutan la tradizione non è solo negli abiti, qui viene mantenuta viva anche nelle case che devono avere un particolare tipo di finestra in legno sagomato e colorato secondo lo stile locale. E non è tutto: anche i colori ammessi in qualunque tipo di utilizzo pubblico o privato sono stati previsti in una speciale “mazzetta cromatica” che ne ammette solo alcuni escludendo tutti gli altri.
Il buddismo è la Religione di Stato in Bhutan ma c’è anche una certa apertura verso altre religioni come l’induismo e per le minoranze cristiane che possono professare però il loro credo solo in casa. I suoi festival di origine religiosa si svolgono all’interno degli Dzong che sono i tipici edifici del Bhutan con una curiosa funzione mista di centro militare, e allo stesso tempo anche religioso, tutto all’interno di uno stesso edificio. Gli dzong, vengono costruiti rispettando le regole di stile imposte per legge e naturalmente il lavoro di progettazione viene stabilito in accordo tra le autorità religiose e quelle civili.

Ogni dzong ospita un festival religioso annuale chiamato tshechu durante il quale si svolgono le danze con costumi coloratissimi che rappresentano animali reali o mitologici chiamate cham che possono durare per ore ad un ritmo lento e incessante, angosciante e tetro. Fondamentalmente le trame dei cham celebrano la vittoria del bene sul male con la sottomissione del diavolo e la liberazione dagli spiriti maligni.
Durante i cham, tra i danzatori ufficiali che si esibiscono in faticose ed estenuanti coreografie rituali, fanno la loro comparsa assolutamente incontrollata delle figure di disturbo (anch’esse mascherate) che entrano liberamente e improvvisamente nella scena per ridurre la tensione. Hanno una ruolo fondamentale e allo stesso tempo irriverente e dissacrante e portano gli spettatori (e i bambini in particolare) a grosse risate inaspettate e nessuno si mostra disturbato dalla loro presenza che ha esattamente la funzione del clown nel nostro circo durante l’esibizione del domatori di leoni.

Un vero Viaggiatore prima di partire sa darsi un obiettivo, ha uno scopo per decidere di fare quel viaggio. Ciò che ci spinge a metterci in viaggio non è mai la meta finale, la destinazione non è un punto di arrivo, ma il concretizzarsi di un “percorso” che a volte dura anni e che nulla ha a che fare con la “strada” necessaria per arrivare. Ciascun Viaggiatore si chiede quindi prima il perchè sceglie una meta piuttosto che un’altra, e ciascuno avrà una risposta diversa da tutti gli altri.
Mi sono chiesto anche io perchè il Bhutan, perchè raggiungere una destinazione tanto insolita, un Paese quasi del tutto sconosciuto al Turismo nel quale arrivano ogni anno solo 20.000 Turisti da tutto il mondo, metà dei quali sono Indiani. Il Visto “all inclusive” che costa circa 250 dollari al giorno comprende anche il pernottamento, i pasti e la guida locale obbligatoria più i trasporti interni con autista privato e le tasse di soggiorno.

Sono andato in Bhutan perchè mi piacciono i viaggi etnici, e scoprire culture lontane, mi piace il rapporto tra la gente e la religione, documentare la spiritualità delle persone che vivono in Paesi in cui la religione è un valore costituzionale e fa parte della struttura sociale.
Sono andato fino in Bhutan appositamente per fotografare i Festival di Punakha e di Thimphu che si svolgono in ottobre a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Tutto il viaggio è durato 8 giorni di cui quattro li ho passati nei festival vivendo le danze in mezzo alla gente: qui gli spazi sono aperti e la libertà di muoversi è assoluta: ci si può sedere anche accanto al Re, se si trova un posto libero nella Tribuna d’Onore.

Il popolo è accogliente e sorridente: questa gente ti apre le porte di casa per farti entrare e offrirti un tè anche se non ti ha mai visto prima. Molti di loro vivono in campagna coltivando riso sui campi terrazzati a gradoni e sono molto ospitali con i pochi stranieri che si spingono fino in Bhutan a scoprirne la cultura. In Bhutan tutto è a misura d’uomo: basti pensare che in tutto il Paese non esiste un semaforo e che gli incroci principali sono controllati da vigili urbani che dirigono il traffico in guanti bianchi, grazie al Ministero della Felicità qui non esiste la disoccupazione.
In tutto il Bhutan c’è un solo aeroporto, a Paro, incastrato in una valle e il suo atterraggio è così complicato che ci sono solo 6 piloti al mondo abilitati a farlo. Tutti questi mi sono sembrati motivi più che sufficienti per scoprire che il Paese in cui tutti vorremmo vivere per essere felici esiste davvero e si chiama Bhutan.
Ah… Ricordate un’ultima cosa: in tutto il Bhutan è severamente vietato fumare!


Oggi parliamo della nostra Bella Italia e delle sue tradizioni così affascinanti che fino alle restrizioni dovute al covid 19 riempivano i calendari di tutto lo Stivale.
A pochi passi da Latina esiste (o meglio esisteva prima del covid) una realtà quasi sconosciuta eppure molto sentita: ci troviamo a Priverno e qui la Processione del Venerdì Santo ha radici profonde e un fortissimo senso religioso. Il Paese intero si riversa in strada non solo per assistere, ma per partecipare attivamente alla sacra sfilata. Tra loro le Anime Nere: due detenuti anonimi che volontariamente in segno di penitenza camminano scalzi e con i piedi incatenati portando una croce sulle spalle.

A Priverno si celebra la Passione di Cristo non è una rievocazione storica come avviene in tante altre località, qui viene vissuta attraverso il suo significato simbolico.
Tutto ha inizio nella Cattedrale: i membri delle confraternite (Anime Bianche) si riuniscono in preghiera nel tardo pomeriggio. Con loro ci sono i due detenuti (Anime Nere) che con un permesso speciale dell’autorità carceraria escono appositamente dal carcere per manifestare il loro pentimento e per espiare le loro colpe davanti a Dio, e alla società seppur protetti dall’anonimato del cappuccio che ricopre i loro volti.

In chiesa entrano scalzi e tali resteranno fino alla fine, quando escono per la processione i loro piedi vengono legati con pesanti catene e sfilano accompagnati dai Carabinieri. Il clima è di silenziosa preghiera e di profondo rispetto. Si percepisce un silenzio sacro ma non muto. L’emozione è forte, ci si sente circondati da migliaia di persone a lutto. Dappertutto c’è un enorme silenzio. Non c’è la banda, qui si celebra in strada il funerale di Cristo.

La folla dei fedeli esce dalla chiesa accolta da una piazza gremita di altre migliaia di persone. Tutti hanno un ruolo, chi porta un vessillo, chi un enorme lampadario a bracci che rischiarerà la marcia notturna di tutti, chi canta e chi trasporta le statue sacre della passione. E’ questo il momento in cui alle Anime nere vengono incatenati i piedi e caricate le pesanti croci sulle spalle: le portano in segno di penitenza per più di due ore.

Il corteo viene aperto dai cori delle contrade che lo precedono lungo tutta la via crucis, nei vicoli vengono fatte delle soste in prossimità di tutte le chiese del paese. I personaggi incappucciati in bianco precedono le Anime Nere e ne annunciano il passaggio, poi sfilano i penitenti con i loro pesanti carichi sia dal punto di vista fisico che emotivo. Il rumore delle catene che strusciano sul selciato a sampietrini rompe il profondo silenzio che ammanta il paese e scandisce il passo dei due uomini che si fanno carico della croce di Cristo. La statua del Cristo disteso chiude poi la lunga colonna umana.

Le Anime Nere che la gente qui chiama i Sacconi, sono quelli che espiano pubblicamente le loro colpe, tutto qui è rituale e simbolico: i buoni sono bianchi, i cattivi sono neri. E’ l’alternanza tra il bene e il male, tra chi sceglie la retta via e chi la ha lasciata per poi ravvedersi. E ci sono i Carabinieri in divisa, in un apparente mescolamento tra sacro e profano, ma si tratta di un gioco di ruoli, un sottile gioco delle parti in cui ciascuno incarna un personaggio.

 A volte partiamo per lunghi viaggi alla ricerca di rituali lontani e culture diverse dimenticando di cercare le nostre origini sociali e culturali a poca distanza da noi. Vivere qui una serata così intensa è un’esperienza da non perdere (anche per chi non è credente): l’aspetto antropologico, culturale e spirituale è enorme. Vi sembrerà di vivere in un sogno, qui tutto è rarefatto, lontano nel tempo e nello spazio sembra incredibile ma siamo a pochi chilometri da Roma, e la spiritualità è fortissima.
A volte partiamo per lunghi viaggi alla ricerca di rituali lontani e culture diverse dimenticando di cercare le nostre origini sociali e culturali a poca distanza da noi. Vivere qui una serata così intensa è un’esperienza da non perdere (anche per chi non è credente): l’aspetto antropologico, culturale e spirituale è enorme. Vi sembrerà di vivere in un sogno, qui tutto è rarefatto, lontano nel tempo e nello spazio sembra incredibile ma siamo a pochi chilometri da Roma, e la spiritualità è fortissima.
Priverno riscopre una sua identità che non ha varcato i confini del proprio territorio e che quindi non è ancora diventato un’attrazione turistica. A Priverno, ogni anno, il Venerdì Santo, farete un viaggio alla ricerca di una valori dimenticati, di un’Italia che “non esiste solo al sud”.


 Oggi 13 marzo 2021 intorno alle ore 18, il mondo della fotografia piange uno dei suoi più indiscussi Maestri.
Oggi 13 marzo 2021 intorno alle ore 18, il mondo della fotografia piange uno dei suoi più indiscussi Maestri.
E’ morto Giovanni Gastel ci ha lasciati oggi a soli 65 anni a causa del Covid-19. Sono cresciuto con le sue immagini: 30 anni fa, quando ho iniziato ero solo un ragazzino e lui, poco più grande di me era già Giovanni Gastel
Una persona raffinata, colta, elegante, un grande ritrattista che si è contraddistinto per le sue immagini pulite, creative, potentissimi strumenti di comunicazione che per 40 anni esatti hanno segnato la storia della fotografia commerciale, moderna e contemporanea.
Giovanni Gastel ha fotografato le donne più belle del mondo rendendole ancora più affascinanti e mai volgari, mai ammiccanti ma sempre sature di infinita personalità. Ma a parte una sua predilezione per il le donne ha fotografato anche tanti uomini, artisti, industriali, politici…
Una persona che ha sempre avuto intorno a se solo stima e mai clamore, mai uno scandalo, uno dei pochi di cui si poteva solo parlare bene e del quale mai nessuno è riuscito a mettere in dubbio l’efficacia e del suo stile semplice e inconfondibile.
Giovanni Gastel nasce a Milano il 27 dicembre 1955 ultimo di sette figli e nipote di Luchino Visconti, inizia la sua carriera nel 1981 a soli 26 anni collaborando con riviste come Vogue Italia e Rolling Stone, e firmando nei rampanti anno ’80 campagne pubblicitarie per i più grandi stilisti di tutto il mondo tra cui Versace, Missoni, Trussardi, Dior, Nina Ricci, Guerlain e molti altri.
Quel che mi piaceva di lui era la semplicità: non aveva bisogno di urlare. A Gastel bastavano pochi elementi, schemi di luce piena senza effetti drammatici e senza speculazioni. Lui sapeva tirare fuori la bellezza intrinseca dei suoi soggetti. Di lui ricordo i suoi Polaroid scattati con il banco ottico 20×25, delle opere d’arte che hanno segnato la mia formazione e la mia crescita fotografica.
 La sua mostra al MAXXI di Roma è finita il 5 marzo 2021, 8 giorni fa. Di lui mi piaceva molto anche il lato umano che emergeva dalle sue pagine Social nelle quali spiegava ogni giorno i motivi della sua arte, cosa spingeva i suoi scatti, quali erano le sue emozioni a stare dietro alla fotocamera. Le pagine social in cui pochi mesi fa, nell’autunno 2020, non parlava più di fotografia ma del fatto di essere diventato nonno e della sua enorme gioia di questo.
La sua mostra al MAXXI di Roma è finita il 5 marzo 2021, 8 giorni fa. Di lui mi piaceva molto anche il lato umano che emergeva dalle sue pagine Social nelle quali spiegava ogni giorno i motivi della sua arte, cosa spingeva i suoi scatti, quali erano le sue emozioni a stare dietro alla fotocamera. Le pagine social in cui pochi mesi fa, nell’autunno 2020, non parlava più di fotografia ma del fatto di essere diventato nonno e della sua enorme gioia di questo.
Oggi sono triste, davvero. Di lui non voglio dire molto di più. Vi lascio con le sue parole, quelle che potete andare a leggere voi stessi sulla sua pagina facebook: https://www.facebook.com/GiovanniGastelFotografo
Ciao Maestro, grazie di aver ILLUMINATO la mia fotografia.

Il progetto ‘Madonne’, ideato da me e il grandissimo stylist Simone Guidarelli, con la bellissima modella Beatrice Brusco nasce dall’idea di lasciare un interpretazione contemporanea della Vergine come tutte le epoche hanno fatto attraverso l’arte. L’ispirazione è alle Madonne barocche e andine.
Il mio amore per la figura della Santissima Vergine Maria come simbolo del massimo amore e insieme del massimo dolore è immenso!

Le donne sono state per tutta la mia vita faro e muse del mio cammino. Ancora oggi dedico a loro il mio lavoro fotografico e letterario!
Grazie mille vi amo tutte e vi ringrazio di essermi sempre vicine.

Foto dell’amico e sublime danzatore Roberto Bolle che ho avuto la gioia di fotografare la prima volta a 18 anni nel foyer del teatro alla Scala quando era già un promessa della danza mondiale. Qua Roberto siede pensoso, per una volta nella platea.

Mi ha sempre affascinato la commistione contenuta nella Mitologia tra Esseri di diversa natura. Quasi un monito a non allontanarci da essa.
Macchina: Plaubell 300 mm su Polaroid 20×25
Foto rielaborate con sovrapposizioni e filettature in post-produzione

Quando Luciana è arrivata da me era visibilmente contraria all’idea di farsi ritrarre. Allora ho cercato di calmarla e alla fine ne è uscito questo ritratto in cui si è riconosciuta con grande gioia.
Liberatoria immagini – copyright
Le immagini e i testi scritti in corsivo su questo articolo sono state reperite su internet, principalmente tramite ricerca libera con il motore di Google e sulla pagina Facebook di Giovanni Gastel. Dunque, proprio perchè trovate liberamente su pagine web, sono state giudicate di pubblico dominio. In ogni caso si precisa che se qualcuno, potendo vantare diritti su immagini qui pubblicate, avesse qualcosa in contrario, può scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica : dp@iss.sm per chiederne la rimozione delle stesse, rimozione che nel caso verrà immediatamente effettuata.
Questo sito utilizza il diritto di corta citazione:
l’art.70, legge 22 aprile 1941 n° 633 (recante norme sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) dispone che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d’opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Con il decreto legislativo n°68 del 9 aprile 2003 è stata introdotta l’espressione di comunicazione al pubblico, per cui il diritto non è esercitabile solo per i vecchi mass media, ma anche per i nuovi come da ultimo il web.


 Harry Gruyaert nasce a Antwerp (Belgio) nel 1941, dal 1959 al 1962 ha studiato presso la scuola di cinema e Fotografia di Bruxelles, in seguito si trasferisce come fotografo freelance a Parigi, dove ha cominciato a lavorare nel campo della pubblicità e dove divenne in seguito direttore della Flemish Television.
Harry Gruyaert nasce a Antwerp (Belgio) nel 1941, dal 1959 al 1962 ha studiato presso la scuola di cinema e Fotografia di Bruxelles, in seguito si trasferisce come fotografo freelance a Parigi, dove ha cominciato a lavorare nel campo della pubblicità e dove divenne in seguito direttore della Flemish Television.
Gruyaert ha il desiderio di viaggiare e fotografare e soprattutto di scoprire il mondo, prima della fine degli anni ’70 avrà già lavorato in moltissimi luoghi, visitando paesi come :India, Stati Uniti, Egitto Giappone e Marocco. Ora è pronto per tornare nel paese d’origine, il Belgio, per cominciare a lavorare sulla ricerca del colore.
 Gruyaert non si considera un fotoreporter, ma ha adottato questa filosofia “ Non ci sono storie, è solo una questione di luci e forme”, come affermato in una sua intervista di qualche anno fa .
Gruyaert non si considera un fotoreporter, ma ha adottato questa filosofia “ Non ci sono storie, è solo una questione di luci e forme”, come affermato in una sua intervista di qualche anno fa .
I primi tempi non sono stati molto semplici, in quanto tutto ciò che riguardava la fotografia di strada, fino a quel momento, vedeva una netta predominanza del bianconero e quindi i suoi scatti erano visti con molto scetticismo, ma continuerà incessantemente a esplorare il colore fino a farlo diventare uno dei fotografi più importanti del panorama europeo.
 Non aveva importanza dove si trovasse, poteva essere in Belgio come a Las Vegas, ad Anversa oppure a Mosca o a Los Angeles, il suo scopo finale è sempre stato quello di far emergere il colore da qualunque elemento gli si prospettasse davanti.
Non aveva importanza dove si trovasse, poteva essere in Belgio come a Las Vegas, ad Anversa oppure a Mosca o a Los Angeles, il suo scopo finale è sempre stato quello di far emergere il colore da qualunque elemento gli si prospettasse davanti.
Gruyaert ha sempre avuto la capacità di lavorare con qualsiasi condizione di luce, realizzando immagini straordinarie, non si limitava a sfruttare la luce naturale, sapeva usare a proprio piacimento qualunque tipo di illuminazione avesse a disposizione, luci a neon, lampioni, insegne di caffè, tutto poteva essere usato.
 Quando ha cominciato a scattare a colori, non erano stati pubblicati moltissimi lavori, negli Stati Uniti “William Eggleston’s Guide” ed in Italia “Kodachrome” di Luigi Ghirri, giusto per citare due autori che hanno usato il colore in maniera esemplare.
Quando ha cominciato a scattare a colori, non erano stati pubblicati moltissimi lavori, negli Stati Uniti “William Eggleston’s Guide” ed in Italia “Kodachrome” di Luigi Ghirri, giusto per citare due autori che hanno usato il colore in maniera esemplare.
Nel 1981 gli viene proposto di realizzare un lavoro per la rivista “GEO” a Las Vegas, una di quelle città americane dove il colore è presente in ogni luogo, soprattutto la notte. Ma Gruyaert sceglie un approccio diverso e decide di raccontare la Las Vegas di giorno perchè considerava troppo facile lo spettacolo della notte della città del gioco.
 Nel suo lavoro si ritrova tutta l’iconografia americana, centri commerciali, stazioni di servizio, autostrade, parcheggi, automobili, hotel e le persone che vivono questi luoghi, ma non sono mai invadenti, tutto è concentrato e basato sempre sul colore.
Nel suo lavoro si ritrova tutta l’iconografia americana, centri commerciali, stazioni di servizio, autostrade, parcheggi, automobili, hotel e le persone che vivono questi luoghi, ma non sono mai invadenti, tutto è concentrato e basato sempre sul colore.
L’anno seguente, il 1982, sarà invitato a far parte dell’agenzia Magnum.
Gruyaert ha lavorato fino al 2009 con pellicola Kodachrome, anno di cessazione della produzione, convertendosi poi al digitale con il quale continua a lavorare.
 Le sue immagini sono sempre state in anticipo sui tempi, un po’ come quelle di William Eggleston, Joel Sternfeld, Stephen Shore, Luigi Ghirri, Guido Guidi giusto per citarne alcuni, e continuano a mantenere ancora una contemporaneità assoluta.
Le sue immagini sono sempre state in anticipo sui tempi, un po’ come quelle di William Eggleston, Joel Sternfeld, Stephen Shore, Luigi Ghirri, Guido Guidi giusto per citarne alcuni, e continuano a mantenere ancora una contemporaneità assoluta.
Pur non considerandosi un testimone di qualcosa, è indubbio che gli scatti di Harry Gruyaert rappresentano dei documenti importantissimi sul tempo che scorre.
 I suoi colori continuano ad emozionarci a distanza di anni, il giallo, il rosso, il verde, l’azzurro ci fanno reagire come se fossimo presenti sulla scena, questo è la capacità e la maestria dei grandi fotografi, far rivivere il momento dello scatto attraverso il tempo.
I suoi colori continuano ad emozionarci a distanza di anni, il giallo, il rosso, il verde, l’azzurro ci fanno reagire come se fossimo presenti sulla scena, questo è la capacità e la maestria dei grandi fotografi, far rivivere il momento dello scatto attraverso il tempo.
Siti riferimento
https://www.magnumphotos.com/photographer/harry-gruyaert/
http://www.harrygruyaert-film.com/
Roberto Bianchi:
Facebook: https://www.facebook.com/robybianchi


Dal nostro Viaggio Fotografico Cracovia Innevata presentiamo questo video creato con le foto di Enrico Cambiaso fatte nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. In quei luoghi di sterminio la lucida follia nazista ha sterminato 6 milioni di ebrei. Insieme a loro sono morti altri zingari, omosessuali, dissidenti politici e altre persone colpevoli solo di non essere appartenenti alla “razza ariana”.
Il video che trovi in questa pagina è l’urlo che echeggiava nella fabbrica della morte al passaggio di quegli esseri umani che avevano perso anche la dignità di sentirsi persone.
“Eravamo persone” dicevano, ma dopo aver varcato quel cancello hanno smesso di esserlo, erano diventati numeri, cose senza valore.
La breve vita che esisteva nei campi era, quasi per tutti, quel lasso di tempo che andava tra l’arrivo del treno e l’entrata nelle camere a gas. La vita poteva durare poche ore o pochi giorni.
Il vero problema è stato per i pochissimi sopravvissuti che sono tornati a casa tenendo il dolore dentro di se per lunghi anni. Testimoni raccontano che avrebbero preferito la morte a convivere con il ricordo.
Per ricordare, per non dimenticare. Nel Giorno della Memoria della Shoah.
Puoi commentare questo Articolo, lasciare una testimonianza, un tuo pensiero o anche una preghiera in memoria nello spazio apposito qui sotto.
La musica Dissociation è di Naoya Sakamata è libera da Diritti di Utilizzo e puoi ascoltarla sul canale You Tube dell’Autrice: https://www.youtube.com/watch?v=T9yWYs0XsQk

Questo video di Giusy Scigliano è stato realizzato ad Auschwitz durante il nostro Viaggio Fotografico Cracovia Innevata, edizione 2016.
Pubblichiamo per ricordare, per non dimenticare.
Il Video:
Il grande merito di Giusy Scigliano è quello di aver raccontato Auschwitz non solo con immagini potenti ed esplicite, ma ha saputo mostrarci la storia che è dietro di esse. La colonna sonora che ha scelto è assolutamente perfetta per dare la giusta enfasi a questo lavoro che resta come una vera pietra miliare tra i lavori prodotti durante i nostri itinerari in tutto il mondo.
Ringraziamo l’Autrice per averci gentilmente concesso di pubblicare e condividere il suo video.
Lasciamo a Voi la visione straziante e la possibilità di commentare il video nello spazio che trovate in fondo alla pagina.

Non prendetemi per pazzo, ho viaggiato in 48 Paesi ma la nostra Italia è il più straordinario di tutti e ci è voluto il Covid-19 per farmela riscoprire in tutta la sua prorompente bellezza.
Abituato a viaggiare a lungo, lo faccio spesso seguendo le strade storiche di tutto il mondo dalla Route 66 alla Panamericana, alla Via della Seta… Ma fare un itinerario del genere rimanendo nel nostro Belpaese è un’esperienza davvero irripetibile. Quale altro posto al mondo se non l’Italia può vantare una così ampia varietà di stimoli culturali, storici, etnici, enogastronomici e paesaggistici? Davvero nessuno… Altri Paesi nei quali c’è qualcosa da vedere bisogna guidare per giorni per passare da un punto di interesse ad un altro. In Italia si trovano location inesplorate ogni 20 chilometri. Ogni angolo testimonia un grande passato, una storia millenaria.

Da tempo sognavo di fare un grande viaggio tutto italiano, e quest’anno finalmente ne ho avuto l’occasione ad agosto: ben dodici giorni per fare soli 650 chilometri percorrendo tutto il tracciato dell’Antica Via Appia da Roma a Brindisi. Li ho percorsi lentamente, apprezzando ogni pietra miliare che mi ricordava quanto Roma si allontanasse pian piano dietro di me. Un lungo lavoro di ricerca e organizzazione mi hanno portato a disegnare questo itinerario interessantissimo nella nostra storia italiana.
La via Appia, tra le strade Consolari romane, da sempre è stata la più importante arteria di comunicazione, tanto da essere nominata come la Regina Viarum. Molto più di un semplice collegamento tra luoghi; l’Appia stessa è un luogo dotato di una identità, di una storia autonoma che le ha permesso di sopravvivere per 2000 anni e mantenere il suo fascino e la sua funzione. L’Appia è stata la meta stessa del mio viaggio.

Non è un caso che lungo questa strada siano passati papi, eserciti, merci e bestiame. Ma non solo: è stata il luogo in cui sono transitate culture, lingue e popolazioni ciascuna delle quali ha influenzato profondamente il tracciato lasciando i segni evidenti del suo passaggio e rendendolo un mix concentrato di storia. Infatti, una volta arrivati a Brindisi, attraversando il Mediterraneo sia arrivava in Grecia e poi da lì il viaggio continuava verso oriente, fino in Cina seguendo la Via della Seta…
Lungo l’Appia sono nate e hanno prosperato città e paesi di straordinaria bellezza e oggi divenuti Patrimoni UNESCO: Roma, Caserta, Benevento, Matera sono le più famose, ma poi ci sono Melfi, Terracina, Santa Maria Capua Vetere, Gravina in Puglia, Venosa. Meno note ma non meno belle e fascinose…
Pensando a tutto questo, mi stuzzicava molto l’idea di fare un viaggio per riunire tutti questi punti legati tra loro da una Storia comune e non solo da una strada che li unisce semplicemente.

Il Viaggio non è una vacanza, ma è un percorso mentale, uno stato emotivo con il quale ci apprestiamo ad aprire i nostri confini mentali e cognitivi per arricchirci di esperienza e di conoscenza. Percorrere una strada storica è uno dei modi migliori per ottenere tutto questo: mentre viaggiamo non percorriamo chilometri, ma ordiniamo le nostre idee, allarghiamo la nostra visione del mondo.
L’Appia mi ha permesso di fare tutto questo, di fare un vero Viaggio in Italia, non per scoprire culture lontane, ma per ri-trovare le mie origini, ciò che è scritto nel mio DNA. Un viaggio interiore.

Un viaggio come questo richiede una lunga e accurata documentazione prima di fare i bagagli. La prima idea è stata quella di fare tutto il tracciato a piedi o in mountain bike, ma ho poi desistito perchè il mio scopo principale era andare a documentare il percorso con la fotocamera e ho preferito l’auto per gestire meglio gli spostamenti e avere più tempo per fotografare.
Ci sono in giro tantissime pubblicazioni, libri, guide che illustrano le varie tappe da cui prendere spunto e ispirazione, io ho trovato più utile studiare le mappe che adoro leggere e osservare, imparare a memoria prima di un viaggio. Le mappe on line e quelle cartacee più qualche sito ufficiale che riporta dettagliatamente il percorso, mi sono serviti per non lasciare nulla al caso. Ho usato anche alcune App fotografiche per pianificare i dettagli sugli orari del sole di cui avevo bisogno per scattare le mie foto con le condizioni di luce migliori.
Le tappe erano pianificate, ma gli Alberghi non li avevo prenotati, quando parto mi piace scoprire sul posto questi dettagli. Volevo che fosse il viaggio di un viandante, di un Viaggiatore che sa succhiare il piacere dell’avventura, che sa osservare il mondo che lo circonda e sa scegliere il miglior posto dove mangiare non dalle relazioni trovate on line, ma dai profumi che sento di giorno in giorno per strada.

Quando sono in viaggio per me l’odore di una strada vale più delle parole spese per descriverla, lo sguardo su un orizzonte vale più delle foto fatte per raccontarlo, e in Italia le emozioni si susseguono ravvicinatissime, una dopo l’altra. Il mio lavoro prima di partire è stato raggruppare i miei sogni, riunire e mettere in fila tutte le emozioni che mi aspettavo di trovare tra Roma e Brindisi. Ho cercato nel mio immaginario tutto ciò che avevo sentito dire su quel tratto di mondo. Ho fatto un vero e proprio brain storming per segnare sul percorso tutto ciò che avrei voluto vivere e sperimentare.
Nella mia lista avevo previsto anche la gastronomia legata ai luoghi: impossibile parlare di Roma senza pensare alla Carbonara. Inutile andare a Caserta senza assaggiare la mozzarella o la pizza e passare per Matera senza prevedere un piatto con i peperoni cruschi. Superficiale transitare in Puglia senza provare il piacere del pane cotto a legna…

La cosa più difficile da organizzare è stata la scelta dei luoghi: pur sapendo che avrei fatto tutto il tracciato dovevo comunque escludere qualcosa e, vista la quantità enorme di siti, la scelta è stata impegnativa.
Ad esempio, l’attuale SS7 via Appia, NON è, se non in piccoli tratti, la via Appia Antica. Molto spesso infatti le due strade corrono parallele ma su percorsi diversi magari distanti qualche chilometro.

Ho cercato metro per metro i tracciati originali, spesso la vecchia Regina Viarum ha perso la sua importanza diventando un tratturo di campagna percorso solo da greggi e pastori. Una ricerca impegnativa però interessantissima e divertente da fare. Erano proprio questi i tratti che di più mi è piaciuto cercare e poi ritrovare.
Ho segnato sulla mappa ogni singola location che volevo raggiungere per fotografarla con lo stesso entusiasmo di chi disegna il luogo in cui ha nascosto il proprio tesoro.
Questo perchè il viaggio è una metafora di vita, e nella vita come nel viaggio non c’è nulla di più bello che decidere dove andare e arrivarci lentamente godendosi non solo la destinazione, quanto la strada fatta per arrivarci.

Finalmente si parte.
Eravamo in due, io e Simona, la mia compagna di vita e di strada. Non mi piace partire da solo, preferisco avere un buon compagno anche se poi quando siamo in giro viviamo esperienze percettive parallele ma non uguali pur facendo le stesse cose nello stesso momento. In viaggio è bello trovare i propri spazi di indipendenza, fare dei tratti di strada da soli per poi raccontarseli una volta arrivati a destinazione la sera davanti ad una birra ghiacciata e con le foto scaricate nel computer.
Pochi bagagli, nessuna prenotazione. Era l’estate indimenticabile del 2020, subito dopo il primo lungo lockdown imposto dal covid. Siamo partiti per la prima volta nella nostra vita mettendo le mascherine tra le cose necessarie: con quella ritrovata voglia di viaggiare unita alla nuova paura di contagiarsi tra la gente che avremmo incontrato. Non si può viaggiare con la diffidenza, ma la prudenza è sempre necessaria.
La cosa più bella di questo viaggio è stato il goderselo a partire da Roma, la città in cui vivo e che non finisce mai di stupirmi. Roma è parte integrante di questo itinerario fatto di storia e cultura, di paesaggio e gastronomia. Siamo arrivati fino a Brindisi godendoci ogni passo con lentezza e con consapevolezza.

In 650 chilometri si incrociano testimonianze dei Romani, degli Svevi, dei Normanni e dei Longobardi ma anche dei Sanniti e dei Borbone… La storia si mescola lungo questa strada percorsa da Papi e Cardinali per arrivare fino a Melfi per fare 5 concili in questa piccola cittadina fortificata in provincia di Potenza tutta da scoprire. Osservando le città lungo la strada si sentono palesemente le influenze di tutto questo…
L’Appia attraversa le grandi Pianure Pontine e il Tavoliere delle Puglie e valica gli Appennini passando in paesaggi modificati da migliaia di pale eoliche che producono energia pulita rispettando la natura. Campi coltivati e pascoli enormi si susseguono e si alternano alle grandi grandi aziende che sorgono in prossimità della strada e movimentano le loro merci lungo di essa in un percorso che non annoia mai. La varietà di ambienti è proprio il grande valore aggiunto di questo Viaggio.

La strada unisce due mari e passa dai tramonti che si vedono sul Tirreno (nel tratto fra Terracina e Formia) fino alle albe da godere sull’Adriatico a Brindisi dove le colonne Romane sul porto indicano la fine della strada. Vedere un tramonto sull’Adriatico (rimanendo in Italia) è infatti possibile solo da Trieste.
E’ bello attraversare 4 Regioni e ad ogni sosta, in pochi chilometri sentire i dialetti sempre diversi ogni volta che parli con qualcuno anche solo per ordinare un caffè… Il viaggio è anche questo: imparare ad ascoltare ciò che ci circonda, parlare con la gente, sentire il calore genuino dell’accoglienza meridionale.
L’Appia Antica mi resterà nel cuore. Uno straordinario Viaggio da fare a casa nostra.
BUON VIAGGIO A TUTTI
 L’Articolo è pubblicato anche sul mensile Acqua & Sapone nel numero di gennaio 2021: https://www.ioacquaesapone.it/leggi/?n=asgennaio2021#102
L’Articolo è pubblicato anche sul mensile Acqua & Sapone nel numero di gennaio 2021: https://www.ioacquaesapone.it/leggi/?n=asgennaio2021#102


 La sacralità del luogo
La sacralità del luogo Il Kumbh Mela è una di quelle esperienze che non si dimenticano, che quando torni a casa senti che qualcosa è cambiato, che hai partecipato ad un evento emotivamente forte, sconvolgente e affascinante.
Il Kumbh Mela è una di quelle esperienze che non si dimenticano, che quando torni a casa senti che qualcosa è cambiato, che hai partecipato ad un evento emotivamente forte, sconvolgente e affascinante.
Non è solo un evento religioso, o un ritrovo di fedeli che si riuniscono in preghiera condividendo tradizioni o rituali, ma è la più grande manifestazione religiosa del Mondo.
Un enorme pellegrinaggio che coinvolge, a seconda degli anni, fino allo spaventoso numero di 100 milioni di persone.
Siamo in India, nello Stato dell’Uttar Padesh, e precisamente ad Allahabad, città in cui confluiscono i tre fiumi sacri agli induisti: il Gange, lo Yamuna e il mitico Sarasvati, oggi scomparso, o a detta di alcuni quasi totalmente sotterraneo, ma che mantiene ancora  vivo per i fedeli il Culto della Dea da cui prende il nome.
vivo per i fedeli il Culto della Dea da cui prende il nome.
La storia del Kumbh Mela e le sue celebrazioni sono legate a leggende dai forti connotati mitologici ed astrali, e come in tutti i poemi epici che si rispettino, anche qui buoni e cattivi combattono, e combattono per 12 giorni e 12 notti finchè Vishnu, che aveva ordinato di agitare gli Oceani per ottenere il nettare dell’Immortalità, chiamato Amrita, ne fece cadere alcune gocce nei quattro luoghi che così divennero sacri : Allahabad, Haridwar, Ujjain, e Nashik.
Proprio in queste quattro città si svolge a rotazione, ogni tre anni, questo importantissimo pellegrinaggio.
 L’esperienza umana
L’esperienza umana C’erano 50 milioni di persone attorno a me. 50 milioni di persone che camminavano, camminavano ininterrottamente, giorno e notte, senza sosta. 50 milioni di pellegrini, fedeli delle più svariate sètte induiste (akhada), che hanno attraversato il paese con treni speciali, pullman, camion, ed ogni altro mezzo di fortuna per radunarsi in un’area di non più di 20 km di lunghezza per 32 km quadrati di superficie.
C’erano 50 milioni di persone attorno a me. 50 milioni di persone che camminavano, camminavano ininterrottamente, giorno e notte, senza sosta. 50 milioni di pellegrini, fedeli delle più svariate sètte induiste (akhada), che hanno attraversato il paese con treni speciali, pullman, camion, ed ogni altro mezzo di fortuna per radunarsi in un’area di non più di 20 km di lunghezza per 32 km quadrati di superficie.
Inimmaginabile per noi occidentali, impossibile da capire, troppo lontano dalla nostra cultura e dalla nostra esperienza umana.
E soprattutto difficile da descrivere. Quasi impossibile.
Il mio primo impatto in quest’area che sembrava un enorme campo tendato, è stata una scena che ricordava l’esodo biblico.
Decine… centinaia… migliaia di poverissimi pastori che venivano dallo Stato del Bihàr, nell’India nordorientale, arrivati qui con 5 pullman, ogni pullman con più di 100 persone.
 Scendevano ordinatamente da un alto terrapieno, non si vedeva l’inizio della sterminata fila di persone. Arrivavano cantando, vestiti con quanto di più povero potessero trovare, tutto ciò di cui avevano bisogno era racchiuso in fagotti di tela che portavano sulla testa o annodati in lunghi bastoni poggiati sulle loro spalle.
Scendevano ordinatamente da un alto terrapieno, non si vedeva l’inizio della sterminata fila di persone. Arrivavano cantando, vestiti con quanto di più povero potessero trovare, tutto ciò di cui avevano bisogno era racchiuso in fagotti di tela che portavano sulla testa o annodati in lunghi bastoni poggiati sulle loro spalle.
I più religiosi portavano con sé della paglia. Erano a digiuno e avevano promesso a loro stessi di “dormire su un letto di paglia” finché non avessero fatto le abluzioni nei fiumi sacri.
Capitava spesso, infatti, di trovarne distese enormi lungo le rive dei fiumi, e sopra di esse altre distese di gente che si spogliava e rivestiva senza alcun pudore o soggezione, o paura di essere guardati male.
Si immergevano, quasi completamente svestiti, nelle acque gelide a qualsiasi età, e a qualsiasi ora, giorno o notte che fosse.
Spesso incontravo figli che portavano gli anziani genitori perché potessero fare la loro sacra immersione prima del trapasso che sentivano avvicinarsi.
Ed è proprio questo il motivo più profondo dell’essere qui, almeno una volta nella vita, per ogni Induista: un dovere che ognuno sente dentro di sé, come liberazione e purificazione dell’anima e dello spirito.
Questo è infatti quello che mi è stato detto anche dalla mia fidatissima guida:
“Ogni induista crede che sia molto importante andare almeno una volta nella vita sui luoghi sacri della religione Hindu per fare le abluzioni nelle acque del fiume Gange o degli altri fiumi sacri nei periodi del Kumbh Mela perché questi luoghi sono stati benedetti dalla divinità Vishnu.
Chi farà i bagni sacri nel corso di questi eventi verrà pulito di tutti i peccati e potrà seguire la strada per il moksha, ovvero la liberazione e la salvezza come condizione spirituale superiore”.

 La decisione di rimanere a dormire all’interno dell’area del Kumbh, senza tornare al nostro comodo campo tendato si è dimostrata vincente .
La decisione di rimanere a dormire all’interno dell’area del Kumbh, senza tornare al nostro comodo campo tendato si è dimostrata vincente .
Troppa folla, i ponti erano stati chiusi, se avessimo dormito al nostro campo non saremmo probabilmente riusciti arrivare nemmeno partendo a mezzanotte. Impossibile.
Con entusiasmo, molta curiosità e tanti chilometri a piedi, ci incamminammo così, verso il tendone dei Sadhu che ci avrebbero ospitati.
La strada era lunga parecchi chilometri, e quello che c’era intorno a  me era incredibile .
me era incredibile .
Fedeli poverissimi, famiglie con bambini, sadhu, asceti… Guru con vesti arancioni, o solo con perizomi bianchi, o semplicemente vestiti di cenere.
Tendoni delle varie sette, in ognuno dei quali c’erano cerimonie religiose, venivano accolti i fedeli, si mangiava, dormiva, pregava, predicava, accoglieva…
Sulla strada c’era chi benediva, e chi chiedeva donazioni possibilmente in moneta del paese di provenienza, o chi camminava verso chissà quale luogo dove fermarsi a dormire… chi lavava, cucinava, ed anche qualcuno che stirava.
 E il tutto con un’organizzazione perfetta, con gli eserciti di 5 Stati Indiani, decine di migliaia di bagni, punti di informazione, ospedali da campo.
E il tutto con un’organizzazione perfetta, con gli eserciti di 5 Stati Indiani, decine di migliaia di bagni, punti di informazione, ospedali da campo.
E soprattutto c’era silenzio, un caos ordinato e un religioso rispetto per chiunque.
Arriviamo dai nostri ospiti.
Ho conosciuto subito il Maestro, un vecchio con occhi buoni e capelli grigi lunghi e stoppacciosi. L’accoglienza è stata bellissima e calorosa.
Quella, adesso era casa nostra.
 Intorno a me, a terra, c’era un gruppetto di devoti, fumavano marijuana, alcuni erano completamente storditi, dormivano o a malapena tenevano gli occhi aperti.
Intorno a me, a terra, c’era un gruppetto di devoti, fumavano marijuana, alcuni erano completamente storditi, dormivano o a malapena tenevano gli occhi aperti.
 Erano questi i miei compagni di camera?
Erano questi i miei compagni di camera?
Ho mangiato con loro, seduta a terra e servita in piatti di metallo, rigorosamente senza posate. Il cibo, buono e speziato al punto giusto, si prendeva aiutandosi con il pane senza usare le posate. Tutto bellissimo. Ed emozionante.
Quelle gentilissime persone che mi hanno ospitata per due giorni, servita e riverita erano Naga (Nudo) Baba.
Fanno parte della “famiglia” dei Sadhu, e come dice il loro nome, usano uscire nudi e coprirsi il corpo con la sola cenere.
Si dice che, a differenza di altri gruppi Sadhu, non siano propriamente  pacifici, possano essere vendicativi ed arrivare alla mortificazione del proprio corpo e soprattutto del loro pene, desensibilizzandolo in vari modi: ho visto lucchetti, spade, e altri oggetti utilizzati per questo scopo.
pacifici, possano essere vendicativi ed arrivare alla mortificazione del proprio corpo e soprattutto del loro pene, desensibilizzandolo in vari modi: ho visto lucchetti, spade, e altri oggetti utilizzati per questo scopo.
Proprio loro, assieme alla più estrema delle sette Sadhu, gli Aghori, alle 3 di mattina hanno aperto la lunga processione fino ai gath alla confluenza dei fiumi sacri.
Erano il gruppo più atteso e scenograficamente più impressionante.
 L’esperienza più straordinaria è stata nella notte tra il 3 e il 4 febbraio.
L’esperienza più straordinaria è stata nella notte tra il 3 e il 4 febbraio.
Questa notte si è svolto il Shahi Snan, bagno rituale alla confluenza dei tre fiumi sacri, evento più importante di tutto il mese della Festa.
Un esercito di uomini nudi vestiti solo di cenere bianca e ghirlande arancioni sulla testa, con capelli lunghissimi arruffati e raccolti, o completamente rasati si preparavano fuori dalle loro tende per iniziare il cammino più importante, seguiti da migliaia di seguaci e qualche curioso.
Una scena che difficilmente si dimentica.

 Ho camminato per tre km circondata da tutto il genere umano.
Ho camminato per tre km circondata da tutto il genere umano.
 Tutta l’area, illuminata a giorno, aveva un’atmosfera surreale.
Tutta l’area, illuminata a giorno, aveva un’atmosfera surreale.
Sfilavano i carri degli asceti, sventolavano le bandiere arancioni, i manifesti giganti con le fotografie dei maestri venivano portati dai fedeli, e poi, c’era chi suonava i tamburi, e chi semplicemente camminava, andava avanti quasi per inerzia fino alla meta tanto desiderata.
Tutto intorno gente… gente… e ancora gente… e le tende dove dormivano, file infinite di bagni allestiti per l’occasione, militari a piedi e a cavallo che si occupavano di mantenere la sicurezza e l’ordine, e che severissimi allontanavano i non autorizzati, senza occuparsi troppo se sotto gli zoccoli dei cavalli finiva qualche essere umano.
Anime erranti mi circondavano da ogni lato con sguardi neri e profondi, avvolti da vesti povere ma pulite, e con la testa spesso coperta da cappelli di lana per affrontare la lunga e fredda notte.
Ognuno viveva quel momento da solo, in un intimo e religioso silenzio.

 L’arrivo ai fiumi è stato memorabile.
L’arrivo ai fiumi è stato memorabile.
 Questo era per i fedeli il momento più importante: il momento del bagno sacro, aspettato probabilmente una vita intera e che per sempre rimarrà nei lori cuori e nelle loro anime.
Questo era per i fedeli il momento più importante: il momento del bagno sacro, aspettato probabilmente una vita intera e che per sempre rimarrà nei lori cuori e nelle loro anime.
La notte era fredda e ancora fonda. L’illuminazione era perfetta.
Per terra erano accatastati migliaia di abiti e scarpe.
Corpi per lo più magrissimi, prevalentemente con barbe bianche e lunghe, e donne seminude, procedevano verso l’attesa purificazione immergendosi nell’acqua freddissima del Gange o dello Yamuna che proprio qui si incontrano.
Qualcuno cercava di arrivare ad immergersi nell’acqua insieme ai  propri maestri, il che rendeva quel momento ancora più sacro e ricco di significato.
propri maestri, il che rendeva quel momento ancora più sacro e ricco di significato.
Lo spazio in cui si svolgevano le abluzioni era piuttosto piccolo e delimitato da galleggianti, ed i responsabili della sicurezza sui loro gommoni lavoravano per garantire a tutti di poter vivere al meglio le loro abluzioni.
Qui le correnti sono infatti molto forti e i rischi di incidente, considerando anche la forte densità di persone, sarebbero potuti essere molto alti, ma tutto si è svolto per fortuna senza alcun problema e nel migliore dei modi.
 L’esperienza al Kumbh si conclude così, un misto di emozioni fortissime si alternano nella mia testa pensando che nonostante questo strano mondo possa sembrare a noi occidentali così diverso, lontano ed incomprensibile, la grande umanità, simpatia ed ospitalità della gente mi ha fatto sentire in una grande
L’esperienza al Kumbh si conclude così, un misto di emozioni fortissime si alternano nella mia testa pensando che nonostante questo strano mondo possa sembrare a noi occidentali così diverso, lontano ed incomprensibile, la grande umanità, simpatia ed ospitalità della gente mi ha fatto sentire in una grande
famiglia e sempre più curiosa di continuare a conoscere, ed immergermi in nuove culture che altro non possono fare che arricchirmi e rendermi migliore.


Per un Viaggiatore di solito non conta tanto la meta, quanto la “strada” fatta per arrivarci. La Giordania è diversa: per alcuni versi tutto il Paese è una destinazione straordinaria, ma è anche un “percorso” da fare lentamente alla scoperta di un Popolo che si sta aprendo alla modernità occidentale mantenendo ancora intatte le sue tradizioni religiose e culturali.
Abbiamo parlato di strade e non c’è modo migliore di viaggiare in Giordania che evitare la comoda e moderna autostrada che passa in pianura e percorrere l’antica Strada dei Re che è una ampia strada panoramica di montagna che si inerpica tra Paesini anonimi e proprio per questo pieni di fascino.
Questa antica dorsale di comunicazione risale ad oltre 5000 anni fa, poi nota anche come Via Traiana, e si estende per circa 460 chilometri da dalla Capitale Amman, le rovine archeologiche della antica Jerash di epoca romana, passando per Dana, Petra il deserto del Wadi Rum fino ad Aqaba sul Mar Rosso.
Il percorso è mozzafiato: si estende tra gole brulle, aspre, desertiche con curve a tornanti, e ovviamente, visto che in epoca remota era l’unica via di collegamento per uomini e merci con il mare, lungo di essa sono nati, e tutt’oggi si incontrano, i Patrimoni dell’UNESCO di Petra e Jerash che da soli valgono il viaggio.

Se deciderete di muovervi gustandovi la Strada dei Re (e ve lo suggerisco), tenete presente una velocità media di circa 70-80 km/h e non abbiate fretta: il tempo dilatato giocherà a favore di tante soste da fare nel bel mezzo del nulla per godere al massimo i suoi panorami. E’ questo il percorso migliore da seguire perchè tocca tutte le principali destinazioni di interesse turistico che vedremo in queste pagine.
Molto più di una semplice striscia di asfalto, più di una tratta storica: la Strada dei Re è parte integrante del viaggio stesso, è una meta imperdibile almeno quanto lo sono le località che unisce tra loro. Armatevi di fotocamera e di tanta curiosità: il vostro viaggio è già iniziato.
Ora che abbiamo capito che il modo migliore per spostarsi in Giordania è seguire la Strada dei Re, vediamo quali sono i siti imperdibili che rendono questo Paese straordinario e scopriamo cosa c’è da sapere per muoversi in sicurezza.
Tanto per cominciare, sappiate che in Giordania ci si può spostare in tutta tranquillità anche con un’auto a noleggio che potrete guidare voi stessi per muovervi in totale libertà. Suggerisco però di avere sempre un navigatore GPS perchè, specie in zone poco turistiche, potreste trovare che i cartelli indicatori non sono scritti bilingue ma solo in arabo! Il Vostro Google Maps potrebbe essere una buona idea gratuita purchè vi scarichiate le mappe off line in modo da potervi connettere senza utilizzare la rete dati locale che in roaming è costosissima. Se seguirete il percorso che vi suggerisco di fare verso sud lungo la Strada dei Re, per il ritorno potreste tornare verso Amman costeggiano la sponda giordana del Mar Morto oppure arrivare fino ad Aqaba dove prendere un volo di rientro verso l’Italia.
La Giordania è una monarchia islamica: il re è molto benvoluto dal Popolo e gli aspetti religiosi, pur essendo molto radicati nella mentalità della gente, non arrivano mai ad eccessi di intolleranza o di ostilità nei confronti degli Ospiti stranieri, nè ci sono per i Cittadini obblighi o sanzioni per chi non crede nell’Islam. La religione insomma è molto sentita ma non obbligatoria: ci sono molti laici sia tra gli uomini che tra le donne.
La situazione sociale e politica è molto stabile: la Giordania da molti anni è in pace con tutti i Paesi confinanti nonostante si trovi in un’area molto calda a livello di tensioni internazionali. Di norma quindi, i turisti sono ben accetti da tutta la Popolazione e il benvenuto è sincero, non si è mai assediati da insistenti venditori di strada. Un saluto e un sorriso saranno sempre la chiave migliore per aprire qualsiasi rapporto con la popolazione.
L’antica Gerasa, oggi il suo nome in arabo è diventato Jerash, è una antica città Romana ancora perfettamente conservata, patrimonio dell’UNESCO. Si trova a meno di un’ora di auto dal centro di Amman ed è un sito archeologico mozzafiato nel quale è un piacere perdersi tra i resti di una città romana con cardo e decumani ancora perfettamente conservata.
Jerash vi darà il benvenuto con l’Arco di Adriano che si trova all’ingresso della città e da cui parte la Strada dei Re. Subito dopo l’arco troverete l’Ippodromo: un autentico tuffo nel passato, qui sono ancora visibili le tribune e tutto il percorso che veniva fatto dalle bighe, in questo luogo vi sembrerà ancora di ascoltare le urla della folla che incita gli atleti in competizione.
Camminando lungo le strade, ancora tutte lastricate, si arriva al Foro con il suo colonnato ovale che è rimasto intatto, sepolto per secoli e ora riemerso in tutto il suo splendore grazie al lavoro degli archeologi. Potreste rimanere per ore a camminare qui e pian piano spostarvi verso il Teatro e l’Odeon che ancora fanno mostra di sè con gradinate in marmi pregiati e ancora funzionanti con intense stagioni di spettacoli.

Riservate una visita di almeno 3-4 ore a questo luogo incantato, avventuratevi tra le sue strade lastricate di pietre bianche e rimanete in silenzio ad ascoltare il frinire assordante delle cicale e dei grilli in estate…
Uscite da Jerash e iniziate a percorrere la Strada dei Re verso sud: tra un tornante e l’altro, salendo e scendendo le numerose montagne che troverete lungo il percorso, arriverete a Petra, la vera meta del nostro viaggio in Giordania.
Fate in modo di visitare prima la Piccola Petra, poco distante dal sito maggiore e arrivateci preferibilmente un’ora prima del tramonto quando la luce dorata del sole crea lunghe ombre nel canyon e illumina perfettamente le rovine di pietra calcarea. Ricordate di visitare prima la Piccola Petra che vi permetterà di entrare in un crescendo emozionale per poi vedere Petra.
La visita di Petra richiede dalle 4 alle 15 ore di tempo a seconda di quanto vorrete approfondire la vostra conoscenza, vedrete che, comunque scegliate di farla in base alle vostre condizioni di salute e alle vostre aspettative, quel tempo vi passerà in fretta.

Per i più arditi suggerisco di mettersi in fila ai cancelli già all’alba, ed entrare alle prime luci del sole (quando l’aria è ancora fresca ed è meno trafficato da turisti di ogni parte del mondo).
Il sito di Petra è una lunga strada di circa 6 chilometri affiancata su entrambi i lati dai resti della vecchia città che si estende dall’ingresso fino al Monastero passando per il Tesoro, le Tombe dei Re, il Teatro e il Colonnato. Potrete vederne una parte o farla tutta, ricordatevi solo che la strada che farete all’andata dovrete rifarla uguale anche al ritorno: dosatevi le energie. C’è la possibilità di fare alcuni tratti su piccoli calessini trainati a cavallo oppure a dorso di asino o dromedario. Per chi vuole arrivare fino al Monastero (ultima parte visitabile) il modo migliore è armarsi di pazienza e affrontare gli 800 gradini da fare a piedi in circa un’oretta di cammino.
Se vi è piaciuta Jerash, una visita approfondita a Petra cambierà per sempre la vostra vita: un vero salto nel tempo che vi riporterà in una full immersion all’epoca dei Nabatei nel VI secolo AC quando la città, nascosta tra le montagne e nel suo Siq scavato dall’acqua nella roccia, prosperava nei commerci tra oriente e occidente.
Impossibile rimanere impassibili al fascino storico di Petra: i suoi monumenti sono ancora intatti e brillano da secoli sotto i tagli di luce che il sole disegna insinuandosi tra le rocce policrome di pietra arenaria.

Il modo migliore di terminare la giornata a Petra (ecco perchè la vostra visita potrebbe durare fino a 15 ore) è assistere allo spettacolo di Petra by Night: 3 notti ogni settimana il Siq e il Tesoro vengono illuminati dalla meravigliosa luce incantata di migliaia di candele che rischiarano la notte e vestono il sito di un’atmosfera surreale che non dimenticherete facilmente.
Al mattino successivo, dopo Petra, riprendete di nuovo la Strada dei Re e puntate ancora verso sud: in un paio di ore arriverete nel deserto del Wadi Rum. Qui è facile trovare posto per dormire nei tanti campi tendati di lusso che sono nascosti tra le rocce proprio per essere meno visibili e lasciare intatta la bellezza dell’ambiente circostante.
Il Wadi Rum è un deserto relativamente piccolo (circa 70 km di diametro) rispetto ad altri deserti del mondo, ma molto selvaggio e con scorci paesaggistici indimenticabili.

Qui, una volta arrivati in auto (o in bus) non potrete procedere con i vostri mezzi tra le dune, ma vi occorre un fuoristrada con un autista che vi porti in giro in sicurezza senza perdervi e senza insabbiarvi con un mezzo non idoneo che potrebbe rivelarsi pericoloso. Il giro che in genere fanno fare ai turisti dura un paio di ore al tramonto, ma il mio suggerimento è quello di arrivare entro le 11 del mattino e fare un tour di almeno 6 ore per vedere il deserto, fermarvi a pranzare tra i resti della casa di Lawrence d’Arabia o all’ombra di un Djebel o sotto la Roccia del Fungo.
Con un pò di fortuna potrete anche incontrare una carovana di dromedari che camminano nel deserto portando approvvigionamenti ai campi tendati.
La notte stellata concluderà il ricordo di uno dei viaggi più belli che potrete fare a sole 3 ore e mezza di volo da Roma.

| Se vi state chiedendo come sarà il cibo in Giordania ve lo dico io: si tratta di una cucina tipicamente mediterranea perchè gli ingredienti usati sono fondamentalmente gli stessi che utilizziamo noi dal pomodoro all’olio di oliva, dai legumi alle melanzane.
Il pane arabo è buonissimo, lo potrete mangiare caldo appena sfornato in strada e preparato come le nostre piadine ma immaginatele cotte a legna e molto più lievitato… Tra le cose tipiche da mangiare ci sono l’Hummus (una sorta di crema a base di farina di ceci) e il Mutabbal (anche questa una sorta di crema a base di melanzane al forno con aglio) e i mitici Falafel (polpettine a base di farina di ceci leggermente speziate e fritte), ovviamente non mancano le carni di agnello e pollo cucinate al tegame o alla brace in forma di spiedini che qui chiamano Koftah o Kebab.  Sempre presente anche il riso (chiamato Maqluba quando servito con la carne di pollo) e tantissimi dolci a base di miele come la Baklava (pasta fillo, miele, pistacchi) e il Knafeh a base di formaggio fuso su una base di sfoglia da mangiare caldo con un filo di miele il cui sapore ricorda le nostre Seadas sarde. Anche se siete dei patiti dello Street Food, potete stare tranquilli che le condizioni igieniche in Giordania hanno quasi sempre gli standard europei con cibo sempre freschissimo e buone condizioni di conservazione. |
Questo Articolo è stato pubblicato sulla Rivista Acqua & Sapone a luglio 2017, sfoglialo sul sito: https://www.ioacquaesapone.it/leggi/?n=asgiugno2020#117


Se pensi al Natale come Babbo Natale che arriva sulla slitta il 25 dicembre e porta regali ai bambini, leggi questo articolo: ti porterò in un posto in cui tutto questo non è vero. Ad esempio, nel nord dell’Etiopia, a Lalibela, è tutto diverso, anche la data di Natale che viene celebrato il 7 gennaio!

Lalibela è un posto magico, denso di spiritualità, uno di quei posti in cui sentirai esplodere dentro di te il mal d’Africa. Lalibela è la classica cittadina tranquilla africana: poche case in muratura, qualche albergo e tante capanne, sono i tipici tukul con il tetto in paglia a punta. Lalibela però è un Patrimonio dell’UNESCO perchè qui c’è qualcosa che non esiste in nessun altro posto al mondo: le chiese rupestri ipogee monolitiche. Detto in altri termini queste chiese sono state letteralmente scavate svuotando la montagna e ricavando la chiesa da un unico blocco di roccia. 40 anni di lavoro fatto a mano con martelli e scalpelli.

Qui le chiese sono di rito cristiano copto, un rito completamente diverso da quello cattolico, nei costumi, nella durata, nelle modalità di celebrazione e anche nella simbologia. La festa del Natale è la più sentita, la più bella e partecipata dell’anno. Circa 20.000 fedeli arrivano qui per celebrare la nascita di Gesù con una messa che dura 12 ore: dalle 9 di sera fino alle 9 del mattino successivo, il tutto accompagnato da circa 300 sacerdoti che indossano paramenti dai colori sgargianti e da tutti i fedeli che vestono il tipico caftano bianco. L’atmosfera che si respira qui è meravigliosa, che si sia credenti o no è impossibile rimanere impassibili davanti a tutto questo. La simbologia è talmente chiara da sembrare artefatta: sembra che ci sia dietro il lavoro di un abile regista, mentre invece tutto è dettato dalla tradizione più antica e incontaminata. Quando andai io, tra la gente c’era persino il Presidente dell’Etiopia con la sua scorta! Le misure di sicurezza erano fittissime! ;:)

La notte simboleggia la tenebra e il peccato: il rito non a caso viene celebrato con il buio. La suggestione del momento è enfatizzata dalla presenza di centinaia di candele con le quali i fedeli rischiarano di tanto in tanto la lettura dei testi sacri che portano con se per seguire le letture durante la lunga veglia. E’ incredibile osservare le espressioni e il coinvolgimento emotivo di queste persone rapite dalla preghiera. Ma la notte è fatta anche per riposare e qui nella grande chiesa di Santa Maria (dedicata alla Madonna) si dorme regolarmente durante la lunga veglia notturna del Natale! Quello che da noi in Italia sarebbe impensabile, irriverente, inaccettabile come il dormire in chiesa durante un rito sacro, in Etiopia invece viene accettato senza difficoltà: la notte è fatta per dormire, chi vuole prega, gli altri dormono!
I sacerdoti sono centinaia, restano svegli tutta la notte a celebrare il lungo rito. Molti di loro sono sposati e hanno figli, il celibato non è a loro richiesto. Quasi ogni parte del rito viene cantata e danzata per rendere la partecipazione più corale e intensa. Le letture e le omelie sono ridotte al minimo. Il ritmo lento viene scandito dal Sistro: uno strumento il cui suono assomiglia a quello di un cembalo, costruito con una impugnatura con dei piattelli che vengono suonati alzando o abbassando il braccio in un gesto rituale che simboleggia la morte (braccio abbassato) e la resurrezione di Gesù (braccio alzato). Durante ogni canto, durante tutta la notte, viene ricordato tutto questo.

E poi c’è la gente che vive in massa tutto questo. A parte chi dorme e chi legge nella chiesa, c’è poi chi rimane all’esterno e partecipa al rito guardandolo sui maxischermi che vengono allestiti per l’occasione perchè all’interno non c’è spazio per tutti. Fuori dalla chiesa, davanti ai monitor si crea un vero e proprio accampamento con tende improvvisate e tavolate di intere famiglie che ricoprono la montagna con le loro vesti bianche che si vedono bene nella notte.
Tra la gente e i sacerdoti c’è la presenza fondamentale di certi mediatori che scendono tra la gente portando a loro i simboli cerimoniali come la croce e un cuscino che viene baciato a turno dai fedeli. Questi mediatori sono quelli che vendono le candele con le quali partecipare alla messa. I loro abiti sono preziosi, dorati, coloratissimi e portano sempre un ombrello damascato coordinato con l’abbigliamento. A ben guardare i loro movimenti, nonostante l’apparenza solenne, appaiono però come abili commercianti che si aggirano durante la lunga messa tra la gente per vendere ancora candele a chi ne fosse rimasto sprovvisto.

Il Natale copto è il 7 gennaio, con la grande veglia che inizia il 6 sera, in corrispondenza con la nostra Epifania. Il giorno della Vigilia passa tra i pellegrinaggi che vengono fatti dai fedeli nelle chiese: si va in visita alle icone dei santi e ci si mette in fila per una veloce benedizione, si bacia la croce copta in legno o in argento e con questa si viene benedetti dal sacerdote. Migliaia di persone arrivano 1-2 giorni prima del Natale proprio per avere il tempo di fare i pellegrinaggi in tutte le chiese e in particolare in quella di San Giorgio, la più grande e bella: famiglie intere o comunità locali si spostano in gruppo arrampicandosi sui pericolosi muretti alti 10 metri senza protezioni, camminando negli stretti cunicoli in discesa scavati per accedere alle chiese. E per tutto il giorno si mangia in strada dove ci sono ristorantini ambulanti e migliaia di fedeli già vestiti a festa.

Alle 21 del 6 gennaio inizia la lunga messa: 12 ore per sentirsi vicini a dio. Durante la prima parte ci sono canti e danze, quando la notte diventa profonda, il ritmo rallenta e la gente si addormenta a terra. Quello è il momento preferito da noi fotografi perchè possiamo muoverci facilmente per fare le nostre foto e camminare infilando i piedi nei pochissimi spazi liberi tra la gente che dorme, anche se ogni tanto può capitare di pestare una mano o un piede nascosti nel buio… La cosa più bella da fotografare sono i contrasti tra le luci delle candele e le ombre, tra il bianco delle vesti e il nero della pelle della gente, tra i colori dei vestiti e il nero della notte.
La lunga veglia prosegue abbastanza uguale a se stessa fino al momento in cui improvvisamente il rito cambia e il buio lascia lo spazio al rito della luce che simboleggia la nuova nascita e l’arrivo del Natale. La chiesa che era caduta nel torpore generale si sveglia improvvisamente tra le urla generali delle folla impazzita: la nascita di Gesù viene celebrata in quel momento con una gioia incontenibile e urla liberatorie. In pochi istanti tutti i fedeli tirano fuori le candele che avevano conservato e le accendono l’una con l’altra in un gesto di condivisione reciproca durante il quale la luce aumenta velocemente in proporzione. Il momento è emozionante: le urla festose, la luce che aumenta, la chiesa che fino a quel momento era stesa a terra a dormire si rialza in piedi e ricomincia a partecipare al rito. Poco dopo la preghiera è fortissima, le urla caotiche vengono riordinate di nuovo dalla coralità della preghiera e, girandosi intorno, tutto ciò che era buio ora è illuminato dalla luce di migliaia di candele accese, tutto ciò che era libero ora diventa ordinato e corale.

La gente ora è tutta in piedi e rivolta verso l’altare con le candele in mano intenta a pregare, questo momento dura un’oretta di preghiera, poi di nuovo un crescendo di emozioni avvolge i presenti: di nuovo le urla della folla impazzita: alzando lo sguardo verso i bordi laterali si scorgono i sacerdoti che sono saliti sul bordo dello strapiombo intorno alla chiesa e dall’alto cingono con la loro presenza tutta la chiesa e i fedeli in un abbraccio simbolico, hanno cambiato le loro vesti, tolto i colori e sono tornati a vestire anche loro di bianco con solo una fascia colorata. Applausi, lacrime e sorrisi: si alzano verso di loro migliaia di telefoni cellulari che fotografano la lunghissima fila di Celebranti, tutti hanno tra loro un parente o un amico che dall’alto li sta benedicendo e li ricambiano con una foto ricordo. Anche i sacerdoti, nonostante la sacralità del momento e del loro ruolo, scattano di tanto in tanto qualche foto con il cellulare alla folla sotto di loro alternano questo gesto pagano alla sacralità del suonare il sistro che da ore segna il tempo della cerimonia. La simbologia anche qui è fortissima: dopo la tenebra del peccato arriva la luce e quindi la salvezza.

La magia della luce continua perchè adesso il cielo inizia a tingersi di rosa: è l’alba di Natale! La messa vera e propria ha inizio alle 6 del mattino, e finirà alle 9 dopo tre ore di canti e danze accompagnati ora dal ritmo dei tamburi che sovrasta e sostituisce il suono melodioso e malinconico del sistro. E qui l’anima africana degli etiopi fatta di ritmo e danze prende il sopravvento sul rito lento e profondo che si è vissuto per tutta la notte… L’allegria generale da il benvenuto alla festa, segna la fine dell’attesa per la nascita di Gesù nel giorno di Natale.

Qui siamo lontani anni luce dall’icona tipica di Babbo Natale, siamo lontani dai panettoni e dalla neve. Benvenuti in Africa.
| La chiesa cristiana copta celebra il rito del Natale con un calendario diverso rispetto al nostro, spostato di 13 giorni in avanti. La festa del Natale è quindi il 7 gennaio con la vigilia il 6, ossia il giorno della nostra Epifania. Quindi, la loro Epifania è il 20 gennaio. |

C’è una Cuba che tutti conoscono, è la Cuba della Salsa e di tutti i balli caraibici che la fanno amare da milioni di persone in tutto il mondo, ma non è questa la vera Alma de Cuba. C’è la Cuba legata ai grandi Rum pregiatissimi che sono apprezzati dagli estimatori di 5 Continenti. C’è la Cuba famosa per Che Guevara e Fidel Castro e la loro Rivoluzione. Ma non è di tutto questo che oggi voglio parlarvi, questo già lo sapete.
A me interessa il popolo, quello che fa e che sente la gente vera quando è lontana dai riflettori mediatici. Voglio parlarvi del motore sociale dell’Isola Grande, di coloro che con la loro opera quotidiana rendono questo posto una meta imperdibile per noi Viaggiatori e Fotografi.

Oggi voglio raccontarvi di quel popolo silenzioso e cordiale che vive tutto questo in prima persona in un luogo del mondo che sta crescendo troppo in fretta suo malgrado e senza accorgersene. Oggi vi parlo di come si arriva a quelle eccellenze e di come sta la gente vera, quelli che dopo 60 anni di Fidel Castro ancora lo amano anche dopo la sua morte.
Voglio farvi capire cosa c’è di bello nell’anima della gente di Cuba. Voglio uscire dai luoghi comuni che tutti conoscono, e farvi apprezzare una realtà complessa che ho toccato con mano.

In molti Paesi del mondo per trovare la gente più vera e autentica, occorre allontanarsi dalle grandi città, andare nelle campagne dove si vive ancora come una volta tra antiche tradizioni e uno stile di vita semplice. Bisogna vivere per qualche giorno in un luogo lontano per ritrovare tutt’oggi quello che era il vissuto quotidiano dell’Italia del Dopoguerra. Cuba non fa eccezione: la campagna è il vero senso di questo viaggio.
Ahimè, molto spesso, dobbiamo riconoscere che ci farebbe molto comodo poter lasciare intere nazioni nel loro degrado fascinoso e autentico, lasciarle nella loro arretratezza rispetto ai nostri standard. Molto spesso pensiamo che stiano meglio loro senza nulla rispetto a noi che abbiamo tutto.
La questione è un pò più complicata e ve la racconto dalla viva voce dei cubani che me la hanno raccontata durante i miei due viaggi ad un anno di distanza nella loro terra. A Cuba un benestante guadagna 100 Euro al mese, ma molti fanno 2-3 lavori, hanno più stipendi, ma riescono a recuperare pochi altri soldi, in genere ci sono famiglie intere che non arrivano a 150 Euro al mese pur con tutti gli extra.

I Cubani sono gente di cuore, gente che vive di passioni, fondamentalmente onesta e apparentemente felice nel loro piccolo mondo. Apparentemente perchè in pochissimo tempo le cose stanno cambiando velocemente, la gente inizia a sapere cosa c’è oltre il mare che circonda quell’angolo di paradiso e il turismo inizia a diventare di massa. Viene spontaneo quindi per loro, e giustamente, guardarsi intorno e fare le dovute differenze tra chi vive lì e chi ci va per turismo.

In città da un anno all’altro sono successe tantissime cose. Troppe…
La prima volta che sono andato era appena finito l’embargo e sembrava di vivere nella nostra Italia del Boom economico avendo loro la stessa tecnologia che avevamo noi negli anni ‘60. Tante televisioni, radio qualcuna, nessuna lavatrice, e le mitiche cadillac degli anni ‘50 ancora perfettamente funzionanti.

Ma la prima rete WIFI pubblica (nelle case ancora non esiste) è arrivata a giugno 2015 e ancora oggi ci si può connettere solo in alcune piazze di alcune città, da quel giorno, nel giro di 15 mesi sono avvenuti dei cambiamenti storici che hanno modificato per sempre la vita dei cubani.
Innanzitutto la visita di Obama, il primo Presidente Americano che sia venuto in visita ufficiale, poi subito dopo questo ha portato l’arrivo della prima nave da crociera, la prima di una lunga serie che scaricano 4-5000 passeggeri al giorno in una città che fino ad un anno prima vedeva le stesse persone in un mese.
E’ arrivato poi il concerto dei Rolling Stones che ha portato… “musica nuova” qualcosa di molto diverso dalle sonorità a cui erano abituati i locali. E infine la morte di Fidel Castro che ha causato la fine di un’ epoca.
I Cubani non sanno più dove stare, sono cambiate troppe cose in due anni, troppo rapidamente. Hanno iniziato a conoscere il lato consumistico del turismo, hanno visto arrivare soldi e sbarcare turisti e hanno visto il guadagno facile. Ma tutto questo senza avere una struttura mentale imprenditoriale, senza conoscere cosa sia il concetto di Qualità, di Servizio, di professionalità.
Sono ancora mentalmente molto legati allo stile di vita assistenzialista che avevano sotto Castro. L’Havana è una città troppo piccola per sostenere ondate così grosse di turisti e non è pronta ad accoglierli. Le campagne vivono i cambiamenti in modo più lento, ma anche lì si stanno iniziando a guardare intorno a capire che ancora molte cose gli mancano.

Gli errori più grandi che noi occidentali possiamo fare in questi casi sono due ed opposti tra loro. Il primo è il pretendere che i popoli si adeguino a noi in tempi troppo rapidi. Il secondo errore è quello di pretendere che rimangano in una loro affascinante quanto decadente arretratezza per preservarne la naturalità e la spontaneità.
La verità, invece, è che da queste parti in campagna si vive ancora bene. Questo accade non solo perchè i ritmi sono più lenti e adeguati all’indole del popolo cubano, ma perchè questi ritmi sono quelli più naturali per la nostra natura umana. Ogni momento è legato al ciclo lento delle stagioni che segnano il tempo del lavoro nei campi. La gente vive ancora lontana dal turismo. Ci si reca al lavoro su un carretto trainato da un cavallo oppure prendendo un autobus che passa senza orario.
Ecco… il fascino più vero e autentico dei cubani è proprio la loro lentezza, il non avere stress, avere ambizioni si ma con poca competitività. E tutto questo lo potrete apprezzare nelle campagne,
A Cuba i pochissimi che hanno una delle vecchie auto se la tengono gelosamente e in perfetto stato: sanno che ha un valore enorme come taxi, come mezzo da dare a noleggio con conducente.
Ma la vita nella campagna cubana riserva molte soddisfazioni a chi sia così curioso da volerne scoprire la luce calda del mattino quando il sole sorge nella rugiada e le ombre si stagliano in controluce sul cielo, qui è facile vedere i carretti che si dirigono nei campi trainati da un asino o un cavallo, vedere i ragazzi che vanno a scuola a piedi con le loro divise perfettamente pulite e con i colori diversi a seconda del grado di scuola che si frequenta: elementari, medie o superiori.

Qui la sera troverai la vita della gente che scende in strada a chiacchierare, a fare una passeggiata tra fidanzati o un giro in bici con gli amici. Strano… La musica non è diffusa ovunque come crediamo! A Cuba, nei posti che ho frequentato io non c’è musica come ce la aspetteremmo. Persino quando ho trovato la musica non era mai la salsa cubana che noi conosciamo dall’Italia.
In campagna la gente suona, ma non i ritmi caraibici ballabili, si sente invece più musica melodica e il repertorio classico alla Buena Vista Social Club…

L’altra cosa che può sconvolgerci è che a Cuba le case sono aperte, piano terra con la porta aperta e chiunque potenzialmente può entrare, affacciarsi a guardare dentro casa o a fare una foto. La gente qui si fida. Anzi, sono loro a dirti di entrare. Fidel Castro è dovunque, sui muri, nei portaritratti, sui manifesti…
Che Guevara è un’icona grafica, ha quasi del tutto perso le sue sembianze fotografiche per essere un tratto disegnato in bianco e nero, lo vedi sventolare sulle bandiere, stampato sulle magliette, esposto in case e uffici, la gente gli è grata e devota come se fosse un santo.
E a proposito di santi, in tutta l’isola si trovano luoghi e riti di Santeria, una religione che trae origini in quella cattolica ma sfocia tra lo sciamanesimo e l’animismo, vi si trovano adorazioni di alberi rituali e sacrifici animali, una cosa gioiosa ma spesso cruda e dura come la vita.
Qui non sarà raro vedere rituali che vengono celebrati al ritmo incessante delle percussioni con persone che entrano in trance, si portano offerte ai fantocci e cibi per le comunità o per i poveri.

In campagna ho trovato il meglio della gente di Cuba, in località piccole come a Vignales, a Pinar del Rio, nella Valle del los Ingenios…. Sono posti relativamente lontani dal turismo di massa, lì dove ancora si riesce a vivere in modo tradizionale, dove un contadino può coltivare il tabacco da vendere alle grandi manifatture governative, ma può anche tenerne una parte per se e farsi un “Puro” rollandoselo sul tavolo o direttamente sui pantaloni e poi incollandone le foglie esterne con il miele per dargli anche un sapore leggermente più dolce.
Beh… di certo non sarà nè perfetto di forma, nè bellissimo a guardarsi, però quel sigaro sarà solo suo, la miscela di foglie necessaria per comporlo sarà un mix unico e irripetibile, fatto in casa. E qualche Puro può anche venderlo in privato, favorendo così una microeconomia con la quale potrà finanziarci qualche spesa extra per casa.

Ho incontrato per puro caso uno di questi contadini in giro tra le campagne, non avevo una guida, nè un interprete, non parlo spagnolo e lui non parlava inglese, per cui ci intendiamo parlando ciascuno la propria lingua madre, convinti che le persone di buon senso se vogliono comunicare possono riuscirci anche solo a gesti. E così andò: ci capimmo al volo…
Poco dopo i normali convenevoli che si scambiano tra i viandanti, gli ho chiesto se conoscesse qualcuno ove potessi andare a vedere come viene fatta la lavorazione del tabacco. Ero infatti molto interessato a fotografare le varie fasi. Senza esitare mi invitò a casa sua per spiegarmi come viene fatta la coltivazione del tabacco, e naturalmente mi ha aperto tutte le porte senza alcun problema, la gente è sempre cordiale e disponibile da queste parti.
Al mio arrivo tutta la famiglia, compreso il nonno ultraottantenne, stava lavorando per trapiantare le giovani piantine nel campo in cui cresceranno e daranno i loro frutti. L’operazione di piantumazione, sarebbe banale nella sua semplicità, ma risulta essere una vera scoperta per un ingenuo “animale da appartamento” come me.
Qui tutto viene fatto a mano, non c’è fretta di automatizzare tutto, la lavorazione del tabacco da quando viene seminato a quando diventa sigaro dura un anno intero. Mi intrattengo a fotografare le mani degli operai che conficcano le loro dita tozze e forti nel terreno per dare dimora alle giovani piantine.

Ormai dopo mezz’ora di foto nei campi siamo diventati amici con il mio simpatico agricoltore: la fotografia aiuta moltissimo a ridurre le distanze tra le persone, che trovano in essa una loro dimensione di protagonismo. Quasi sempre la gente è portata a rapporti interpersonali informali ed è sempre molto cordiale e quindi quello è il momento giusto per chiedergli di entrare nella sua “Casa del Tabacco”.
Questa è una struttura a metà tra un essiccatoio e un magazzino: è un grande capanno di paglia stesa su un telaio di legno. Al suo interno si crea il giusto microclima per temperatura e umidità necessario alle foglie per essiccarsi in modo semplice e naturale, senza alcun agente esterno che ne velocizzi o rallenti il processo.
La natura segna il tempo di ogni cosa. Un posto del genere è un pò intimo, come una vera casa, ecco perchè ho aspettato a chiederlo, il motivo è che come in una casa, anche qui vengono custoditi i beni più preziosi della famiglia: l’intero raccolto del tabacco che darà lavoro e guadagno a tutti per un intero anno fino al raccolto successivo. Entrando nella casa si vede la quantità di prodotto che poi andrà allo stato, si dimostra così al visitatore la propria capacità di reddito. Infatti il 90% del prodotto andrà allo Stato e solo il 10% trattenuto dalla famiglia per uso personale.

Qui all’interno del capanno, le foglie sono perfettamente sistemate una per una, con la giusta quantità di aria che le avvolge, tutte infilate con il gambo all’insù. Rimarranno qui fino a quando verranno imballate in grossi pacchi e vendute alle manifatture statali. Non si sente ancora il tipico odore del tabacco qui, piuttosto qualcosa che ricorda il bosco in autunno, gli odori tipici del prodotto secco arriveranno poi con la lavorazione e la miscela.
La mia visita si conclude con il rituale quasi sacro della produzione del sigaro. Il Puro, quello lavorato alla buona e fatto sul momento ad uso e consumo di chi lo produce per fumarselo. Il Puro viene prodotto con lo stesso sistema dei sigari industriali, solo che viene fatto con molta meno cura, non viene pressato al torchio, la sua forma e dimensioni non sono perfette ma questo non è un problema per loro: il sapore e la qualità non cambiano.
Tutti i sigari, e quindi anche i Puri sono fatti con i diversi tipi di foglie della pianta che danno la giusta miscela e sapore. Le foglie esterne sono diverse da quelle che si trovano all’interno. Mi piace guardare, osservare e fotografare ogni sapiente gesto di quelle mani abili nel fare movimenti studiati, accurati, frutto di anni di esperienza…
Mi affascina vedere le mani che lavorano e questa cerimonia pagana che si celebra sotto la tettoia della veranda di casa circondati da cani, gatti e una scrofa che allatta…

questo articolo è apparso sulla Rivista Acqua & Sapone nel numero di novembre 2017.

“La parte più a nord dell’America del sud” questo è il singolare primato che può vantare la penisola della Guajira, una terra praticamente sconosciuta al turismo di massa che è stata meta di una delle mie originali scorribande in giro per il mondo.
 Riconosco che non ne avevo mai sentito parlare, me la nominò il mio amico Dario, un Colombiano che mi raccontava di questo promontorio desertico che si protende verso i Caraibi suddiviso o forse sarebbe meglio dire condiviso tra Venezuela e Colombia. Le sue storie mi incuriosirono a tal punto che decisi di andare a scoprire cosa ci fosse da quelle parti.
Riconosco che non ne avevo mai sentito parlare, me la nominò il mio amico Dario, un Colombiano che mi raccontava di questo promontorio desertico che si protende verso i Caraibi suddiviso o forse sarebbe meglio dire condiviso tra Venezuela e Colombia. Le sue storie mi incuriosirono a tal punto che decisi di andare a scoprire cosa ci fosse da quelle parti.
Andammo a fine novembre, quando il clima è più mite, il caldo non è soffocante e le piogge sono virtualmente assenti. Il fattore meteo va sicuramente tenuto presente quando si va da queste parti: ci troviamo in piena fascia equatoriale, poco al di sotto del Tropico del Cancro.

Il viaggio è lungo e faticoso anche se fatto in aereo: innanzitutto ci vuole almeno uno scalo a Madrid o Lisbona, poi ci vogliono una quindicina di ore di volo dall’Italia. Il ritorno è peggio perchè di ore di volo ce ne vogliono 27 dato che la TAP fa scalo a Panama, l’aereo viene svuotato e i passeggeri imbarcati di nuovo.
Finalmente a Bogotà: 2640 metri di altezza sul livello del mare. Qui vista la posizione, fa freddo e piove, tipica giornata da fine autunno. L’aria è rarefatta vista l’altitudine, salire ulteriormente fino alla montagna del Monserrate con il suo Santuario El Senor Caido a 3150 metri di altezza. Ci arriva la funivia ma i pochi metri che ancora bisogna fare fino alla vetta metteranno alla prova quelli meno allenati a livello respiratorio.
Bogotà Ha un piccolo centro storico in stile coloniale, con casette basse coloratissime che ricordano moltissimo quelle di Trinidad nell’Isola di Cuba. Qui è bello passeggiare tra gli studenti universitari che abitano nel quartiere è lo rendono un luogo stimolante e attivo. Per il resto la città non vanta altre bellezze degne di nota, se non il Museo dell’Oro che è un’esperienza mozzafiato per la ricchezza e l’abbondanza dei reperti che risalgono all’epoca precolombiana.
Dopo la doverosa visita alla Capitale, il giorno dopo ripartiamo con un volo interno alla volta, finalmente, della Guajira. Appena scesi veniamo letteralmente proiettati in un’altra realtà, lontana anni luce dal nostro mondo e anche da quello visto il giorno prima nella grande città.
Atterriamo a Riohacha, un piccolissimo aeroporto di quelli tipici dei Paesi tropicali: le palme, un camioncino dei Vigili del Fuoco arrugginito e la scaletta per scendere direttamente sulla pista e proseguire a piedi fino all’aerostazione che è un grosso salone con porte e finestre aperte perchè non c’è aria condizionata.
Il volo viene operato da Avianca, la Compagnia di Bandiera colombiana che può vantarsi di essere la seconda compagnia aerea al mondo per data di fondazione preceduta solo dalla ben più nota KLM.

La Candelaria è uno dei quartieri più interessanti di Bogotà
Siamo nel bel mezzo della Guajira, questa doveva essere la meta finale del viaggio con la motocicletta che fecero Che Guevara con il suo amico Alberto Granado, in realtà non arrivarono a destinazione: ma la mia meta aveva affascinato anche loro.
Da queste parti ancora si può provare l’ebbrezza di sentirsi “esploratori” o “viaggiatori” se preferite. Spingersi da queste parti significa essere davvero molto curiosi di sapere “cosa c’è oltre” oltre le solite mete turistiche, dove finiscono le strade asfaltate e inizia la vera avventura. E l’avventura non tarda ad arrivare: ci aspetta Emilio, il nostro autista: un omone gigantesco, un indio portato al sorriso e alla battuta con un tono di voce assordante, parla poco lo spagnolo, più che altro conosce la sua lingua, ma con le sue 20 parole riesce a farsi capire senza problemi su molti argomenti. Saliamo sul suo bel fuoristrada 4X4 a passo lungo ed eccoci ad iniziare finalmente il clou del nostro itinerario.

Nel pomeriggio ci fermiamo in un villaggio di capanne di fango e paglia, qui è la norma, sembra di stare in Africa. Le donne sono poco abituate al turismo, ci salutano con una certa timidezza e non hanno nulla da venderci, siamo noi stessi a chiedere loro se vogliano esibirsi in canti o danze tradizionali per condividere con noi una parte della loro cultura. Ben felici della nostra richiesta, le donne convocano un anziano percussionista che con il tamburo accompagna le loro danze che ricordano i movimenti che fanno i pennuti da cortile nei loro corteggiamenti. Questo è il nostro primo incontro con i Wayuu che vedremo più avanti.

Proseguiamo fino a Cabo De La Vela un villaggio sul mare in una posizione da sogno, incredibile, con un mare verde smeraldo e le coste sferzate da un vento fresco e gagliardo. Anche qui non esiste il turismo in nessuna forma. Il lungomare è solo il “giardino sul retro” delle capanne costruite sulle dune. Nel villaggio non c’è assolutamente nulla nè da vedere, nè da fare, nè da comprare. Ma è proprio questo suo fascino selvaggio che ci piace trovare in questo piccolo avamposto nel nulla sospeso tra il mare e il deserto. Non esiste corrente elettrica, non esiste segnale telefonico per i cellulari.
C’è giusto il tempo di fare un bagno nell’Oceano al tramonto che arriva la sera: siamo in fascia equatoriale, per cui qui durante tutto l’anno il sole tramonta intorno alle 18, il che vuol dire che alle 19 abbiamo già finito di cenare e alle 21 si spegne il gruppo elettrogeno e tutto il paese resta nel buio più totale… Ne approfittiamo per fare qualche foto ad una notte stellata incredibile che non dimenticheremo facilmente.
Parlavo di avventura e il momento di andare a dormire ci riserva un’altra bella sorpresa: non ci sono le camere, non ci sono muri, nè letti! Si dorme tutti insieme sotto una tettoia di paglia ciascuno sul suo chinchorro (da queste parti le amache si chiamano così), ma ci vuole l’esperienza del nostro autista Emilio che ci spiega la tecnica per dormire su questi inconsueti giacigli: basta mettersi a 45° rispetto all’asse dell’amaca: in pratica è necessario dormire con le gambe appese all’esterno del supporto in modo da farlo rimanere un pò più aperto. Solo i più fortunati riusciranno a dormire un paio di ore a notte…

La Guajira è un vero deserto in mezzo al mare: qui ci sono altissime dune sabbiose che vanno a finire direttamente nell’oceano, ci si sposta solo in fuoristrada 4×4 perchè non ci sono strade: la velocità media che si può tenere sulle piste è di 20 chilometri all’ora, il che vuol dire che per fare uno spostamento di soli 200 km ci vogliono 10 ore di “Colombia Massage”, una giornata intera di sballottamenti tra rocce e sentieri, tra guadi e saline.
Da qui partivano i corrieri del mare, i trafficanti di cocaina del cartello di Medellin che attraversavano il Mar dei Caraibi per fare tappa a Cuba e poi portare la droga nel sud degli USA. Molte delle piste segnate da queste parti e ancora oggi percorribili, sono state tracciate dagli sgherri al soldo di Pablo Escobar e non meraviglia più di tanto il fatto che la penisola sia ufficialmente divisa tra Colombia e Venezuela, ma andando da quelle parti ci si rende conto che tali confini siano piuttosto labili e di fatti i Wayuu sono un Popolo apolide che si sposta più o meno liberamente a seconda delle necessità tra questi due Paesi.
Di fatto i confini tra i due Paesi non vengono controllati: sono pochi e segnati male, ne segue una gran tolleranza per le popolazioni locali che sono piuttosto libere di passare da una parte all’altra nell’indifferenza delle Autorità preposte ai controlli di frontiera.

Altra meta da non perdere in Guajira sono laghi e insenature di mare che ospitano migliaia di Fenicotteri rosa pronti a volare via appena l’uomo si avvicini nei paraggi. Per vedere questo spettacolo della natura suggerisco di utilizzare una piccola barca a vela con la quale avvicinarsi senza disturbare gli uccelli e di tenere anche montato il teleobiettivo stando pronti per riprenderli quando immancabilmente si alzeranno in volo: uno spettacolo meraviglioso contraddistinto dal particolare verso gracchiante dei fenicotteri impauriti!

Ma la meta più estrema del nostro giro nonchè il termine del nostro itinerario è Cabo Gallinas: la punta famosa per essere quella più a nord di tutta l’America del Sud! Qui c’è un faro per i naviganti, una meta imperdibile per soddisfare le vanità di ciascuno di noi con un classico SELFIE!
I Wayuu oltre ad essere pastori e allevatori, sono anche abilissimi nuotatori e quindi pescatori, qui a cena puoi mangiare 4 aragoste a persona spendendo solo 18-20 euro… Il nostro viaggio fuori strada continua fino alle ventosissime Dune di Taroa molto note in zona proprio per questo motivo: il vento praticamente costante tutti i giorni dell’anno, può essere a volte così forte da far cadere una persona con le sue raffiche.

La Guajira è una zona che oltre alle sue bellezze porta i segni anche dello sfruttamento del territorio: ci sono delle saline enormi come quella di Manaure: qui ci sono ettari ed ettari di terra in cui viene lasciata evaporare l’acqua del mare per ottenere cloruro di sodio utilissimo per l’alimentazione umana.
L’altra fonte di reddito che viene da questa natura aspra e avara, sono i treni che portano il carbone dalle antiche miniere tutt’oggi funzionanti, fino ai porti o ai consumatori finali: vediamo passare tanti convogli, sono lunghissimi con la tipica motrice a gasolio si spostano lenti portando ogni tanto a bordo anche qualche clandestino che non aveva altro modo per spostarsi.

Il nostro viaggio termina con il lungo e lento rientro verso il nostro mondo occidentale, abbiamo vissuto giornate intense di scoperta di un Paese sconosciuto ai più. Ci resterà il ricordo di una esperienza di vita rude e a contatto con una natura gagliarda in grado di fare del male a chi la sfidi, e al contempo innocua con chi la teme. Ricorderemo il silenzio profondo che pervade quei territori sconfinati e disabitati divisi tra l’oceano e il deserto.
Questo Articolo è stato pubblicato sulla Rivista Acqua & Sapone a luglio 2017, sfoglialo sul sito: https://www.ioacquaesapone.it/leggi/?n=asagosto2019#106

Ci sono i “viaggi del cuore”, c’è il “Viaggio della vita” ci sono le “vacanze spensierate”, i viaggi semplici e quelli avventurosi e poi… E poi c’è L’Azerbaijan, un Paese nel quale non ti saresti mai immaginato di andare, un Paese tutto da scoprire, nel quale letteralmente non sai cosa aspettarti e del quale non trovi neanche info sul web. Parti solo conoscendo la data del volo aereo.
Insomma ti scopri completamente ignorante di un angolo di mondo e decidi di partire, di andare a vedere cosa ti sei perso, cosa si perdono quelli che ancora non ne sanno nulla…
Ed è proprio quello che è successo a me: tornando dall’Uzbekistan ho deciso di fare con il volo uno scalo a Baku, la capitale. Fino a quel momento non l’avevo neanche mai sentita nominare…

Arrivando a Baku mi sono immediatamente accorto che le mie poche, pochissime, aspettative che avevo su questo Paese erano in realtà frutto della mia fantasia e di una specie di bonario “pregiudizio” che avevo sul Paese.
Il pazzesco sillogismo per il quale siamo convinti che una cosa, se non la conosciamo o non ne abbiamo sentito parlare, allora vuol dire che non è bella, che non la conosce nessuno e che non c’è nulla da vedere o da fare… Un vero Viaggiatore non dovrebbe mai ragionare in questo modo, ma è umano, capita di farlo… L’ho fatto anche io. Sbagliando. E per vincere la mia ignoranza ho deciso di andare a colmare le mie lacune.
L’Azerbaijan ha ottenuto la sua indipendenza dalla ex URSS il 18 ottobre 1991, per cui in tempi abbastanza recenti, mi aspettavo quindi che Baku fosse una città con vecchi retaggi da regime, con austeri e imponenti edifici di stampo sovietico. Pensavo a giganteschi condomini e strade enormi per le classiche parate militari da guerra fredda… Pensavo insomma al vecchio clichè architettonico di Berlino Est, piuttosto che a Tashkent o Tiraspol, Astana… A quelle città costruite per dare fasto al regime comunista dell’epoca.

Ecco… Appena arrivato in aeroporto mi sono immediatamente ricreduto: quello che mi aspettavo fosse un gigante grigio e squadrato di cemento armato, un grosso “scatolone” porta persone, era invece uno dei più begli esempi di architettura aeroportuale che io abbia mai visto…
Un aeroporto ricco e fastoso come quello di un Emirato Arabo: modernissimo, rifinito e pulitissimo, che alterna forme armoniche in vetro e acciaio armonizzandole tra loro con la necessaria razionalità di uno scalo che guarda solo al futuro rinnegando il proprio passato.
Rinnegare il passato per l’Azerbaijan è stato ad esempio scrivere un nuovo alfabeto per cancellare completamente il cirillico a suo tempo imposto dal regime sovietico. Qui in Azerbaijan c’è ora una scrittura di provenienza latina, ma con alcune lettere modificate, segno di una vera e propria rivoluzione culturale che, per cercare una propria identità, ha iniziato a traslitterare la propria letteratura. Il Russo però è una lingua ancora molto parlata, studiata a scuola e conosciuta da chi è nato nella vecchia URSS e ora si trova cittadino Azero.

Lasciato l’aeroporto, in pochi minuti siamo arrivati alle porte della città, il benvenuto ce lo danno le costruzioni più moderne e innovative degli archistar più famosi al mondo: prima tra tutti Zaha Hadid. E’ opera sua l’enorme museo che è alle porte della città, ed è la prima cosa che si nota all’arrivo. Un museo come questo è già esso stesso un’opera d’arte che può ammirare chiunque gli passi davanti. Siamo rimasti due ore a camminare negli enormi prati circostanti, ad osservare e fotografare la gente che andava e veniva…
A pochi passi dal museo siamo arrivati in città e abbiamo notato qualcosa di strano…. barriere, tribune, tende, pubblicità enormi, strutture prefabbricate… Era la seconda sorpresa di cui non immaginavamo nulla: due settimane dopo ci sarebbe stato il Gran Premio di Formula 1 sul circuito cittadino di Baku, un pò come quello ben più famoso di Montecarlo… Pensavamo di trovare un Paese povero, tutto da scoprire e da… “civilizzare” e invece a due ore dal nostro arrivo ci rendevamo già conto che certi eventi muovono cifre incredibili e non può organizzarli un “Paese in via di sviluppo”.

Il nostro giro nelle strade del centro è stata una scoperta ad ogni passo: l’architettura è quella tipicamente parigina, elegante e neoclassica con i tipici tetti spioventi come nella Capitale francese, e nel centro nulla rimane, inaspettatamente, delle austere linee architettoniche del regime sovietico.
Baku è una città che ci ha saputo stupire, lasciare letteralmente a bocca aperta ad ogni angolo. Modernissimi centri commerciali, una linea di metropolitana semplice ma che copre tutta la città, un centro storico fortificato con vicoli e mura nelle quali è bello perdersi andando in giro ad esplorare ogni scorcio della città tra lussuose Ambasciate che si affiancano ai negozietti di paccottiglia per turisti.
Ma il centro è un susseguirsi di nuovissimi edifici e centri commerciali modernissimi in cui vetro e acciaio la fanno da padroni a copertura delle architetture più moderne e sfarzose. Tra questi il museo del tappeto con la sua tipica forma arrotolata e con tanto di decorazioni orientaleggianti, il lungomare che si estende sul mar Caspio è tutto un susseguirsi di viali alberati, teatri, centri congressi e tantissimi edifici dedicati alla ginnastica, alla danza e agli sport di lotta che sono le specialità in cui da queste parti riescono meglio ad imporsi ai massimi livelli al mondo.

La gente passeggia nelle strade, ci sono persone che fanno sport e quelli che frequentano gli hammam decorati con un improbabile stile kitch di dubbio pregio ma di grandissimo fascino. E’ evidente un certo benessere generale, le persone lavorano tutte, la disoccupazione non è un problema ad ogni angolo di strada c’è un poliziotto di piantone, persino le stazioni della metropolitana hanno un bile di binario per ciascun senso di marcia, una cosa mai vista in nessun’altro posto al mondo. Hanno belle auto, vestono bene e c’è ancora il piacere di andare a fumare nei locali del centro per chiacchierare dei loro affari, sembra di stare nei caffè di Parigi di un secolo fa, ma senza rinunciare ai piaceri della modernità.

Andando in periferia la situazione cambia completamente. Dalle boutique scintillanti del centro prendiamo la metropolitana che ha due linee e in poche stazioni, veniamo letteralmente trasferiti come in una macchina del tempo all’epoca della ex Unione Sovietica. Qui tutto ci riporta a quell’epoca, è un’altra città, un’altra epoca storica. E invece no, sono le due facce della stessa medaglia. Qui all’ultima fermata della LINEA ROSSA dallo sfarzo e dalla modernità dei palazzi amministrativi del centro si passa improvvisamente ai giganteschi mostri di cemento armato arruginito che assumono le sembianze di dormitori di 20 piani e 10 scale con centinaia di appartamenti e migliaia di persone che ci abitano.
Ecco… qui possiamo vedere, almeno in parte, quello che ci immaginavamo dell’Azerbaijan prima di partire.

La gente in questa zona della città ha una vita frenetica, i palazzi enormi e impersonali in cui vivono, condizionano molto il loro stile di vita. Qui si esce a piedi, senza badare al look, ci si veste per andare al lavoro negli impianti petrolchimici o per andare a fare la spesa al supermercato sotto casa. Di auto ce ne sono poche e quelle che ci sono sono vecchie e malandate. In strada al posto delle scintillanti boutique del centro ci sono fetide palestre e sale bingo, negozi di barbiere e di elettronica, fast food e una serie infinita di negozi di abiti da sposa, talmente numerosi che ci domandiamo quanti possano essere i matrimoni in un anno…

Uscendo da Baku troviamo un’altra sorpresa: l’Azerbaijan è uno dei più forti produttori di petrolio e gas naturale al mondo e ce ne rendiamo conto immediatamente. Qui ci sono laghi di oro nero a cielo aperto: delle pozze putride sotto le quali da oltre 100 anni si estrae il greggio che viene esportato in tutto il mondo. Anche nel Mar Caspio ci sono giacimenti di gas a pochi metri dalla riva e vicinissimi al centro città. La zona estrattiva è molto limitata… una ventina di chilometri di diametro proprio intorno alla capitale: qui ci sono migliaia di pozzi, non ci sono recinti ma sono controllatissimi dal personale che non manca mai.
La terra è grassa, molle, priva di vita perchè impregnata di preziose sostanze, ci sono le Yanar Da, le montagne di fuoco dalle quali ininterrottamente da oltre mille anni escono lingue di fuoco e che sono state luogo sacro per la religione zoroastra. Il gas che fuoriesce dalla collina prende fuoco per autocombustione e crea un fronte di circa 12 metri di fiamme che venivano venerate dal popolo.

Ci siamo poi allontanati da Baku in direzione di Sheki per fermarci tra le aspre montagne che sono intorno a Lahic. Qui abbiamo visto la parte meglio conservata dell’Azerbaijan, dove la gente vive come una volta in una società agropastorale che a stento e solo negli ultimissimi tempi si sta aprendo al turismo e alla modernità.
Qui puoi trovare solo qualche albergo, la connessione wifi e qualche ristorante, il resto è ancora tutto come una volta: un salto nel tempo alla nostra Italia del secondo dopoguerra…
I ritmi di vita sono sereni e rilassati, il venerdì si va alla moschea, la gente parla in strada o gioca a domino mentre sorseggia un bicchiere di the fumando liberamente nei locali pubblici.

Qui si possono fare amicizie fatte di sguardi e di sorrisi, la gente non parla inglese ma ha voglia di socializzare e allora ti accoglie come può offrendoti un bicchiere di the o un caffè o chiedendoti una sigaretta in cambio. Per accogliere qualcuno non serve aver studiato le lingue, non serve neanche avere chissà quali discorsi da fare, a volte basta sedersi a tavola con un estraneo che ti fa capire che ha piacere di stare con te. E’ una sensazione molto forte, alla quale noi non siamo abituati, ma che invece è invece importante saper apprezzare.
Questo è il mio Azerbaijan, un Paese pieno di sorprese e tutto da scoprire.


Ritenevo di aver preparato con cura il Viaggio in Mongolia, approfondendo sia la vita della popolazione nomade sia la straordinaria offerta naturalistica di questo meraviglioso e sconfinato Paese; colpevolmente, non avevo approcciato in maniera esaustiva il Buddismo ed il rapporto tra i Fedeli ed i Monaci Buddisti.
Chissà, forse inconsciamente , ho preferito calarmi in maniera asettica ed “epidermica” nella fantastica emozione di fotografare questo mondo di pace ed interiorità.
Varcare la soglia di un Tempio Buddista, significa utilizzare una sorta di Stargate che ti proietta in una dimensione fatta di serenità, trascendenza, compartecipazione ed assoluto amore per il prossimo e per la natura; osservare i Monaci che si preparano all”ingresso nel Tempio ed assistere al “servizio” durante il quale un Lama per un fedele recita una sutra con il tipico canto gutturale del Buddismo Tibetano, inizialmente mi ha quasi fatto dimenticare la “fotografia” provocandomi una diffusa e persistente sensazione di benessere da non interrompere.’

Stavo pensando al Texas. Non volevo che fosse il solito viaggio negli USA alla scoperta dei pur meravigliosi Parchi americani, li avevo già visti due volte facendo due Coast to Coast.
Quello che avevo capito nei viaggi precedenti è il fatto che ciò che mi piaceva degli Stati Uniti non sono tanto le grandi città o le bellezze incontaminate dei monumenti naturali.
No, avevo capito che l’aspetto che preferivo del viaggio è la scoperta della Provincia americana, quel Deep South sperduto e dimenticato da dio e dagli uomini.
Mi affascinava il nowhere di quelle cittadine che sorgono in mezzo al nulla e che hanno ragione di esistere solo perchè lì qualcuno ci ha messo un distributore di benzina, un fast food e un supermercato nel quale comprare di tutto, dalla falciaerba ai fiocchi d’avena.

Quelle cittadine disabitate nelle quali non ci sono case, dove la gente vive nei ranch distanti anche 70 miglia dal centro e dove si va in paese una volta alla settimana per fare la spesa o il pieno di benzina, dove a causa delle distanze i bambini vanno a scuola con lo scuolabus…
Ecco… Quelli erano i posti che volevo imprimere per sempre nella mia memoria emozionale e fotografica, quelli sarebbero stati la meta del mio viaggio in Texas, un viaggio che non volevo perdermi, pieno di fascino e di aspettative.

Intendiamoci: sapevo di non potermi aspettare grandi cose, nè paesaggi mozzafiato, nè monumenti storici o scavi archeologici. Sapevo che sarebbe stato un viaggio piuttosto intimo più alla ricerca di me stesso che non alla scoperta di luoghi da cartolina, per andare a trovare tutto questo mi documentai a lungo e scelsi il Texas, dove ho trovato tutto quello che mi aspettavo…
Partimmo in agosto, volevo il periodo più caldo e soleggiato per andare a scoprire il Texas e le sue sconfinate praterie, per percepire sulla mia pelle il rapporto tra uomini e bovini che mi avrebbe riportato ai vecchi film western di John Wayne visti nelle lunghe afose domeniche estive o in terza serata in compagnia di mio padre: lui vedeva quelle pellicole per rivivere la sua gioventù mentre io le vedevo per sognare qualcosa che finalmente mi apprestavo a realizzare.


Il nostro viaggio è iniziato da Houston, la città più importante del Texas, uno degli Stati più estesi degli USA, mezzo deserto, mezzo al pascolo, tagliato a nord dalla mitica Route 66 nelle città di Amarillo e Flagstaff.
Houston è famosa in tutto il mondo per la famosa base di lancio missilistica, quella del film Apollo 13: “Houston, abbiamo un problema”, la base è tutt’oggi visitabile, si può ancora vedere la famosa sala di controllo dalla quale venivano lanciati i missili diretti verso la luna e un missile intero all’interno di un hangar, è annesso un museo dell’esplorazione spaziale che piace molto ai “bambini” da 5 a 70 anni!

C’è poi un posto che si chiama Marfa, è un piccolo villaggio, la cittadina ospita un piccolissimo ma interessante museo di arte moderna e contemporanea che ha una sua installazione proprio in mezzo al deserto a poca distanza dal centro: si tratta di una (falsa) vetrina di Prada con tanto di insegna e logo originale che secondo l’idea dell’artista sarebbe lì per esporre le creazioni del famoso stilista ai pochi viaggiatori di passaggio.

Viaggiare nel Deep South americano non è facile ma è bellissimo: il Texas è un luogo vuoto con enormi praterie, orizzonti infiniti, niente montagne e niente persone, poche auto… Il caldo si fa sentire tutto il giorno e mi è capitato di viaggiare per due giorni senza vedere assolutamente nulla, in una strada che divide in due uno spazio abitato solo da vacche e cavalli.
Un viaggio on the road, quindi, da godersi al volante andando a cercare le piccole cose che a sorpresa si susseguono chilometro dopo chilometro, andando a provare la cucina messicana che ha sconfinato anche qui sui tavolacci di legno grezzo che sono nei pub, andando a ballare il country in un locale con musica dal vivo di fronte alla ferrovia…

I texani si sentono vaccari, in effetti sono i pronipoti dei cow boys che vedevo in quei film che hanno riempito la mia infanzia: il loro look è rimasto oggi come allora.
Mi ha colpito il fatto che un viaggio in Texas è molto più etnico di quello che si possa pensare: la gente veste ancora con il classico cappellone a falda larga, la camicia a quadroni, i jeans e gli immancabili boots, gli stivaloni di cuoio impunturati con disegni fiorati.
E anche il loro stile di vita non è granchè cambiato da allora: amano muoversi a cavallo e radunare le mandrie al pascolo galoppando tra centinaia di capi della specie texana che si chiama long horn, ossia lungo corno. Posso garantire che le dimensioni del copricapo sono veramente esagerate arrivando a sfiorare i due metri di apertura totale!

In America tutto è grande: dai pascoli alle dimensioni delle mandrie, un bovino ha bisogno di 70 ettari di pascolo per anno, una mandria di piccole dimensioni con 400-500 capi (a conduzione familiare) ha bisogno di uno spazio grande come mezza Provincia delle nostre…
In Texas sono rimasto letteralmente estasiato a rimirare per ore i giganteschi silos in acciaio specchiato di immagazzinamento di granaglie, ho passato ore a fotografare un ufficio postale abbandonato in un incrocio nel bel mezzo del nulla, mi sono fermato per mezz’ora a guardare un pozzo di petrolio che pompava il prezioso oro nero…
Le cose che mi piacciono di più quando viaggio sono i mercati popolari, ma non credevo che ce ne fossero negli USA, nella grande civiltà modernizzata americana. E invece ne ho trovato uno straordinario. E’ un mercato settimanale, lo fanno dal venerdì pomeriggio alla domenica dalle parti di Fredericksburgh ed è un vero mercatino dell’usato in stile texano.
La cosa fantastica è la gente che va a vendere pezzi di casa e vecchi memorabilia originali di antichi ranch. Ti capiterà di trovare in vendita dalla classica cassetta per le lettere sagomata a forma di bufalo fino all’insegna del benzinaio della Texaco o al martello da maniscalco per ferrare i cavalli…
E poi migliaia di targhe automobilistiche arrugginite, vecchi giocattoli di legno, juke box degli anni ‘50 e ‘60, pannelli della Coca Cola, teste di alce imbalsamate…
E’ un posto incredibile: spesso i venditori sono coppie di pensionati (anche loro ovviamente in perfetto look da bovari) che hanno cambiato casa e invece di gettare pezzi della loro storia li vendono al mercatino.
Restano lì sulle loro poltroncine con la lattina di birra in mano e visto che da quelle parti sono completamente fuori da ogni itinerario turistico. Eravamo gli unici forestieri ed eravamo noi a stimolare la loro curiosità a tal punto che la gente ci fermava per chiederci se ci fossimo persi. Alla nostra negazione rispondevano: «ma allora perchè siete venuti? Qui non c’è nulla da fare nè da vedere, ci sono solo vacche e cavalli…»

Invece per un viaggiatore in un posto del genere di cose da fare e da vedere ce ne sono davvero tante: dal cimitero delle Cadillac ad Amarillo, un posto dove sono state conficcate 12 automobili vere nel terreno e ora sono diventate un monumento del famoso brand americano alla portata di tutti che sono liberi di decorarle con vernici e ogni altro tipo di arte.

Un viaggiatore apprezzerà bar e motel in stile anni ‘50 e ‘60 lungo la Route 66 nei quali il tempo sembra che si sia fermato all’epoca nella quale sono stati costruiti.
Un viaggiatore non potrà che notare le enormi strade deserte e assolate tipo “Mezzogiorno di fuoco” in pieno centro abitato.

Ma se c’è una cosa per la quale il viaggio merita di essere fatto è il Rodeo che abbiamo visto a Johnson City, ce ne sono tanti in giro: anche ad Austin, o a Vega… E’ una delle cose più belle di tutto il viaggio.


Il Rodeo è una festa che dura per tutto il week end. Si arriva il venerdì pomeriggio per iniziare a sistemarsi con i camper e le stalle a ruote in tempo per gli allenamenti pre-gara.
Il terreno di gara è il classico recinto fatto con pesantissimi tubi di ferro a prova di toro, sono più alti di una persona e proteggono gli spettatori da ogni incidente.
La sera al tramonto si iniziano a diffondere nell’aria gli odori degli stand gastronomici che profumano l’aria con aromi di patatine fritte e di carni alla brace.
E dopo cena iniziano le danze: persone di tutte le età che si alternano nelle quadriglie, in balli tipici del country melodico o ritmato del sud…

Il sabato mattina ci sono le prove libere delle varie specialità, ciascun atleta prova per l’ultima volta i suoi movimenti, ottimizza le attrezzature e le protezioni personali perchè si tratta di sport comunque molto duri e violenti.
Poi inizia un momento di forte concentrazione e tutto sembra fermarsi in una atmosfera ovattata in attesa delle gare di specialità.

La sera del sabato, poco prima del tramonto si inizia e l’atmosfera diventa immediatamente elettrica. La voce del cronista apre il Rodeo e fa uscire tutti: sulle note de “I Magnifici Sette” entrano i cavalieri con le bandiere degli Stati Uniti e del Texas, segue l’inno degli USA e iniziano le prime manches di velocità per catturare il vitello al lazo e legarne le zampe.
Lo speaker parla dei cow boys in gara e si intende che sono tutti suoi vecchi amici e ne racconta le gesta descrivendoli come eroi, è una grande famiglia quella che unisce questa gente: si rivedono di volta in volta nei vari rodei sfidandosi in competizioni fatte per uomini duri e donne coraggiose ma non solo: lo stadio va letteralmente in delirio quando si aprono i cancelli ed escono i bambini aggrappati ai montoni che fuggono: vince il giovane campione che riesce a rimanere più a lungo sulla povera bestiola.

E dopo i bambini ecco la gara finale, la più attesa, la più breve ma pericolosa e spettacolare, la più impegnativa, stiamo parlando della monta del toro. Qui la sfida è talmente difficile che vincono tutti quelli che riescono a rimanere seduto sull’enorme animale per almeno 8 secondi. Chi resiste va a finire nell’Olimpo dei Cow Boys, nell’albo d’oro di quelli che ce l’hanno fatta.
Non conta il migliore, il migliore è sempre il toro, non importa quanti siano i vincitori o se non ce ne sia nessuno, qui basta sopravvivere anche perchè cadendo si rischia di rimanere schiacciati dalla furia e dalla potenza indomita del bovino, impossibile controllarlo, l’unica cosa che possono fare gli assistenti di gara è ricondurlo nel suo recinto dopo che scalciando ha disarcionato l’uomo che ha cercato invano di dominarlo.

Al mattino successivo i cow boys fanno una parata d’onore in città per mostrarsi e farsi applaudire dai propri familiari e poi il Rodeo è ufficialmente finito: i camper smontano gli accampamenti, uomini e cavalli si preparano per tornare alle loro case che a volte possono essere lontane centinaia di miglia, o trovarsi in New Mexico o Arizona….

E con i cow boys che tornavano a casa, anche noi riprendemmo la strada: il nostro viaggio era ancora lungo e Los Angeles ancora lontana, ma questo magari ve lo racconterò la prossima volta…

[/vc_gutenberg][vc_gutenberg]Articolo pubblicato sul numero di luglio 2018 della Rivista in distribuzione gratuita in tutti i negozi di Acqua & Sapone.
Clicca sulla foto per leggerla on line

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di luglio 2018 della Rivista in distribuzione gratuita presso i negozi #Acqua&Sapone, direttore #AngelaIantosca


Il Perù raccontato dopo 30 anni da Andrea Del Genovese di Pisa. Altri tempi, altra fotografia. All’epoca naturalmente si scattava in pellicola, anzi, in questo caso in diapositiva, si scattava tutto in manuale e le foto si riguardavano solo una volta tornati a casa… Non c’erano monitor, nè stampe fine art, i più raffinati stampavano il bianco e nero nel bagno di casa. Chi voleva il massimo dai colori affidava le sue diapositive ad un laboratorio professionale rimanendo in attesa per giorni per vedere il risultato dei propri scatti.
Quando si faceva una foto la si pensava e si scattava molto meno perchè le pellicole avevano un costo immediato. C’era una cura diversa nel fare le cose, il fotografo all’epoca entrava davvero in empatia con la fotocamera e impiegava tutto se stesso per uno scatto. Da allora in 20 anni sono cambiate più cose nella storia della fotografia che nei precedenti 150 anni da quando fu inventata…
Il nostro Andrea è andato a rispolverare le foto del Perù dall’archivio di famiglia per farci scoprire un modo diverso di fare fotografia. Tecniche diverse, ma anche un linguaggio visivo che oggi è completamente cambiato.
Voglio ringraziare Andrea Del Genovese per aver voluto condividere con noi un pezzo della sua storia personale e per chi fosse interessato al Perù noi ci andremo dal 20 al 31 agosto 2018: https://viaggiofotografico.it/22396/peru-inca/
BUONA VISIONE
La tecnologia applicata alla fotografia ha fatto passi da gigante; prova lampante le foto che presento (decisamente vintage!) relative ad un viaggio fatto nel 2001. Tutte fatte con DIA scattate con una Pentax Me super e frame di video girati con Sony VHS, entrambe digitalizzate.
Le immagini hanno questo sapore indefinito, sbiadite e poco incisive, ma i ricordi del viaggio in una terra meravigliosa come il Perù sono ancora assolutamente freschi e vividi.
Il Perù, con le proprie popolazioni Quechua, Aymara ed altri Gruppi Etnici, ha il potere di affascinare il viaggiatore grazie ai suoi spettacolari scenari sia naturalistici che archeologici legati alla Civiltà Inca.
Percorrere la Valle dell’Urubamba, godersi la vista di Machu Picchu dalla Puerta del Sol, vivere il colorito mercato di Pisac, ingraziarsi il Lago Titicaca offrendogli alcune foglie di coca per assicurarsi un rientro a Puno dopo l’escursione all’isola di Taquile, esaltarsi con la vista aerea delle Linee di Nazca, immaginare come l’uomo abbia potuto 500 anni fa utilizzare i massi ciclopici della Fortezza di Sachsayuaman, ammirare la perfezione chirurgica della “piedra de los doce angulos” di Cuzco…
Vi lasceranno ricordi incancellabili e Voi avrete la fortuna di scattare in digitale ! Attendo con ansia le Vs . foto !
Non perdeteVi il Perù !!
Andrea Del Genovese
https://www.facebook.com/andrea.delgenovese.3


Durante le tre edizioni del nostro Viaggio Fotografico in Uzbekistan i nostri Viaggiatori si sono espressi con foto e video sul Buzkashi, che da queste parti chiamano Kupkari.
Tre nostri Compagni di viaggio ci hanno dato la loro personale lettura di una giornata straordinaria:
E per finire in fondo alla pagina ci sono anche i video di:
Scopri tutto in questa pagina e guarda come hanno trattato lo stesso argomento in modi tanto diversi…

Acchiappa la capra! Questo è il significato della parola uzbeka Kupkari e della corrispondente parola parsi Buzkashi. Si tratta di un antico sport equestre molto popolare in Uzbekistan e in molti paesi dell’Asia centrale.












E’ il nome di un antico gioco equestre che ha origine in Asia centrale dove è ancora diffuso e praticato in occasione di festività ed eventi speciali.
Con « viaggio fotografico » abbiamo potuto assistere a questa straordinaria festa, non lontano da Samarcanda, in Uzbekistan, in occasione del Navruz che celebra l’equinozio di primavera e l’inizio del nuovo anno, secondo una tradizione che risale ai tempi del zoroastrismo .
Niente arene, piazze o stadi, con scalinate, balconi o tribune. Il Kupkari si gioca all’interno di una spianata stepposa, delimitata da dossi di terra, dove si assiepa il pubblico, soprattutto donne e bambini, che incitano i valorosi cavalieri, rigorosamente uomini, che si trovano più in basso e si contendono la carcassa di una pecora o un montone per portarla e depositarla oltre il traguardo.
In premio ci sono somme di denaro, beni di consumo e il riconoscimento del proprio valore. Come in ogni competizione equestre che si rispetti, non mancano gli allibratori e le scommesse.










La giuria e gli ospiti privilegiati, quali eravamo noi fotografi venuti da lontano, trovano posto a bordo di autocarri che, disposti in fila, delimitano l’area di della competizione. Gli stessi offrono pure un riparo dagli impetuosi assalti dei cavalieri e dagli zoccoli dei loro cavalli.
Il gioco è piuttosto violento e le regole concedono di tutto, compreso l’uso di un improbabile frustino, che i cavalieri stringono tra i denti, usato per colpire l’avversario e per disarcionarlo.
Per proteggersi, i cavalieri indossano dei copricapo di ogni genere, tra questi un vecchio e bizzarro berretto da carrista, reliquia dell’era sovietica.
La competizione comincia con i saluti di rito e una preghiera, un trattore trasporta la carcassa al centro del campo e la competizione ha inizio.
L’energia sprigionata dai cavalli al galoppo e dai cavalieri che lottano, corpo a corpo, impennando i loro destrieri è davvero impressionante e coinvolgente.
Il Kupkari non è soltanto una competizione equestre, ma è anche e soprattutto una grande festa di paese. Non abbiamo assistito ad un evento confezionato per i turisti, bensì ad un momento di indimenticabile folklore autentico e genuino.

Il Buzkashi (chiamato anche Kupkari) è uno sport equestre praticato in tutta l’Asia centrale e considerato sport nazionale in Afghanistan.
In Uzbekistan è generalmente praticato in determinate occasioni come matrimoni o feste nazionali.
E’ praticato in un grande campo; l’obiettivo è quello di impadronirsi della carcassa di una capra, portarla lungo un percorso obbligato e lanciarla oltre un’area definita. I giocatori utilizzano una piccola frusta in pelle grezza che viene tenuta tra i denti quando non è usata.








Non esistono regole scritte, sono per di più tramandate oralmente e frutto di una lunga tradizione ed è concesso di tutto, da colpire l’avversario con il frustino a farlo cadere da cavallo E’ sicuramente uno sport piuttosto violento, ma fa parte delle tradizioni locali e ha origini antiche.
Si pensa che sia stato introdotto dai Mongoli nel 12mo – 13mo secolo.
Il Buzkashi in Uzbekistan viene organizzato in modo spontaneo e non è sempre facile conoscere il luogo esatto e l’ora in cui si svolgerà ,ma grazie alla nostra preziosa guida Bek siamo riusciti a partecipare a questo evento.
L’atmosfera che si respira è festosa, la gente locale, ammassata attorno al campo, tifa, scommette, ma anche si cucina carne alla brace e i locali ti invitano a mangiare con loro e a bere (vodka!).
C’è fierezza e determinazione nel volto degli uomini che a cavallo sono pronti a tutto pur di raggiungere l’obiettivo e conquistare così il premio e dimostrare il loro coraggio.
di Lia Taddei

Avevo sempre snobbato New York. Mi domandavo: ma perché tanta gente ci va? Cosa ci trovano di interessante in una megalopoli caotica? Ma, se piace a tanti, una ragione ci deve pur essere.
Così ho deciso: proviamo. Fu una delle decisioni più azzeccate che abbia mai preso, ne sono rimasto letteralmente entusiasta.
Perché New York è davvero la capitale del mondo. Girando con l’underground in poche ore potete passare dal Brasile alla Russia, dal Sudamerica all’Africa. Ed è straordinaria la gente che popola questa città, a cui ho voluto dedicare questo portfolio.
Perché anche dal punto di vista umano a New York si trova davvero di tutto: dogsitter professionali, anziani pattinatori, runner obesi, amanti dei piccioni, calciatori di fiume…
E non ultimo New York è il paradiso della street photography: si può fotografare liberamente quasi in ogni luogo e le persone fotografate, nella maggior parte dei casi, sembrano considerarla una cosa normalissima.
E poi a NY si trova un’incredibile varietà di soggetti e di ambienti: si può fare il giro del mondo in pochi giorni prendendo solo l’underground, senza uscire dalla città.
E dunque come non approfittarne? Io ne ho approfittato!
Eccovi il risultato


Raccontare un viaggio con delle immagini: una bella scommessa per un fotoamatore dilettante come me. Ma ci provo perché il viaggio in Vietnam dell’ottobre scorso ha avuto delle particolarità.
La meta era, sulla carta, interessante ma non quanto alcuni paesi limitrofi del sud est asiatico che vantano insigni siti archeologici.
E’ un paese di antichissime tradizioni ma devastato da guerre che hanno influenzato profondamente il suo sviluppo.
Ci sono grandi e caotiche città con moderni grattacieli che però assomigliano incredibilmente ad altre città di recente sviluppo.
Nonostante tutto ciò, la nostra visita, seppur limitata nel tempo, dodici giorni, ci ha permesso di avvicinarci al cuore profondo del paese e di sentirne il respiro.
Ho avuto conferma delle mie sensazioni leggendo i racconti di Nguyên Huy Thiêp nella raccolta “Vietnam Soul”. Ambientati nei villaggi di montagna lontano dai grandi centri cittadini narrano della lotta quotidiana della gente per vivere, della fatica di affrontare le malattie e il dolore , di soddisfare i normali bisogni.
Storie di piccole comunità si alternano a figure solitarie ma sempre dalla narrazione traspare grande forza e senso di solidarietà.
Nelle mie foto ho privilegiato scatti a uomini e donne in ambiente di lavoro, un’umanità attiva, giovane di età che sprigiona energia vitale e affronta con coraggio le difficoltà della vita. Senza tralasciare anche un momento dedicato al sentimento religioso.
Ornella Massa
Facebook: https://www.facebook.com/ornella.massa.372

Nell’ambito delle spedizioni uzbeko – giapponesi è stato scoperto un quadro dell’VIII secolo, riporta Uzbekistan Today. L’artefatto antico è stato rinvenuto nella fortezza Kafirkala è rappresenta un tabellone che raffigura un rituale dello Zoroastrismo.
Il ritrovamento a Samarcanda prova l’importanza dell’Uzbekistan come una regione situata sulla Via della Seta e raffigura uno strumento musicale situato nell’edificio del tesoro “Shoso-in” nella città di Nara in Giappone.
La fortezza Kafirkala si trova a trenta chilometri a sud-est del sito di Afrosiab. La presenza dei fori da chiodi di ferro indica che il quadro era attaccato al muro e si presume che all’epoca si trovasse nella sala del sovrano.
“L’immagine è composta da quattro righe. Nella riga superiore è raffigurata la dea di Sogd “Nana”, seduta sul leone, nella seconda riga i musicisti suonano l’arpa e lo strumento a corde “biwa”, entrambi conservati nello “Shoso-in”. La riga più bassa raffigura l’altare del fuoco. Si ritiene, che la storia dell’arpa abbia avuto l’inizio in Assiria, nella Mesopotamia Settentrionale e che lo strumento musicale sia stato trasportato dall’Asia Centrale alla Cina e al Giappone”.

Gazeta.uz
Il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ha firmato il decreto sulla creazione della zona turistica libera “Chorbo’q”.
La prima zona turistica sarà creata all’interno del territorio ricreativo e di resort “Chimgan-Chorbo’q” con nuove infrastrutture d’ingegneria, moderni complessi alberghieri, centri di benessere e culturali, commerciali e d’intrattenimento e altre strutture turistiche.
Il decreto prevede la preparazione degli itinerari turistici unici, tenendo conto delle possibilità ambientali della regione, sviluppando un’adeguata infrastruttura di trasporto, garantendo la disponibilità di trasporti, l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto nella regione (treni, treni elettrici, autobus), compresi i mezzi di trasporto alimentati con fonti di energia rinnovabile, l’espansione delle rotte di trasporto passeggeri e l’organizzazione del suo ininterrotto funzionamento.
Si prevede di creare ulteriori condizioni per la sicurezza del soggiorno dei turisti, attrezzando le infrastrutture turistiche con sistemi di allarme e videosorveglianza, fornendo assistenza in situazioni d’emergenza e attivando un singolo database di informazioni sui turisti, che arrivano nel territorio della regione.
È prevista la realizzazione dei progetti sulla creazione di un sistema ecologico unico, introducendo, in via sperimentale, i nuovi sistemi di risparmio energetico e le tecnologie alimentate con fonti di energia rinnovabile e alternativa.
La zona turistica libera sarà realizzata per il periodo di funzionamento di 30 anni con la possibilità di una successiva estensione. Il territorio della zona turistica e le imprese registrate come partecipanti sono soggette alle disposizioni della legislazione sulle zone economiche libere, comprese le agevolazioni e i benefici stabiliti.
Per cofinanziare progetti d’investimento, attuati nella zona turistica libera, il Fondo per la Ricostruzione e lo Sviluppo dell’Uzbekistan concederà una linea di credito agevolato per un importo complessivo di 100 milioni di dollari statunitensi con le condizioni flessibili di rimborso del prestito e degli interessi.
Attualmente, nella regione di Tashkent operano 120 organizzazioni di servizi turistici, tra cui 15 tour operator, 45 alberghi con la capacità di accogliere 2440 turisti al giorno, 71 sanatori e aree ricreative.

Nei prossimi due mesi sarà preparato il progetto di decisione governativa che consentirà la vendita di lingotti d’oro agli stranieri e semplificherà la loro esportazione all’estero.
Per il prossimo futuro si prevede anche la vendita di lastre in oro di vari tagli da dieci a duecento grammi.
Si prevede di esportare gioielli e oggetti preziosi per quasi 14 milioni di dollari statunitensi nel 2020.

L’Uzbekistan per la prima volta nella storia affida la gestione di un aeroporto alla società privata. L’aeroporto internazionale “Karshi” (regione di Kashkadarya) sarà assegnato alla società specializzata nella gestione di aeroporti internazionali.
La risoluzione del Presidente Shavkat Mirziyoyev “Sulle misure per lo sviluppo del turismo in entrata” stabilisce l’uscita di quest’aeroporto internazionale dalla società NAC (Uzbekiston Havo Yullari) e l’introduzione del “Cielo aperto” sul suo territorio con il coinvolgimento delle compagnie aerei low cost.

L’Uzbekistan ha abolito l’obbligo del visto per i cittadini di sette paesi. Introduzione del visto elettronico dal 1° luglio 2018
Dal 10 febbraio 2018 L’Uzbekistan introduce il regime senza visti per un ingresso di trenta giorni ai cittadini di Israele, Indonesia, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Turchia e Giappone.
Inoltre, è stata semplificata la procedura di rilascio del visto turistico per altri trentanove paesi, tra cui il Vaticano e la Malta:
– annullamento dell’obbligo di presentare al Ministero degli Affari Esteri dell’Uzbekistan il voucher turistico o la lettera d’invito da parte di un cittadino uzbeko o un’impresa operante in Uzbekistan;
– rilascio del visto in due giorni lavorativi, escluso il giorno di accettazione della richiesta del visto.
Si prevede di semplificare la procedura del rilascio del visto in cinquantuno paesi (da 15 a 51).
Inoltre, dal 1° luglio 2018 l’Uzbekistan prevede il rilascio del visto elettronico per i cittadini stranieri. Il visto elettronico sarà rilasciato in aeroporti del paese in conformità con le richieste in forma scritta presentate dai cittadini stranieri per avviare la procedura del rilascio del visto d’ingresso, indipendentemente dalla presenza della rappresentanza diplomatica della Repubblica dell’Uzbekistan nel paese d’origine.
I pagamenti di tariffe e oneri inerenti al rilascio del visto elettronico si potranno effettuare con la carta di credito sui circuiti di pagamento internazionali Visa e MasterCard.
Per il tuo visto italiano per recarti in Uzbekistan clicca qui: http://evisa.mfa.uz/evisa_en/

Secondo il servizio stampa del Comitato Statale per il Turismo della Repubblica dell’Uzbekistan, al fine di creare le condizioni confortevoli per i turisti stranieri e per le strutture ricettive, il Ministero degli Affari Interni della Repubblica dell’Uzbekistan ha annullato l’obbligo di compilare il libro di registrazione e di presentare resoconti cartacei sui turisti da parte degli alberghi e altre strutture turistiche che passano all’utilizzo del sistema informativo “E- Mehmonhona”.
L’introduzione di nuove disposizioni per la registrazione degli ospiti e l’annullamento delle restrizioni sono validi per i turisti che arrivano in Uzbekistan per il turismo ecologico, estremo e per i turisti che viaggiano in auto:
1. Il software “E-Mehmonhona” (E-Hotel) consente di inserire le informazioni necessarie via Internet ed è stato introdotto per la registrazione rapida e pratica degli ospiti negli alberghi e altre strutture ricettive.
2. È stata semplificata la procedura di registrazione per i turisti stranieri durante i tour ecologici o viaggi in auto nel paese, trasferendola in un formato elettronico. Gli elenchi elettronici di turisti completi di estremi del passaporto, presentati dagli operatori turistici, comprensivi degli itinerari, soste di pernottamento durante i viaggi, saranno equiparati al permesso di soggiorno temporaneo se:
a) accompagnati da guida turistica o da istruttore all’interno del tour organizzato dall’agenzia turistica al di fuori delle aree popolate, se il tour o parte di esso non supera i dieci giorni;
b) da stranieri su auto privata, in motocicletta, in bicicletta, a piedi o in gruppo su autobus del tour organizzato dall’agenzia turistica.
3. “Campeggio”, “mezzo di trasporto, convertito in alloggio per il pernottamento” sono stati inclusi nella categoria “struttura ricettiva”.
I turisti stranieri, in sostanza, non sono più soggetti alle restrizioni in caso di viaggi attraverso le montagne, steppe e deserti dell’Uzbekistan e se arrivano con un mezzo di trasporto, attrezzato di posti letti o con la roulotte.

La stipulazione dell’accordo tra le compagnie aeree Uzbekistan Airways e Alitalia ha offerto grandi vantaggi del pieno utilizzo della vasta rete aerea dell’Alitalia. Secondo il nuovo calendario, i voli dell’Uzbekistan Airways da/per Roma e da/per Milano sono garantiti con attracchi bilaterali con i voli italiani interni e voli europei delle compagnie partner.
La modifica del programma dei voli HY – 257/258 Tashkent – Roma – Tashkent e Tashkent – Milano – Tashkent nel 2017 ha consentito di organizzare il trasporto di gruppi di turisti provenienti da Italia e Spagna (Madrid, Barcellona e Valencia) in Uzbekistan sui voli della Compagnia Aerea Nazionale (NAC). Inoltre, secondo il nuovo calendario, i voli della NAC da Roma, che hanno ottenuto l’attracco per i voli del mattino da Tashkent a Urgench, stanno creando un’ulteriore comodità per operatori turistici, rendendo i tour in Uzbekistan più efficienti e razionali.
Dal 27 marzo 2018 la NAC aumenterà la frequenza dei voli dall’Italia per tutta la stagione primavera – estate, aggiungendo il secondo volo da Roma in Uzbekistan (2° e 4° giorno della settimana). Dal 6 agosto al 26 ottobre 2018 sarà aggiunto il secondo volo anche da Milano (1° e 4° giorno della settimana).
Al fine di creare servizi aggiuntivi per i turisti provenienti da Milano e da Roma, sono previsti i voli di linea aggiuntivi con atterraggio a Urgench (Khiva). Se la domanda raggiunge almeno 80 passeggeri per le rotte Roma – Urgench e Milano – Urgench sui voli del 2° giorno della settimana, sarà considerata la possibilità di organizzare altri atterraggi nella città di Urgench anche per le restanti date.
Informazioni: aeromobili moderni e confortevoli, con la scritta “Uzbekistan” a bordo, eseguono voli regolari in più di 50 paesi del mondo, e voli charter dall’Alaska fino alla Nuova Zelanda. Nel 2016, la compagnia aerea nazionale ha trasportato 2,5 milioni di passeggeri e 43.000 tonnellate di merci. Nel 2017 la NAC ha messo in funzione due nuove rotte: Dushanbe (Tajikistan) e Lahore (Pakistan), così come nuove rotte verso Mumbai (India) e Guangzhou (Cina).
Nel mese di agosto 2016 Uzbekistan Airways ha messo in funzione aeromobili Boeing-787-8 Dreamliner. La NAC in collaborazione con la società Boeing, ha aperto il Centro per la riparazione di materiali compositi degli aeromobili, ampiamente utilizzati nell’industria aeronautica mondiale.
Tutti gli 11 aeroporti del paese sono stati completamenti ricostruiti e modernizzati, ricevendo lo status internazionale. A seguito della modernizzazione e del miglioramento del servizio, il flusso di visitatori stranieri nel nostro paese è aumentato. Gli aeroporti “Tashkent”, “Samarcanda”, “Bukhara”, “Urgench” e altri hanno vinto numerosi concorsi internazionali.
Il Centro logistico intermodale internazionale, creato sulla base dell’aeroporto “Navoi”, è uno dei più grandi e tecnologicamente avanzati complessi di trasporto aereo di merci sul territorio dell’Asia Centrale. Oggi, il Centro collega l’Uzbekistan con i maggiori centri logistici in tutto il mondo: Francoforte, Milano, Bruxelles, Vienna, Saragozza, Oslo, Basilea, Dubai, New Delhi, Teheran, Shanghai e altri.
Prosegue la collaborazione con i partner sudcoreani sulla realizzazione del progetto per la costruzione del terminal passeggeri più moderno dell’Asia Centrale “Tashkent-4”, che avrà una capacità di 1500 passeggeri l’ora. Il nuovo terminal passeggeri sarà messo in funzione entro la fine del 2019.


L’antica e grande casa di pietra ci accoglie nelle stanze bianche di calce, arredate con mobili funzionali di semplice fattura.

Cani festosi salutano il nostro arrivo con effusioni contenute.

Abbiamo conosciuto a Razzuolo Margherita e Andrea, i nostri ospiti. Con i loro veicoli a quattro ruote motrici ci hanno prelevato al parcheggio e condotto rapidamente al Podere Giuvigiana per la stretta ripida strada bianca.
Al podere incontriamo Duccio che ci accompagna a vedere l’orto sinergico che produce la verdura utilizzata per i pranzi, il frutteto che ha bisogno di essere potato e il bosco di pini Douglas che circonda la casa e che verrà diradato per fare spazio ad altre colture.

Ci parlano dei problemi che quotidianamente devono affrontare per rendere casa e podere economicamente autonomi e dei loro sogni di sviluppo della proprietà, in accordo al progetto iniziale. Il racconto sarà da loro continuato nei giorni seguenti e darà modo a noi di comprendere la passione di questi ragazzi per la natura e per la vita di campagna ed il loro profondo desiderio di condividere la loro esperienza con quanta più gente possibile.
Ci fanno conoscere i loro giovani ospiti-lavoratori: sono ragazzi simpatici , provenienti sia dall’Italia sia dall’estero, che li aiutano nelle diverse attività in cambio di vitto e alloggio. Dormono in tende in una piccola radura del bosco.

Ceniamo nella grande sala da pranzo annessa alla cucina. Intorno al lungo tavolo si snocciolano storie che continuano nella sera, seduti sulle panche di legno, sotto il nero cielo punteggiato di stelle.
L’indomani la giornata inizia con la mungitura delle caprette: un evento normale nelle campagne, ma noi vi assistiamo come in un film!

Margherita, che è guida naturalistica, ci accompagna alla scoperta della linea ferroviaria faentina e di alcune vecchie strutture di servizio ormai dismesse. La passeggiata nei boschi dell’Appennino è piacevole di per sè, ma è resa ancora più interessante dal potersi avvicinare a edifici abbandonati in cui ancora risuonano le voci di coloro che qui vissero e lavorarono.

Il giorno successivo, grazie a Margherita e Andrea, conosciamo Andrea Gatti, presidente dell’organizzazione ONLUS Gotica Toscana. Con lui saliamo sul Monte Altuzzo, il luogo dove, durante la seconda guerra mondiale, gli Alleati riuscirono a sfondare la linea difensiva tedesca in Italia per riversarsi poi nella pianura padana. Qui volontari stanno lavorando alla ricerca e restauro di postazioni militari. Le parole del presidente ci affascinano e ci ricordano eventi tragici della nostra storia di cui tutti abbiamo sentito, ahimè, parlare. L’occasione ci fa riflettere sull’importanza della pace.

L’ultimo giorno di permanenza i nostri ospiti ci accompagnano in un luogo di frescura, il torrente Rovigo, dove si susseguono pozze di acqua con cascatelle scintillanti che fotografiamo sperimentando l’uso dei tempi lunghi.

Speriamo che le foto scattate in questi giorni possano almeno in piccola parte emozionarci come le ore vissute in questo podere che Margherita, Andrea e Duccio stanno facendo rivivere e ci offrono con simpatia e generosità.
Ornella Massa: https://www.facebook.com/ornella.massa.372


The Subway: solo qui si chiama così, mai chiamarla Metro…
Amo viaggiare e neppure dopo tanti viaggi ho perso la capacità di stupirmi davanti alle cose che vedo; nulla è mai ovvio né scontato, neanche le cose che già conosco o i luoghi che ho già visitato. Ogni volta è una scoperta perché nel frattempo sono io stesso ad essere cambiato.
La metropolitana di New York non fa eccezione a tutto questo, è un vero viaggio nel viaggio, una sorpresa ogni giorno perché quasi sempre è nuova la gente che vi si incontra.
Già… Ho scritto quasi perchè in realtà ci sono alcune figure che sembrano loro stesse far parte di quelle gallerie e appartenere ai lunghi condotti che conducono nelle viscere rocciose del sottosuolo di Manhattan, quasi fossero elementi di arredo progettati insieme alla stazione.

È il caso dell’uomo che distribuisce le copie gratuite di “Metro”, il free magazine che conosciamo anche in Italia: la sua vita professionale inizia al mattino alle 6 quando comincia ad urlare una specie di litania che dura fino alle 9, allorché le copie del giornale sono esaurite e lui sparisce insieme a loro dileguandosi senza riapparire fino al mattino successivo, e così per anni, per sempre… Puoi ritornare e ritrovarlo lì: stazione 34 linea BDFM.
Se invece ti trovi a frequentare la Grand Central Station, nei suoi infiniti corridoi sotterranei, ed esattamente dove c’è il passaggio comunicante con lo “Shuttle” per Times Square, lì trovi puntualmente la musica Country suonata dalla classica famiglia allargata che esegue questo genere: tre fratelli, due di questi con relative mogli che suonano la chitarra, il basso e la batteria e cantano, vestiti con camicie a quadroni, gonne a fiori e ciabatte. Cantano storie di vita rurale della gente del Sud.

Ma non ci sono solo gli habitué, nella Subway puoi trovare ogni genere di artisti di strada, alcuni di loro sono dei veri professionisti e hanno uno speciale patentino che li abilita ad esibirsi: li trovi sui treni ma possono essere dovunque, puoi vederli in un in una stazione di periferia e il giorno dopo sentirli cantare a Broadway.
Non è un modo di dire, se cerchi su YouTube “U2 underground Times Square” vedrai che anche loro, gli U2 di Bono Vox, quelli veri, si sono esibiti in un concerto gratuito e non programmato tra i corridoi della piazza più famosa del mondo…

Ti imbatterai in burattinai e suonatori di fisarmonica, in ballerini-acrobati che fanno ogni genere di movimenti spericolati afferrandosi a pali ed a sostegni per le mani, li vedrai esibirsi in spettacoli di alto livello. Naturalmente non manca il disperato, quello che prova a fare qualcosa, che non sa cantare, né suonare né ballare, quello che cerca di attirare l’attenzione parlando di sua madre tossicodipendente e del padre ucciso. Lui in genere non cerca di impaurirti, ma solo di farsi dare un dollaro che non riesce a guadagnare in altro modo.

E poi c’è la gente… migliaia di persone in ogni treno, 5 milioni e mezzo di persone al giorno e quasi due miliardi l’anno! C’è il mondo intorno a te. Ricordo le scene del film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders, in cui un angelo era in grado di ascoltare i pensieri delle persone sulla metropolitana e capirne le infinite storie di vita.
Ecco… quando sono sulla metropolitana di New York le guardo e a volte le fotografo, ma sempre le ascolto, anche nei loro infiniti silenzi.
I loro corpi parlano al posto delle parole: il linguaggio dei gesti, la postura, l’abbigliamento e… Mi piace osservare la gente e immaginarne le storie, proprio come nel film… È bello guardare le ragazze bellissime, altissime. Le vedi dirigersi a Chelsea, dove ci sono le Agenzie di modelle… le immagini andare a fare un casting, potresti magari ritrovarle in un manifesto pubblicitario al rientro in Italia…

Puoi vedere ovunque il classico top manager nel suo nuovo look, che ha sostituito la vecchia 24 ore con una borsa nera per il computer, oppure che indossa il cappotto con lo zaino sulle spalle… Mi domandavo perchè ne vedessi tanti in questo look… Allora ho iniziato a osservare i dettagli di ciò che indossavano, cercavo di indovinare che cosa potessero avere nello zaino… Alla fine l’ho capito: vanno al lavoro la mattina portandosi l’abbigliamento per allenarsi dopo l’ufficio.
Finito l’orario di lavoro indossano le scarpe e la tenuta da running, cose che avevano nello zaino la mattina, mettono il cappotto e il resto nello zaino e tornano a casa facendo anche 15-20 chilometri di corsa, allenamento del tutto normale per la preparazione della più classica delle Maratone, proprio quella di New York!

Anche la vecchia icona della donna vestita elegantemente in metropolitana e che calza le scarpe da ginnastica portando quelle con i tacchi a spillo nella borsa è ormai passata: le donne hanno sì tacchi vertiginosi, ma piuttosto larghi e certo stanno più comode rispetto a qualche anno fa!
E naturalmente mi diverto ad osservare il colore della pelle, che mi parla della società cosmopolita Newyorkese e che non ha paragoni in nessun’altra città del mondo in termine di numero di etnie.
Un’altra cosa che mi piace fare è allontanarmi da Manhattan, dal centro, dall’ombelico del mondo… Prendo la linea 4 o la 5 e me ne vado nel Bronx dove conosco qualche posticino poco turistico nel quale andare a scoprire la faccia più vera della città. La via del ritorno sulla metropolitana è bellissima perché la scena che vi si ripete sempre è quella di trovarmi come unico bianco circondato da un treno di blacks e qualche portoricano, orientali pochi… sì… quasi tutti neri.
Si muovono a famiglie intere, mamme con due o tre figli oppure gruppi di amici adolescenti… Ma sempre insieme, a gruppi. Ci trovi i rappers, quelli più distinti e le facce tipiche delle donne che vanno a fare le pulizie in qualche ufficio a Wall St. La cosa più bella è osservare lo…. “sbiancamento” del colore medio della pelle dei passeggeri man mano che il treno si avvicina a Manhattan e poi a downtown.
I neri scendono e i bianchi salgono: quel treno unisce il quartiere più povero e quello più ricco della città, è un treno democratico uguale per tutti e che accompagna ciascuno nella propria vita.
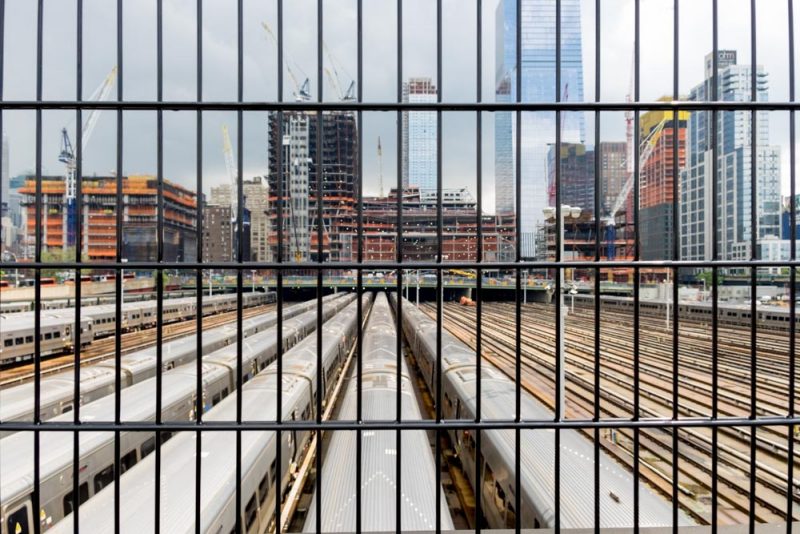
Ma la cosa che mi piace di più della metropolitana di NYC è il suo fascino decadente che non le vieta di essere efficientissima in tutto. Credo che sia la rete più fatiscente che io abbia mai visto in un Paese occidentale, è sporca, decisamente schifosa, gli interni non sono minimamente curati e la manutenzione che viene fatta è solo tecnologica senza nulla di estetico.
Non è raro imbattersi in topi giganti anche in pieno centro, si trovano travi arrugginite e perdite di acqua provenienti non si sa da dove, cartacce e bicchieri di cartone, scatole di pizza e coperte puzzolenti abbandonate dagli stessi clochard per quanto erano inservibili.
Qui si dimenticano i fasti e le decorazioni della metropolitana di Mosca, la modernità e l’arte di quella di Napoli, o la pulizia di quella di Berlino o Dubai. Qui sei vicino all’inferno, anche per il caldo umido che provi tutto l’anno, per il rumore assordante dei treni e dei loro condizionatori. Eppure questa città, senza la sua fetida Subway non sarebbe così bella.

Adoro perdermi nelle stazioni di periferia, quelle più isolate e remote, dove ti trovi da solo ad aspettare un treno o dove scendi e hai l’impressione di essere inseguito di passi silenziosi di un serial killer. Sono quelle stazioni sopraelevate che trovi a Brooklyn, nel Queens, o a Coney Island, dove ti rendi conto di essere nella Little Mosca e dove i negozi hanno le scritte in cirillico! Ne conosco di bellissime: stazioni che passano all’altezza delle basse case a due piani della infinita periferia di New York.
Siamo ad un’ora di metropolitana da Manhattan e siamo ancora nella municipalità di New York. I due capolinea distano tra loro quasi tre ore di viaggio! Da queste stazioni puoi osservare non solo i tetti delle case viaggiando a circa 10 metri di altezza da terra, ma sei abbastanza alto da poter vedere in lontananza tutto lo skyline di Manhattan e i suoi grattacieli che riempiono l’orizzonte. Una vista mozzafiato, uno degli scorci più belli che abbia mai visto della città…

C’è una stazione della linea 7 nella quale potrei stare affacciato per ore alla piccola balaustra al termine del binario che va verso il Queens. Da quel punto mi accorgo di essere sopra la città, sotto di me c’è la strada che brulica di auto, camion e persone, e se alzo lo sguardo dritto davanti a me vedo arrivare i treni che arrancano sui binari in salita.
Sullo sfondo di tutto questo, da lontano, posso osservare l’Empire State Building, il nuovissimo One World Trade Center e il traffico di treni e passeggeri che inconsapevolmente sfilano intorno a me.
E se prendi la linea A, quella blu, in direzione Far Rockaway e superi l’aeroporto JFK dove decine di aerei riempiono il cielo con i loro boati, non fermarti e prosegui ancora, sei nel nulla, ti stai avvicinando al mare. Eccolo: ora ce l’hai davanti, sei sull’Oceano Atlantico!
Intorno a te vedrai i surfisti affrontare le onde come se fossi in California, qui non ci sono grattacieli ma solo ville sul mare e un silenzio assordante rotto solo dal garrito dei gabbiani.
Approfitta per fare una passeggiata e per dimenticare il centro per qualche ora: qui c’è la quiete che non trovi a Manhattan, quando dopo questa gita ritornerai in mezzo alla gente sarà ancora più bello apprezzare il caos!

E poi c’è il ponte di Williamsburg, percorrilo al tramonto sulla linea marrone JMZ, quando il sole tramonta. Affacciandoti sulla destra riuscirai a vedere il Manhattan Bridge e poi in fondo il Ponte di Brooklyn con il sole che tramonta dietro ai grattacieli.
Questi sono i venti secondi più belli del viaggio, non puoi allungarli, non puoi ripeterli e non hai tempo neanche di fare una foto: dura un attimo, ti mozza il fiato, senti un groppo alla gola e in quel preciso momento ti rendi conto che sei davvero a New York!!!

Clicca qui per leggerlo.

380 chilometri, 25 linee, 472 stazioni, sugli stessi binari puoi prendere i treni Local che fermano in tutte le stazioni oppure gli Express che ne saltano tantissime e sono più veloci, ma se sbagli dovrai tornare indietro!
Per orientarti devi sapere che le linee dentro Manhattan sono parallele tra loro e le stazioni hanno il numero della street che tagliano; troverai 4 stazioni con lo stesso numero, su strade diverse e lontane tra loro.
Una jungla di binari, di gallerie, di collegamenti: puoi camminare a piedi per un chilometro solo per cambiare tra due linee che solo apparentemente si incrociano!
Le direzioni da seguire sono sempre e solo due: Uptown and Bronx oppure Queens and Downtown and Brooklyn.

Quando conosciamo una persona (uomo o donna che sia non ha importanza), si puó creare un certo feeling, una sintonia che puó andare avanti o finire, le strade sono infinite, tante quanti gli incontri che possiamo fare.
Ci si guarda, l’aspetto fisico conta, l’occhio deve essere il primo a giudicare, occorre far scattare certe emozioni e queste possono essere delle fortissime reazioni chimiche a catena esplosive oppure possono avvenire con il lavoro costante del tempo, con la conoscenza e la perseveranza.
All’apprezzamento visivo ne segue uno fisico che a sua volta puó dare sensazioni di breve o lunga durata. Ci si puó vedere per una volta o per tutta la vita, dipende dal tipo di reazione emozionale che cerchiamo e da cosa troviamo.
Ci sono persone da amare e persone da sposare. Ecco: dopo aver visto Dubai e New York sento in me questo effetto.

Dubai è la città che ti prende immediatamente, è la perfezione esteriore alla massima potenza, è una attrazione fatale, impossibile non rimanerne affascinati, stregati. Ne hai sentito parlare, sai che è giovane, ricca, bella, elegante e molto, molto passionale, lo capisci dal primo sguardo: è esagerata e perfetta in tutto, al punto da chiederti come mai sia lì a darsi proprio a te e a tanti altri contemporaneamente e con tanta forza. Dubai sa di piacere, sa vestirsi, ha portamento e sa distinguersi, sa dove vuole arrivare, Dubai è di tutti, non sarà mai solo tua. E lo sai, te ne fai una ragione e la ami per quello che è: oggi a te, domani ad un altro, o anche di tutti contemporaneamente.

New York è invece la città matura, indipendente, con una grande personalità, con una sua storia importante fatta di successi e di fallimenti, ha un forte spessore morale che sa affascinarti nonostante sia lì a mostrarti senza vergogna i suoi difetti dei quali sa farsi vanto o sa correggerli. New York è li per te, si concede con generosità a chi sappia accettarne le regole che impone, è per molti ma non per tutti, New York sa stupirti sempre, anche dopo anni e non finisci mai di conoscerla fino in fondo. È spigolosa, dura, difficile da capire, schiva con chi la rifiuta, generosissima di se con chi sappia amarla e accettarla: ogni giorno nuova e diversa, mai uguale a se stessa e sempre in evoluzione. Corre veloce ed è difficile starle dietro: è autonoma, non ha bisogno di te, ma sei tu ad aver bisogno di lei.

Dubai alla fine è un’amante focosissima con la quale vuoi solo godere di meravigliosi istanti senza futuro. New York è una compagna di vita da sposare e con la quale sai di stare bene a lungo.
Con Dubai sai che non c’è storia, non c’è futuro, non c’è rapporto ma è troppo bella per non farla tua almeno per una volta. È una città da vedere, non può mancarti, saprà farsi piacere. È ricchissima ma a buon mercato, adatta a tutte le tasche. Dubai va bene per un rapporto mordi e fuggi con la città.

New York invece te la sposeresti, sai che non ti tradirà mai. Cambierà ma ti piacerà ancora, vuoi invecchiarci insieme e ci torni per vedere come è cambiata e cosa è rimasto, ma sapendo che non sarà l’ultima volta.

A Dubai manca l’anima, manca la gente. Camminando tra le sue strade ti accorgerai di essere sempre da solo, sembra di vivere in un meraviglioso e iper realistico rendering di architettura, nel quale le persone e le auto servono solo a dare le proporzioni degli edifici. Bella senz’anima. Vedila una volta nella vita, godila fino in fondo e ricordala, fotografala, ma non tornarci.

A New York invece la cosa più bella è proprio la gente, sempre diversa, sempre cosmopolita, multiculturale e multietnica. A New York non ti sentirai mai solo, i grattacieli hanno quel fascino intramontabile delle cose antiche, è romantica, ti tiene la mano e con le sue strade parallele ti fa sentire al sicuro e consapevole che non ti perderai, anche se è la prima volta che ci vai.
E allora dove ti consiglio di andare? A te la scelta e ricorda: Dubai per una notte, New York per una vita.

Perchè la Bulgaria? Perchè la Bulgaria è un paese del quale si parla poco, è praticamente sconosciuta al turismo di massa, se ne sa poco a livello sociale e politico e le poche cose che pensiamo di sapere sono dei luoghi comuni privi di fondamento proprio perchè vengono da passaparola privi di conoscenza diretta e di fonti sicure. Anche il nostro immaginario fotografico è praticamente nullo: se cerchiamo di immaginare la Bulgaria il nostro “album dei ricordi” risulta praticamente vuoto.
Per saperne di più e toccare con mano la situazione, siamo andati a visitare questo Paese per fare un sopralluogo per il prossimo Viaggio Fotografico che partirà con un gruppo a luglio.

Partiamo dagli aspetti sociali perchè sono stimolanti anche a livello fotografico. Innanzitutto la Bulgaria non fa parte della zona Euro, e la moneta locale è molto debole per noi, questo significa che la vita costa pochissimo, circa un quarto di quanto costerebbe in Italia lo stesso servizio. Una cena completa al ristorante, birra compresa, costa circa 10,00 Euro, anche meno…

C’è poi il cirillico che aiuta a non comprendere nulla, neanche le scritte sui negozi… E questo, unito al fatto che in pochissimi parlano l’inglese, ci porta a vivere un aspetto del viaggio fatto di incertezze che rendono il viaggio straordinario. Andare in un Paese in cui ti ritrovi a parlare a gesti è sicuramente un privilegio riservato ai pochi fortunati che hanno il piacere di divertirsi in un contesto simile.
Qui si sente ancora fortissimo l’impatto della dominazione del blocco sovietico che ha fortemente influenzato la cultura locale sia negli usi che nei costumi che alla cultura in generale. In strada, guardando come veste la gente, ti rendi conto di quanto tutto questo sia ancora fortemente radicato: le donne con il fazzoletto in testa stile “matrioska”, gli uomini con il giubbotto di pelle e il mocassino in cuoio. Ma non tutto e non tutti sono così, i giovani, infatti, vestono all’occidentale, parlano inglese e hanno un fortissimo desiderio di crescita e apertura verso nuove idee.

Ma la parte che di più ci è piaciuta fotograficamente parlando è la grande spiritualità locale. La religione più praticata qui è la Cristiana Ortodossa e capire questo è un aspetto basilare del nostro Viaggio Fotografico e per capire il senso del vivere di queste persone.
Le chiese sono meravigliose: grandi e monumentali, oppure piccole e raccolte, sono sempre stracariche di affreschi dorati di pregio. La gente va in chiesa per pregare: ci siamo soffermati a vedere i loro movimenti, pochi minuti sono sufficienti per accendere una candela, dire una preghiera, riempirsi gli occhi di icone sacre e ricominciare la giornata. A differenza di altre religioni, qui si va in chiesa a qualsiasi ora e in tutti i giorni della settimana. Lo vedi da quelli che entrano in chiesa con le buste di verdura fresca appena comprata al mercato e passano a pregare prima di andare a casa a cucinare il pranzo. Lo vedi dalla chi entra frettolosamente, “compra” una preghiera, una sorta di “indulgenza” di intenzione per i propri cari o per se stessi, e vedi che entrano con il loro foglietto, lo depositano sull’altare dedicato al santo preferito e vanno via pochi istanti dopo. Le preghiere si comprano lasciando un’offerta in una edicola posta vicino all’ingresso, anche questo è un aspetto interessantissimo da fotografare.

Parliamo di fotografia applicata ai dipinti nelle chiese? Si, leggi qui di seguito… Le icone dei santi sono coloratissime e ricoperte di oro che viene usato come campitura cromatica per le aureole, per rifinire i dettagli dei vestiti dei santi, o per disegnare preziosi sfondi. Il gesto ieratico benedicente o il dito che ammonisce completano ed enfatizzano la forza del santo che viene sempre presentato al centro dell’immagine, e non potrebbe che essere così. Non dimentichiamoci, infatti, che il soggetto posto sui “terzi” seguendo le proporzioni della Sezione Aurea acquisisce dinamismo, ma il soggetto al centro enfatizza il concetto di equità, giustizia, divino, ed eterno. La centralità quindi appare come una scelta obbligata in un tale contesto artistico. L’arte sacra italiana, infatti, ha scene di grande dinamismo in cui i santi sono attivi nel proteggere il popolo, nell’uccidere un drago, nel subire un martirio, nell’essere elevati in cielo e nel realizzare miracoli, nell’arte bizantina i personaggi vengono rappresentati solo nella loro magnificienza. Da noi viene usata la sezione aurea, in Bulgaria e nel mondo ortodosso la prospettiva centrale.

Entrare in un monastero da queste parti vuol dire essere fisicamente presenti su un set fotografico di street photography ambientato in un luogo sacro. La gente che prega, i gesti delle mani che accendono le candele e quelle del sacerdote anziano che fa il gire per andare a spegnerle, il tutto condito da meravigliosi tagli di luce che si insinuano all’interno di chiese buie creando dei contrasti che opportunamente sfruttati sono uno stimolo fortissimo per chi ami questo genere di fotografia. Se cercassimo di ricostruire queste luci, e queste situazioni di ripresa, sarebbe una impresa praticamente impossibile per noi amanti del reportage, sempre abituati a viaggiare leggeri, dobbiamo coglierle sul momento!

La spiritualità però ha sempre degli aspetti umani e anche commerciali che si mescolano ad essa: nei monasteri non mancano i negozietti in cui comprare non solo immagini sacre, ma anche prodotti tipici dell’artigianato locale, giocattoli per intrattenere i bambini che accompagnano i nonni in chiesa, ci sono i ristorantini che con i loro fumi e profumi saturano l’aria delle stradine di accesso e in uno di questi ho trovato, a 10 metri dalla chiesa, accanto ai calendari sacri il manifesto di una birra che veniva pubblicizzata da 6 ragazze a seno nudo!

Che si sia credenti o no, in questi luoghi si sente comunque una grande spiritualità fatta di silenzi profondi, di voci sussurrate, di passi che echeggiano tra i corridoi, di sacerdoti dalle lunghe barbe bianche che benedicono i fedeli. Anche se tutto questo è intangibile e invisibile, raccontarlo in fotografia è possibile, basta prendersi, come facciamo noi quando siamo in viaggio, tutto il tempo necessario per vivere il luogo, comprenderne il senso e lasciarsi prendere dalla bellezza di ciò che sapremo tramutare in immagini fotografiche. Al dilà della bellezza dei luoghi, occorre darsi il tempo per viverli e quindi fotografarli: ed è proprio quello che facciamo noi. Il normale tour turistico tende a segnare con uno scatto i luoghi visitati e a vederne il più possibile, noi, invece, in un Viaggio Fotografico, facciamo della lentezza la nostra forza, preferiamo di gran lunga soffermarci in un posto per ascoltarne le storie e raccontarle con le nostre immagini, ci diamo il tempo di vedere, scoprire e approfondire cose, eventi e persone per rendere completo il senso della storia che abbiamo davanti.
Se ti piace tutto questo, inizia ad organizzarti per venire con noi dal 1 all’8 luglio 2017 in un Viaggio Fotografico indimenticabile. ISCRIVITI QUI.


Sognare di fare un viaggio speciale è una cosa normale, succede a molti e le Aurore Boreali sapranno farti sognare….
Spesso i viaggi sono la realizzazione di un sogno a volte iniziato anni prima, ma pochi viaggi ti fanno sognare mentre li stai facendo, come è successo a me quando ho avuto il mioy primo “appuntamento al buio” con la Dama Sfuggente… Eh già… Ho aspettato quel giorno con l’ansia di un adolescente brufoloso senza sapere se si sarebbe davvero presentata… E l’aspettativa, il risultato incerto dell’incontro, sono quella sana iniezione di adrenalina che ti fa vivere il piacere dell’attesa e godere il momento e ti spingono a partire per questa avventura a 23 gradi sotto zero.
Le Aurore Boreali si possono osservare al di sopra del Circolo Polare Artico, ossia veramente in poche zone abitate del Pianeta che si trovano all’estremo nord della Penisola scandinava, in Islanda, in Siberia e in Alaska. Essendo un fenomeno magnetico che si manifesta come una debole luce verde fluttuante nel cielo, le Aurore si vedono facilmente ad occhio nudo ma solo nel buio profondo delle lunghe notti invernali poichè durante i mesi estivi la loro luce viene sovrastata dal sole di mezzanotte e possono “vederle” solo gli scienziati con appositi strumenti.

Già il viaggio per arrivare è tutt’altro che semplice: ci vogliono 2 o 3 voli (dipende dai giorni e dalle compagnie) da Roma per arrivare fino al più vicino aeroporto che si presenta con la pista completamente innevata e sulla quale atterrano gli aerei di linea misteriosamente senza sbandare. Siamo a Kiruna, da qui si prosegue via terra in un enorme, infinito “deserto” di neve bianca, fino ad arrivare ad un avamposto nel nulla dove si trova qualcosa che, più che una vera stazione, è la casetta del Capostazione dalla quale lui stesso ferma i treni che passano. Niente bar, niente sala di attesa, nessuna biglietteria, nessuno scambio, qui c’è solo il semaforo per fermare i treni. Ecco, siamo arrivati ad Abisko: Svezia del nord.
Intorno a noi solo neve in una pianura a perdita d’occhio. Attraversiamo i binari (perchè naturalmente non c’è neanche il sottopassaggio) e al di là della strada troviamo il nostro Residence con i cottage a 4 posti che avevamo prenotato. Il supermercato più vicino si raggiunge comodamente in circa 2 chilometri e mezzo da fare a piedi da fare sia all’andata che al ritorno. Ovviamente eravamo partiti dall’Italia con sufficienti scorte di cibo per quei giorni, ma comunque qualcosa siamo andati a comprarla caricandola negli zaini al ritorno.
I cottage sono a qualche centinaio di metri dal lago di Abisko che in questo periodo dell’anno (primissimi giorni di marzo) è coperto da uno strato di ghiaccio spesso 140 centimetri tanto che su di esso ci possono tranquillamente camminare i camion invece che girarci intorno con la strada risparmiandosi un pò di benzina nei mesi invernali.

Ho visto una decina di deserti in tutto il mondo e sono tutti bellissimi ma si assomigliano tra loro, qui siamo in un posto che di certo non è abitato, ma che proprio deserto non è! Qui ci sono le strade, la ferrovia, linee elettriche e WIFI, copertura telefonica e acqua abbondante, ma mancano le persone e non puoi non chiederti perchè tutto questo sia lì e a favore di chi se non di quei pochi turisti in grado di essere ospitati nell’unica struttura della zona.
Bene: siamo arrivati… Dobbiamo iniziare a fare i conti con l’ambiente in cui ci troviamo. La prima cosa da fare è noleggiare i tutoni artici con i quali resistere alle gelide temperature che altrimenti sarebbero insopportabili e pericolose anche con un abbigliamento invernale pesante da sci. I tutoni si indossano sopra ai giubbotti invernali e hanno a corredo anche gli stivaloni da neve, un bel cappello a passamontagna, guantoni a moffola con le dita unite per stare più caldi et voilà: gonfi gonfi siamo pronti per arrivare a qualsiasi temperatura, da queste parti si arriva tranquillamente a 20-30 gradi sotto zero.
L’eccitazione è fortissima e aumenta ogni istante perchè la giornata è coperta, non promette nulla di buono: una volta qui, tutti vorremmo vedere e fotografare l’incantesimo della danza della Dama Sfuggente, ma per vederla ci vuole la presenza contemporanea di due fattori: la presenza del fenomeno che non è garantita, e il cielo sgombro dalle nuvole; e, dato che siamo a queste latitudini, la presenza di nuvole è tutt’altro che remota… Inganniamo il tempo e ci godiamo comunque le 11 ore di luce che ci sono in questo periodo, non sono poche, e impiegandole bene renderanno comunque questo viaggio indimenticabile. Per scaramanzia cerchiamo di non pensare alla delusione che potremmo avere se non riuscissimo a vedere le sognate Aurore Boreali e quindi impegniamo il tempo a fare uscite fotografiche durante il giorno in attesa della notte.

A seconda di dove si va a vedere la Aurore Boreali, le attività da fare durante il giorno sono svariate e sono tutte molto legate al territorio, alla sua conformazione e al clima. In Svezia grazie alle pianure che abbiamo intorno possiamo provare l’ebbrezza di guidare le slitte trainate dai cani! Ci sono degli allevamenti ben organizzati che fanno fare queste escursioni, i più grandi dispongono anche di 20 slitte, ciascuna trainata da 8 husky felici di correre in mezzo alla neve del Parco Nazionale di Abisko.
Un breve training iniziale con l’Istruttore che ci spiega come guidare, come frenare e come girare e soprattutto cosa fare in caso di caduta perchè i cani continueranno a correre con la slitta anche senza di noi…
L’escursione dura in tutto 4 ore ed è un tour pazzesco nella natura, tra alberi carichi di neve, piccoli avvallamenti e salitelle in cui aiutare i cani a tirare la slitta… La cosa che può sconvolgerti da queste parti è il silenzio profondo e quasi sacro che ti avvolge fino a farti perdere l’equilibrio. Non ci sono rumori, non ci sono voci, non ci sono auto. Solo il silenzio della neve.

Un’altra cosa divertentissima che si può fare nel grande nord è guidare una motoslitta. Basta avere la normale patente per auto e se ne può noleggiare una per guidarla in mezzo alla neve raggiungendo anche velocità elevate.
Noi le abbiamo prese da Kiruna in Svezia per raggiungere l’ICE Hotel, un vero e proprio albergo interamente realizzato in ghiaccio che viene costruito ogni anno ripartendo da zero.
Tra ottobre e dicembre vengono costruite le camere, la hall, il bar e persino la cappella, tutto fatto con neve e ghiaccio.
Grazie al lavoro ininterrotto di macchine e operai, in poche settimane viene creato un hotel di charme da 1000 Euro a notte. Qui potrai dormire su un letto di ghiaccio coperto da una pelle di foca e in una stanza arredata con lampadari e sculture realizzati da artisti specializzati.
L’albergo rimane aperto all’incirca da Natale fino a metà aprile quando arriva la primavera e la struttura inizia a sciogliersi inesorabilmente sotto i primi timidi raggi di sole…
E poi scende la notte e ci si prepara per l’incontro più importante del viaggio: l’appuntamento con le Aurore Boreali che speriamo facciano la loro apparizione danzando nel cielo con i suoi leggiadri veli verdi.
Il motivo per il quale l’Aurora viene chiamata Dama Sfuggente è proprio il rischio che pur essendo il periodo adatto, non si presenti davanti a noi. Dopo cena si esce per andare a fotografarla nel migliore dei modi. E’ praticamente inutile arrivare fino a qui senza fare foto per portarsi a casa un ricordo tangibile di questa esperienza indimenticabile. E allora ben coperti usciamo armati di fotocamere, obiettivi e cavalletti pronti a scattare le foto più emozionanti della nostra vita.
Se pensi di andarci anche tu, segui il mio consiglio e non dimenticartene: tieni sempre le batterie della fotocamera nelle tasche interne del giubbotto, perchè a quelle temperature in pochissimi minuti si scaricano completamente lasciandoti senza energia al momento dello scatto!!!
Un errore che non ti perdoneresti mai. Le giornate servono anche per fare dei sopralluoghi in cui scattare ricordandoci sempre che le aurore si manifestano seguendo una direzione da nord verso sud, quindi la sera sappiamo già dove posizionarci per fotografare, prepariamo tutto e appena si manifesterà l’aurora, basterà inserire la batteria e scattare.
L’attesa può durare ore, occorre aspettare che il cielo sia sgombero da nuvole e sperare che in quel momento il fenomeno sia visibile. E dopo due notti con una pericolosa tempesta di neve che ci ha costretti a desistere ecco che…. SIIII!!!!!! In pochi istanti il cielo si carica di una incredibile, meravigliosa, indimenticabile luce verde che inizia a fluttuare con leggerezza lasciandoci dapprima incantati e subito dopo ci fa sentire una euforia incontenibile che si manifesta con urla e isteria di massa e qualche lacrima si ghiaccia sul viso delle persone più sensibili. Non stupirti: queste reazioni sono del tutto normali quando assisti ad un fenomeno del genere.
 Il nostro sogno si è avverato mentre eravamo con gli occhi aperti davanti all’incanto della natura.
Il nostro sogno si è avverato mentre eravamo con gli occhi aperti davanti all’incanto della natura.
Buon viaggio e buona luce
Leggi l’articolo di Roberto Gabriele pubblicato sul numero di febbraio 2017 della Rivista Acqua & Sapone a pagina 96.


Da qualche parte in Madagascar, nell’estate del 2008, ho assistito al rito della Famadihana.
Nel nord del Madagascar, nella piccola zona che si estende dalla Capitale Antananarivo fino ad Antsirabe, nelle campagne è ancora in vigore la Famadihana: un rituale di riesumazione dei morti dalle tombe di famiglia, le tradizioni legate al culto dei morti sono molto importanti e sentite e in ogni zona dell’isola si celebra in modo diverso la perdita dei propri cari.
Spostandosi verso l’estremo sud, invece, questa usanza è quasi del tutto sconosciuta: da quelle parti vengono costruite tombe enormi con muretti lunghi circa 10 metri di lato e alti circa un metro e venti. Le tombe del sud vengono decorate con dipinti che ricordano la vita del defunto nelle sue passioni e nei suoi interessi. Una specie di fumetto, un fotoromanzo che raccontano il lavoro, la famiglia o le sue attività. Le tombe vengono adornate con oggetti che erano del defunto o con simbologie varie realizzate su totem piantati nel terreno.

La Famadihana del nord, invece, è un rituale che viene fatto dopo sette anni dalla morte del congiunto (e solo nel periodo fra luglio e settembre), la famiglia organizza una grande festa in onore del defunto che viene riesumato dal suo sepolcro e portato in processione dalla folla gioiosa che canta e balla accompagnata da intere bande musicali.
Io andai a fotografare questo rituale nel 2008 durante uno dei miei viaggi, riuscii ad organizzarmi con un autista che mi portò in giro per tutta la giornata, partenza al mattino prestissimo e dopo 4 ore di auto arrivai nella zona il cui è possibile vedere il rito. Il problema era che non è così scontato trovare la festa, non si tratta di un evento che viene celebrato in un giorno fisso ogni anno, può essere in qualsiasi giorno e ci vuole un pò di fortuna per trovarne una quando si è in giro a cercarla.

La festa della Famadihana ha inizio già al primo mattino, la casa dei parenti viene trasformata in un ristorante dove decine o centinaia di persone prenderanno parte al pranzo di festeggiamento che si svolge in giardino per ovvi motivi di spazio. Tutto si svolge nella massima allegria, la gioia gli deriva dalla possibilità unica (direi dal privilegio) di poter riabbracciare, seppur per poche ore, il corpo del loro caro estinto.
Passai una giornata intera con la famiglia del defunto, mi presentai con il mio autista che mi faceva anche da interprete e che chiese ai padroni di casa se io potessi assistere e fotografare tutto il rito. Furono onorati della mia presenza, e fui ammesso senza esitazioni ad un evento così privato nonostante fossi uno sconosciuto. Non mi chiesero nulla, per partecipare e mi fu veramente difficile una volta entrato fargli accettare le due bottiglie di rum che gli avevo portato in omaggio per ricambiare l’ospitalità. Le portai come regalia per ingraziarmeli e invece loro non volevano neanche accettarla: un ospite che sia ben accetto non paga, un ospite non gradito non entra! Alla fine accettarono.
Il pranzo è abbondante, viene convocata persino la banda musicale del paese che accompagnerà con le sue note tutta la giornata della Famadihana. Più la famiglia è ricca, tanto più sarà grande la formazione dei musicisti. Il pranzo prevede maiale bollito con le patate che è rituale per questa circostanza. Si festeggia e le porzioni in questi casi sono sempre generose. Durante il pranzo c’è la banda musicale che allieta gli ospiti, i musicisti sono in numero proporzionale alla disponibilità economica della famiglia e suonano musiche allegre con gente che balla.
Dopo il pranzo vengono raccolte le offerte per pagare parte delle spese cui la famiglia va incontro in quella giornata. Più o meno succede la stessa cosa che si fa dalle nostre parti in Italia con le buste ai matrimoni.

Dopo aver raccolto le offerte, si parte insieme per raggiungere a suon di musica la tomba di famiglia che può essere lontana anche qualche chilometro. Alla tomba arrivano altri ospiti, centinaia, anche un migliaio di persone da tutta la valle si riuniscono per festeggiare. Qualcuno porta un tavolino che verrà trasformato in un punto di ristoro in cui comprare qualche bibita o qualcosa da mangiare. E’ impressionante vedere questi fiumi di persone che si dirigono tutti insieme verso lo stesso punto: camminano a piedi, portano le bandiere del Madagascar e festeggiano sui prati. La Famadihana è una festa per tutti, non solo per la famiglia.

Camminando tra la folla ti rendi conto di essere in Africa, di essere diverso, unico bianco in mezzo ad una moltitudine di persone. Capisci un pò cosa può significare per uno di loro venire in Italia, da solo, spaesato, senza parlare la lingua e senza conoscere le nostre tradizioni. L’unica differenza è che io in mezzo a quelle persone con la faccia nera mi sentivo accolto, ero amico di tutti, la gente mi salutava e mi faceva sentire importante proprio perchè diverso da loro, perchè ero andato lì per conoscerli e non per invaderli.
Questo non è esattamente lo stesso trattamento che noi Italiani riserviamo ad uno straniero che venga da noi: di certo non lo facciamo sentire a casa sua, non lo salutiamo, non ci importa di ascoltare la sua storia e non vogliamo neanche che si avvicini troppo a noi. Ne segue che ero solo io in mezzo a loro, e mi rendevo conto di tutto questo. Sentivo forti gli odori della gente, dell’erba, degli animali intorno a me, sentivo il caldo umido e opprimente dell’inverno malgascio e immagino cosa può essere stare lì in estate…

Arriva poi il momento in cui il corpo viene estratto dal sepolcro e portato in processione a danzare con la folla, in particolare con la famiglia. E’ un momento molto forte, molto sentito: la gioia viene comprensibilmente rotta per la prima volta dal pianto: un pianto di commozione, di nostalgia e di gratitudine per la possibilità di riabbracciare le ossa del proprio parente.
Qui diventa tutto difficile, fotografare è quasi impossibile, non mi viene chiesto di fermarmi, ma in quel momento capisco io stesso che si impone il rispetto.
Infine, quando viene rinnovato il sudario in cui è avvolto il corpo c’è un intenso momento di emozione e di preghiera in cui le famiglie si stringono con forza e sincera solidarietà. Poi la Famadihana termina con la rideposizione del corpo all’interno della tomba dalla quale non verrà mai più estratto.

Una donna malgascia durante la Famadihana. Foto: © Roberto Gabriele

La decisione del Viaggio Fotografico a Tokyo l’ho presa in cinque minuti circa, sposava perfettamente le mie richieste di andare dalla parte opposta del pianeta e immergermi in una cultura lontana. Il programma di viaggio fotografico mi soddisfaceva in pieno , una settimana intera per cercare di raccontare quello che avrei visto per le strade della capitale nipponica.
I due mesi precedenti la partenza li ho passati vedendo qualche foto di qualche streeter giapponese, qualche film e leggendo qualcosa sui vari forum fotografici. La distanza che separa Roma da Tokyo corrisponde a circa 13 ore di volo, ma una volta che ti immergi nella capitale ti accorgi che questa distanza è molto più ampia.



Appena entri a Tokyo ti sorprendono due cose, una è il silenzio nonostante il traffico infernale, la seconda è la mancanza di indicazioni in inglese. Ti senti subito perso, fai fatica a chiedere informazioni perchè pochissime persone comunicano con la lingua più parlata nel mondo, sembri proiettato in un’altra dimensione.
In ogni luogo si respira una ricerca incessante della perfezione e dell’ordine e il collettivo sembra sovrastare il singolo che lentamente sparisce. Prendendo spunto da tutti questi contrasti si è materializzato il mio progetto fotografico.


Con il passare dei giorni vedevo che le persone erano sempre più distanti, c’era una sorta di barriera, ognuno andava per la propria strada e anche quando venivano fermate per la richiesta di informazioni sembrava recitassero un copione già scritto, senza andare mai oltre il dovuto.

Il mio portfolio si è sviluppato inizialmente con l’utilizzo di ombre e neri fortemente contrastati per poi passare alle silhouette, perchè la silhouette è l’estremizzazione delle ombre in quanto ne cancella tutti i dettagli e la riduce ad una semplice sagoma. Quest’ultima non svela il contenuto, permette di spaziare con la mente e la fantasia nel tentativo di immaginare chi, in realtà, dietro quella sagoma si nasconda. Il giapponese ai miei occhi è apparso così, una persona che lentamente spariva dal mio campo visivo e riuscivo a intravederne solo il profilo.



Non è stato facile sviluppare questo progetto perchè dovevo sfruttare al massimo i tagli di luce del mattino o il tardo pomeriggio. A mio parere questa tecnica è il miglior modo di rappresentare un Paese che non sembra ancora pronto a far convivere una mentalità legatissima alle tradizioni del passato con le moderne tecnologie.
Foto e parole di Luigi Chighine

Cuba……. eccola! Fin da quando metti piede sull’isola ti ammalia, ti conquista e ti rapisce manifestandosi in tutto il suo splendore! E’ una miscela di odori che ti assale, odori che sanno di salsedine, di carburante, di umidità e muffe, di fragranze indefinite.


Entriamo in contatto con la realtà locale, con la sua gente e scopriamo un popolo che ha sofferto, che soffre, ma che non ha perso il suo sorriso. Il sorriso e la danza in questi giorni sono stati messi in un cassetto per la malinconia ed il senso di perdita che pervade l’isola. Il Líder Máximo non c’è più, ma la sua presenza è ovunque. Il Paese celebra e piange Fidel. Tutto ha assunto un tono sussurrato. Il momento storico che stiamo vivendo è unico, tutto è pervaso da un senso di tristezza composta. Mi meraviglia e sorprende quanto amore, nonostante tutto, il popolo cubano manifesta nei confronti di un dittatore che ha procurato loro ristrettezze sotto diversi aspetti. Ma la risposta forse è sintetizzata da Silvia, afrocubana, che ci accoglie all’aeroporto: “è stato un uomo che ha consentito agli esclusi di poter lavorare, studiare, curarsi”. I cubani hanno lottato per una Rivoluzione che ha smarrito gli obiettivi iniziali, che ha infranto i loro sogni, ma nonostante tutto ammirano e amano questo “condottiero” che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Ha trasmesso loro un orgoglio nazionale che si ritrova in ogni aspetto della loro vita e che non è affatto appoggio integrale alle politiche della Cuba rivoluzionaria, e tuttavia è conseguenza di un grandissimo rispetto per chi ha cambiato la storia di un Paese.

Questo orgoglio lo si riconosce anche nella loro musica, che condisce ogni momento della loro vita sia come forma di canto che di esecuzione strumentale che di ballo, permea le giornate che i cubani affrontano con uno spirito estremamente positivo. Ai loro problemi contrappongono il loro approccio alla vita. La miseria e la serenità si confondono e si integrano. Il grigio dei loro giorni è compensato dal colore e dal calore con il quale li abbelliscono danzando non appena sentono una nota musicale. Eccoli che suonano e ballano in strada appena termina il proclamato lutto nazionale e la vita riprende con il consueto ritmo.

Trovi la gente in fila con la libreta del razionamento alimentare e acquistano beni di prima necessità pagando in CUP, moneta utilizzata solo dai cubani. E’ infatti tuttora in vigore il sistema della doppia moneta che nel corso degli anni ha prodotto alcuni effetti negativi, creando due “mercati paralleli”, con un conseguente senso di esclusione economica di una fascia della popolazione cubana, ed una disparità di ricchezza tra coloro che sono pagati in CUP e coloro che invece hanno accesso ai CUC o ai dollari, monete derivanti soprattutto dal settore turistico.

Della gente colpisce la loro generosità e cultura. Non ti possono donare nulla ma donano loro stessi con le loro storie, aprono le loro case ed il loro cuore offrendosi a noi sconosciuti con spontaneità e senza riserve o pregiudizi. Le loro case, così variopinte, con le porte e le finestre perennemente aperte sulla strada, consentono ai passanti di condividere la quotidianità di coloro che le abitano.

Le città sono magnetiche, piene di contraddizioni delle quali ti innamori in modo viscerale e irrazionale. Ne percepisci tutto lo splendore che devono avere avuto in passato e che, in modo fatiscente, ancora emanano attraverso i loro gioielli architettonici che si mescolano qua e là a edifici di una decadenza scenografica, scoloriti dagli anni, dalla salsedine, dal sole e dalle intemperie.

Le coloratissime auto americane degli Anni ’50 Chevrolet, Cadillac, Pontiac e simili sfrecciano ogni giorno per le strade appestandole con i loro gas di scarico. Restano tuttavia dei cimeli che si fanno perdonare l’inquinamento che producono poiché creano un contesto da cartolina che è davvero unico!
Nonostante tanti anni di trascuratezza quasi totale, come riesca questo paese ad essere così straordinariamente bello è un fatto che sfugge a ogni logica, ma basta lasciare andare il cuore e farselo catturare!

Maria Bonetto – Roma
Facebook: https://www.facebook.com/maria.bonetto.779







Siamo arrivati a L’Avana la sera del 30 novembre. Tre giorni prima era morto Fidel Castro, controverso ed indiscusso protagonista della storia contemporanea del Paese.
Quando ho appreso della sua morte ho subito pensato che avremmo avuto una grande opportunità: essere a Cuba in un momento storico, di passaggio verso un futuro di forti cambiamenti ancora incerti ma spero non devastanti.
Non ero ancora mai stata a Cuba. Ero curiosa di parlare con la gente e respirare l’atmosfera di quei giorni di lutto in cui tutto il paese si sarebbe fermato.
Il pomeriggio del 30 novembre è partito da L’Avana il corteo con le ceneri di Fidel verso Santiago, quando siamo arrivati noi era già tutto lontano.
Il giorno dopo, L’Avana era una città fantasma, un caldo umido pesantissimo, e la pioggia che ha reso l’atmosfera ancora più grigia e triste. Così ci accolti il paese della musica e del sole.
Ovunque c’erano bandiere a mezz’asta, immagini commemorative di Fidel e del suo 90° anniversario di vita, scritte rievocative del 26 luglio 1953, in ricordo dell’attacco alla caserma Moncada a Santiago di Cuba, uno degli episodi più importanti della Rivoluzione cubana, a cui è stato ispirato il Movimiento 26 de Julio.

In quei giorni precedenti il funerale del 4 dicembre, e quindi la fine del lutto, c’era uno strano silenzio interrotto solo dal rumore delle poche bellissime e decadenti macchine d’epoca, che sono ancora le protagoniste indiscusse delle strade cubane.

Il sole era tornato, ma rimanevano le bandiere abbassate a mezz’asta, e soprattutto il divieto assoluto di bere e servire alcolici e di ascoltare qualsiasi tipo di musica.
Era stata vietata l’anima di Cuba a Cuba.
Solo in alcuni ristoranti turistici, con le cameriere vestite da Babbo Natale, servivano qualche cocktail a base di rhum, ma mai birra, perché, dicevano, la birra si vede da lontano.
Abbiamo approfittato per parlare con la gente, capire cosa pensano di quel che è stato Fidel per il loro popolo, quanto quel silenzio obbligato fosse vissuto come una costrizione o come un lutto vero e sentito.
A L’Avana alcuni proprietari delle case che ci ospitavano erano poco interessati alla storia e al passato di Cuba… pensavano di più al loro futuro in un turismo che ormai sta diventando di massa.

Ma usciti dalla città, tra i coltivatori di tabacco e canna da zucchero, spesso plurilaureati, il sentimento condiviso è di grande rispetto e devozione nel Lidèr Maximo che ha dato ai cubani istruzione e sanità gratuita per tutti e li ha liberati dalla dittatura fascista e corrotta di Batista.

Sono queste quindi le due anime di Cuba in questo momento di passaggio e cambiamento: quella ancora nostalgica, e certa che Raùl Castro continui sulla linea politica del fratello, e quella che si sta già affacciando al nuovo mondo del turismo, in modo spesso troppo disorganizzato ed approssimativo.
Le casas particulares sono ora autorizzate dal governo, e chi ha modo, non perde l’occasione di trasformare la sua casa in un alloggio per turisti, il porto di L’Avana si è trasformato in un parcheggio per navi da crociera e i pullman turistici da 50 posti sono ormai ovunque…
Rimane però la doppia moneta, il pesos cubano che vale pochissimo (il CUP, 1/24 di €) con cui possono comprare prodotti di prima necessità in botteghe apposite con scaffali prevalentemente vuoti, tutto razionato e controllato, ed il Pesos Convertibile (il CUC, con cambio 1/1 con l’euro), utilizzato dai turisti, che al nero entra nelle mani degli operatori turistici a qualsiasi livello e che crea grosse disparità nella popolazione.

Questa è la Cuba che io ho vissuto io oggi, in un momento importante per il suo futuro, sperando non venga trasformata in una macchina per investimenti ma che riesca a mantenere la sua forza ed unicità.
Cosa succederà non lo sappiamo, ma già si vedono tante bandiere americane nelle strade e dentro le case, e tanti sono i cubani che con i colori della bandiera USA hanno trasformato il loro abbigliamento…
Che sia un bene o un male sarà solo la storia a dirlo…


Scrivo questo pezzo mentre mi trovo ancora in diretta dalla Bulgaria. Stavolta sono solo, in vacanza, con me c’è solo Simona, niente Gruppi da accompagnare, un viaggio di coppia con lo zaino in spalla! Un Capogruppo che si rispetti, per riposarsi tra un viaggio e l’altro… Per vacanza fa un altro viaggio!

Ed eccomi che siamo qui a viaggiare in un Paese vicino alla nostra Italia, a 2 ore di volo da Roma, eppure così diverso. La prima impressione è quella di trovarsi in un posto che ha subito moltissimo l’influenza sovietica per diversi decenni che ne ha modificato l’architettura, il look della gente e lo stile di vita.

Il cirillico innanzitutto è la prima cosa che noti quando sei qui: ti da subito quell’immagine austera che ti aspettavi di trovare. Il cirillico ti porta in un attimo ben oltre la cortina di ferro. Assomiglia un pò al nostro alfabeto, un pò a quello greco, un pò ha strani segni a noi ignoti, e spesso alcune lettere che sono identiche alle nostre, hanno suoni completamente diversi. Il problema è quando il menù è scritto SOLO in cirillico e il personale non parla una parola di inglese… Ma anche questo fa parte delle regole del gioco del saper viaggiare in modo “romantico” senza grandi programmi, senza enormi aspettative…

Il bello del viaggiare in questo modo è la sensazione di smarrimento, di vuoto, di scoperta che sei “costretto” a fare ogni minuto mentre sei fuori casa, ogni cosa che ti serve sei costretto a chiederla.
Qui in Bulgaria Internet è diffuso quasi ovunque con WIFI gratis, ma non è un servizio costante e soprattutto non è affidabile in alcuni momenti in cui sembrerebbe indispensabile! Sai benissimo di aver sottoscritto per il tuo telefono anche la tariffa (quasi) free per internet ma, al dilà dei costi del tutto sostenibili, approfitti di questa occasione per rinunciare del tutto a questa ciambella di salvataggio informatico: questo è il tuo viaggio nel tempo, in quella vecchia Europa che ancora esiste e quando internet non è disponibile…. Non andrai a cercarlo, imparerai a farne di nuovo a meno, a parlare con la gente.

Fotografi in vacanza, e allora riscopri un modo diverso di viaggiare, fatto di chiacchiere a gesti con la persone, e scoprirti incapace di interagire se non con mezzi primitivi di comunicazione: indicare, sorridere, disegnare in aria, fare versi degli animali per spiegare che non mangi maiale o che vuoi il pollo o uno spiedino di agnello!!!!

La musica: ne abbiamo sentita tanta nei taxi, nei negozi, negli hotel…. La musica che ascolta la gente da queste parti è completamente ferma agli anni ’80 e non abbiamo sentito un solo brano che fosse più recente di quel periodo. Un fenomeno ci ha invece particolarmente colpiti: a Sofia c’è un locale che si chiama Delta Blues Bar, un angolo perfetto di Mississippi in piena Bulgaria! Una sorpresa per me e Simona che amiamo questo genere, e che lo abbiamo approfondito nel corso di tanti viaggi nel sud degli USA.

Così, parlando con il gestore, scopriamo che a Sofia, non si sa per quale ispirazione, ci sono l’almeno 500 musicisti che fanno blues e questo ha creato un indotto di pubblico che viene in questo locale ad ascoltare Blues suonato live tutte le sere. Anche a Plovdiv c’è un bel festival di musica Jazz molto seguito dal pubblico e visto che siamo capitati in città proprio in quei giorni, ne abbiamo immediatamente approfittato per un paio di concerti in un teatro e in un club…
Per un fotografo la Bulgaria è il luogo ideale per fare Street Photography: le donne, nei quartieri periferici che frequentiamo noi, vanno in giro con acconciature esagerate con capelli cotonati stile anni’60, la vecchina che cammina con le buste in mano e il capo coperto dal tipico fazzoletto copricapo annodato sotto al collo, l’omino secco secco con il giubbottone di similpelle che fuma una sigaretta che puzza di cadavere, i ragazzi vestono spesso con tute simil-Adidas e qualcuno azzarda looks di ispirazione più occidentale….

I mercati come sempre sono una vera miniera di stimoli fotografici, di personaggi da fotografare, di persone da incontrare e merci da scoprire. Un Luv, la moneta locale, corrisponde a circa 2 Euro, solo che i prezzi sono bassissimi, al ristorante mangi una cena di gran lusso comprese bevande a non più di 12-15 Euro a persona.
Viaggiando da queste parti, quello che ti puoi aspettare è il poter fotografare le vecchie automobili della Lada che ancora girano scassate nelle strade, le auto qui servono per muoversi, non sono uno status symbol, per cui le tengono finchè sono in grado di camminare.

La Bulgaria non ha cose “famose” da fotografare, ma è proprio questa la sua bellezza: potrai esprimerti tu al meglio tirando fuori i racconti e le sensazioni dei momenti che vivi. Non ci sono palazzi importanti e a livello di architetture tutto si riduce ad alcune chiese e monasteri che sono meravigliosi ma assolutamente sconosciuti al turismo di massa.
In questi monasteri, al dilà della bellezza del luogo stesso, ti colpiranno di nuovo le persone, la loro spiritualità, il loro rapporto con la preghiera: in queste chiese scoprirai la bellezza della luce che filtra dalle finestre, le atmosfere mistiche dei sacerdoti che celebrano e la gestualità delle mani che accendono le candele…

E l’altra cosa che abbiamo riscoperto è il piacere di viaggiare con i mezzi pubblici, a parte la metropolitana di Sofia, l’esperienza più bella che abbiamo vissuto è il viaggio su un trenino a scartamento ridotto, ma di questo ne parleremo a parte nel prossimo articolo…
BUONA LUCE
Roberto Gabriele


Viaggio fotografico sulla Strada della Musica, siamo tornati per la terza volta in Mississippi e questa è la STRE-PI-TO-SA casa di una nostra amica che si presenta con il fascino del tempo passato e di una vita vissuta intensamente al fianco dei migliori bluesman e musicisti del mondo.
Avevamo visitato la Oak Alley Plantation nei pressi di New Orleans, la famosa casa di Via col vento…. Ma… Nulla da fare, questa la batte in fascino e autenticità.

Una casa che ha visto passare come ospite ed amico Robert Plant con la sua band, ospitato come noi tra queste mura. Una donna che ha in tutta casa foto di lei abbracciata con BB King, con Joe Cocker e con gli ZZ Top che hanno donato un milione e mezzo di dollari per costruire il Museo del Delta Blues di Clarksdale.
Una casa vera, vissuta, con una forte personalità e una storia densa di emozioni. Perchè qui dentro è la musica che dà emozioni a chiunque entri.
Quando visiti in un museo hai il senso della storia ma non della testimonianza diretta che invece senti quando entri in una casa come questa.

La padrona di casa è una giornalista e fotografa e nella sua vita ha accumulato amicizie, conoscenze, frequentazioni e business con i migliori musicisti del’900 e di questo primo scorcio del terzo millennio, non parliamo di una reggia, nè di una casa/bomboniera, parliamo del concetto di “casa” come luogo di vissuto quotidiano, di quel posto che puó riunire tra quattro mura i ricordi e le esperienze immateriali di una vita di una persona o di una intera famiglia.
Le mura sanno raccontare una storia non scritta altrove e guardando le foto non si puó che emozionarsi al solo pensiero di quante cose possono essere accadute nella vita di una persona così.
Il patio con sedia a dondolo davanti al giardinetto con prato su strada ci introduce ad un pezzo di mondo e di storia. All’interno la struttura è semplice e le camere sono poche. All’ingresso un pianoforte e una libreria enorme, traboccante di libri, vinili e Cd ammucchiati a terra chissà se ordinati o semplicemente accantonati. Alle spalle c’è una stufa con un piccolo vano con due sedute.

Il salone enorme e finestrato su due lati è una specie di museo personale o forse dovrei dire che è una sorta di enorme “scatola dei ricordi” in cui vivere in una alternanza di passato e presente con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Un divano rosso che conta almeno 10 lustri, un enorme mazzo di girasoli sul tavolinetto al centro della sala e anche qui troviamo una incredibile quantità di foto scattate da lei ai suoi amici che hanno scritto la storia del Blues!!!

Una piccola cucina che ha l’odore forte del cibo per i suoi gatti che a quanto pare mangiano più della padrona di casa. Tra un manifesto e una locandina, tra una foto autografata e la copertina di un disco tenuto come un cimelio passiamo nello studio con il computer, stampanti varie, la ciclette impolverata è circondata da libri che rendono impossibile raggiungerla.

La camera da letto è l’ultima stanza che chiude il giro di questa casa strepitosa. Il letto a baldacchino ha ormai perso tutti i suoi ornamenti ed è rimasto “ingabbiato” nella struttura che sosteneva i tendaggi ed ora è diventata a sua volta una specie di cornice tridimensionale che racchiude la rete con il materasso come uno dei tanti ricordi della casa. Accanto alla finestra una gabbia per uccelli vuota, ripenso ai tanti gatti in casa e… Credo di sapere il motivo!!!!


Ultima notte in Mississippi, lo Stato americano che amo di più, dove la gente è vera, dove i neri sono più dei bianchi, dove l’accoglienza che ci viene riservata è quella tipica degli africani e non degli americani. Il Mississippi è nel sud degli USA e la gente che ci vive è calda e ospitale come lo sono nel sud di ogni posto del mondo, Italia compresa.

Il Mississippi è uno di quegli stati in cui i neri sono arrivati come schiavi, portati qui dall’Africa e da sfruttare come macchine da lavoro. Da Jackson, sono partiti i primi movimenti di rivolta per l’integrazione e l’uguaglianza, contro la discriminazione. Da qui è partito Martin Luther King, così come le proteste raccontate nel film The Help.

Qui si vive come in Africa, i ritmi sono lenti e c’è poca della tipica organizzazione americana. Nessuno si meraviglia se in un ristorante vuoto si viene serviti in un’ora, se le ordinazioni sono diverse da quelle fatte e se i negozi sono chiusi la domenica del giorno del Festival più importante dell’anno: la domenica e il riposo sono sacri, qui si va a messa e si fanno cori gospel di una straordinaria potenza non per fare botteghino e vendere biglietti ai turisti, ma perchè qui, semplicemente, si prega così.
Le strade sono deserte e i vecchi centri abitati sono in decadenza da decenni, da quando la meccanizzazione dell’agricoltura e l’integrazione dei neri hanno lasciato la gente senza lavoro. In quel momento al dramma dello sfruttamento si è sostituito quello della disoccupazione. Le città sono abbandonate, la gente si trasferisce in periferia a vivere in prossimità di un supermercato o del distributore di carburanti…

Ma nel DNA di questa gente c’è la musica. Il Blues e il Gospel li hanno inventati loro, il primo durante il lavoro massacrante nelle piantagioni di cotone, il secondo nelle chiese dove la gente aveva l’unico momento a disposizione per dedicarsi ai propri valori e incontrarsi con i propri simili. Musica nera, ovvio. I bianchi possono essere ottimi musicisti, inventare il Rock e il Country, ma il Blues e il Gospel restano per blacks.
E il Blues è stato proprio la parte centrale del nostro Viaggio Fotografico, la più sentita, la più lunga e importante. Lo abbiamo vissuto, non solo ascoltato. Ne abbiamo scoperto le differenti sonorità da quelle più tristi e struggenti a quelle che con le opportune deviazioni ed ispirazioni hanno dato origine al Rock’Roll. Abbiamo scoperto il Blues lento e appassionato con voce e chitarra, e quello fatto di virtuosismi musicali mozzafiato.

Questo è il Mississippi, e la mia ultima notte l’ho dedicata proprio a fotografare la gente in strada. Di notte come di giorno le strade sono vuote, ma qui la gente si raduna in fetidi locali decadenti e pieni di fascino, coloratissimi e naturalmente frequentati quasi esclusivamente da neri.
Ed è proprio in prossimità di questi locali che sono uscito a fare queste foto. Qui si viene solo per ascoltare musica e qualche volta per bere una birra, ma la consumazione non è obbligatoria, basta non portarsi da bere da casa! In alcuni rari casi di locali particolarmente frequentati (in cui c’è anche qualche bianco) si possono mangiare le strepitose costate di maiale fatte al Barbeque.

Alcuni la notte sono ubriachi ma mai molesti, la birra scorre a fiumi, la gente è allegra e ti da a parlare, vogliono sapere da dove vieni e soprattutto perchè sei venuto fin qui tre volte dal’Italia, in questo angolo sperduto di mondo e quando glielo dici capiscono che ti sei innamorato di questi luoghi e di questa gente, della loro musica e del loro modo di vivere.

Qui in questi luoghi che penseresti siano un covo di spacciatori e contrabbandieri non solo non c’è nulla che vada oltre una birra, ma sono i luoghi in cui si esibiscono i migliori bluesman del mondo e lo fanno per i loro amici, per quelli della città vicina, per se stessi e per la loro voglia di fare musica. Il Bluesman deve stupire. Non può suonare solo per il piacere di farlo, deve legarsi a capacità che gli altri bluesman non hanno come ad esempio suonare la chitarra con la lingua, cantare mentre si suona chitarra, grancassa, charleston e alternare la voce all’armonica a bocca, oppure si può stupire con una voce vellutata o per suonare il piano in piedi o esibirsi scalzi sul palco o per suonare una chitarra a forma di gallo!

Qui tutti sono amici, lo spirito di questi locali è la condivisione, l’ospitalità e il segnare pagine di storia della musica.
La fotografia mi ha permesso di sentire tutto questo addosso, dentro di me, di avvicinarmi a queste persone scorendone gli sguardi, i sorrisi, trovarle amiche senza conoscerle, di chiacchierare con uno sconosciuto e promettersi di vederci il prossimo anno. Con la fotografia si ha sempre un canale privilegiato di contatto, è un potentissimo mezzo di socializzazione. Prometto sempre di inviare le mie immagini, e le promesse vanno mantenute, in questo modo ho amici in tutto il mondo. Amici con i quali mi sono scambiato un sorriso, 4 chiacchiere e una birra in cambio di un CD con la loro musica….
Testi e foto: Roberto Gabriele
Riproduzione riservata


Oggi voglio parlare di un diverso modo di viaggiare, di fare fotografia, di vedere il mondo ma soprattutto voglio parlare di un argomento del quale si parla tantissimo: l’Immigrazione. Voglio fare tutto questo insieme mescolando cose apparentemente slegate tra loro.
Iniziamo con il dire che sono Socio della ONG Bambini nel Deserto e che quando posso “mi sporco le mani” rendendomi utile nel volontariato con le mie foto e i video che realizzo quando vado in Africa.
 Torniamo all’immigrazione: problema che coinvolge con opinioni differenti milioni di Italiani, chi vuole aprire le frontiere a chiunque, chi vuole chiuderle. Io credo che il modo migliore per vincere l’immigrazione sia fare in modo che gli extracomunitari abbiano modo di rimanere a casa loro impegnandosi in attività produttive senza essere costretti a rischiare la vita per viaggi terrificanti verso il nostro paese che vedono come il paradiso e si rivela per loro essere un inferno.
Torniamo all’immigrazione: problema che coinvolge con opinioni differenti milioni di Italiani, chi vuole aprire le frontiere a chiunque, chi vuole chiuderle. Io credo che il modo migliore per vincere l’immigrazione sia fare in modo che gli extracomunitari abbiano modo di rimanere a casa loro impegnandosi in attività produttive senza essere costretti a rischiare la vita per viaggi terrificanti verso il nostro paese che vedono come il paradiso e si rivela per loro essere un inferno.
La cosa non è difficile da fare e costa anche molto meno che proteggere le nostre frontiere e dare assistenza a chi sopravvive alle carrette del mare che trasportano disperati fino in Sicilia.
Con Bambini nel Deserto realizza una serie di progetti finalizzati all’avviamento di “Attività generatrici di reddito“. Detto in altre parole, formiamo gli Africani al lavoro, a lavori compatibili con ciò che hanno e a farne eccellenze qualitative. Li formiamo affinchè abbiano le capacità teoriche oltre alle abilità manuali. Gli diamo un “Microcredito“, prestiti a tasso zero che servono per fargli acquistare macchinari o materie prime con le quali lavorare, cifre bassissime (fino a 5000,00 Euro) che loro possono restituire in 4-5 anni.
 Cosa facciamo? Ad esempio gli insegniamo a fare i meccanici di moto (Garage Italia è un Progetto realizzato a Ouagadougou), possiamo avviarli a costituire una cooperativa di allevamento di capre per ricavarne il latte o una cooperativa di agricoltori per vendere su larga scala invece che direttamente al mercato.
Cosa facciamo? Ad esempio gli insegniamo a fare i meccanici di moto (Garage Italia è un Progetto realizzato a Ouagadougou), possiamo avviarli a costituire una cooperativa di allevamento di capre per ricavarne il latte o una cooperativa di agricoltori per vendere su larga scala invece che direttamente al mercato.
 Quello di cui invece voglio parlarvi oggi è un Progetto che abbiamo realizzato con una cooperativa di giovani sarte, coordinate da una Italiana che ha deciso di espatriare e stabilirsi lì, aprendo un B&B e con la sua esperienza maturata in anni di alta moda italiana, è andata in Burkina Faso ad insegnare alle ragazze a cucire! E non è mai più tornata in Italia.
Quello di cui invece voglio parlarvi oggi è un Progetto che abbiamo realizzato con una cooperativa di giovani sarte, coordinate da una Italiana che ha deciso di espatriare e stabilirsi lì, aprendo un B&B e con la sua esperienza maturata in anni di alta moda italiana, è andata in Burkina Faso ad insegnare alle ragazze a cucire! E non è mai più tornata in Italia.
Le ragazze che vedete in queste foto sono le stesse che hanno seguito il Corso di sartoria, i vestiti che indossano li hanno cuciti loro stesse e con orgoglio posano per le mie foto con una naturale eleganza e un portamento naturale da fare invidia a molte top model.
Fotografarle è stato per me esaltante. Conoscevo la loro storia, conoscevo le loro aspirazioni, avevo visto come lavoravano e con quanta passione cucivano i loro modelli. A Bobo Dioulasso ho seguito una di queste ragazze che dopo il Corso aveva aperto una sua Sartoria facendo lavorare 4 persone per lei: cuciono vestiti su misura, gli porti la stoffa, scegli il modello e passi a ritirarlo finito un paio di giorni dopo.

La cosa bella è che stando in Italia sembra che un lavoro nella moda sia riservato solo a noi, oppure a fabbriche di Cinesi stipati a Prato, non è facile pensare che anche in Africa ci siano persone che tengono al loro look! Fortunatamente non tutti gli Africani muoiono di fame, ci sono milioni di persone che nella loro povertà hanno una grandissima dignità e con piccoli (o grandi) gesti curano la propria persona come lo farebbe uno di noi. L’Africa riesce sempre a meravigliarmi, ogni volta che ci ritorno…
 Quando vado in Africa la sensazione più bella è quella di trovarmi in un posto con enormi potenzialità, in un territorio vergine pronto per crecere e dare i suoi frutti migliori. Non un posto da conquistare o da colonizzare, ma al contrario vedo un intero continente che ha voglia di crescere, di svilupparsi e dare il meglio che ancora non è riuscito a dimostrare.
Quando vado in Africa la sensazione più bella è quella di trovarmi in un posto con enormi potenzialità, in un territorio vergine pronto per crecere e dare i suoi frutti migliori. Non un posto da conquistare o da colonizzare, ma al contrario vedo un intero continente che ha voglia di crescere, di svilupparsi e dare il meglio che ancora non è riuscito a dimostrare.
E’ bello poter raccontare le storie di chi ce l’ha fatta a rimanere nel suo Paese, a realizzare la sua vita con eccellenze alla sua portata che gli hanno permesso di farsi una famiglia, di imparare un mestiere e di contribuire alla crescita del suo villaggio.
Altre storie vi potrò raccontare, nelle prossime puntate…
Testi e foto di Roberto Gabriele e Simona Ottolenghi
Leggi anche la versione pubblicata sul sito di Bambini nel Deserto.


Alzi la mano chi di Voi ha sentito parlare di Domon Ken! Almeno sentito nominare? Almeno visto una sua foto senza sapere che lui fosse l’autore??? Nessuno??? Beh… Confesso che anche io fino alla scorsa settimana non sapevo di lui assolutamente nulla.
A Roma invece, da qualche giorno si vedoxno le sue foto nelle locandine che pubblicizzano una sua mostra all’Ara Pacis. Una mostra da vedere entro il 28 agosto, c’è ancora tanto tempo, ma visto il periodo vacanziero non tutti riusciranno ad organizzarsi per vederla, e allora ho deciso di parlarvene io così se non siete di Roma potete comunque imparare qualcosa di nuovo…
Domon Ken è il Maestro del Realismo fotografico giapponese. Detto in altri termini è padre storico giapponese per il Reportage e la Street Photography e ha un intero museo a lui dedicato nella sua città natale, Sakata, in riva ad un lago che contiene tutto il suo archivio. E poi, se leggi qui sotto tutta la sua storia, ti accorgerai che è stato un vero EROE dell’arte fotografica per come l’ha affrontata, portata avanti e approfondita ogni giorno della sua vita.
Ma perché interessarci a Domon Ken se in Italia non lo conosce praticamente nessuno? Perché è bravo, perché la sua mostra all’Ara Pacis è davvero bella e ripercorre mezzo secolo di storia del ‘900 giapponese.

Ogōchimura
535 x 748 mm.
(Ken Domon Museum of Photography)
Fondamentale per capire l’importanza di questo personaggio è leggere la tabella che c’è proprio all’entrata con la cronistoria della sua vita. Questa ci fa capire anche moltissimo del suo carattere. Nasce nel 1909 e inizia la sua carriera artistica con la pittura, avrà 7 figli, ma la cosa sconvolgente sono le 3 emorragie celebrali che lo porteranno a delle battute di arresto dalle quali è uscito sempre più malconcio, ma mantenendo sempre la sua voglia di fotografare e osservare come sia cambiato il suo modo di lavorare in seguito alla malattia che lo ha messo su una sedia a rotelle. Leggi sotto come è andata, perché è davvero interessante…

Gli esordi furono con la fotografia istituzionale: foto di personaggi potenti del mondo della politica giapponese, per lui ritratti di famiglia e rasserenanti immagini di regime che ritraevano la prosperità del Paese alla vigilia della seconda guerra mondiale, la bellezza delle infermiere della Croce Rossa e le esercitazioni di queste e dei soldati con corpi scultorei che in massa si preparavano ordinatamente ai combattimenti, le strade affollate per lo shopping, i mezzi pubblici funzionanti. I punti di vista che enfatizzano le geometrie, le moltitudini delle masse, l’ordine dei pattern e l’abbondanza di figuranti ricordano molto da vicino l’opera di Leni Riefenstahl, la Fotografa del Nazismo che raccontava quello che nello stesso periodo voleva esprimere la Germania. Colleghi di stile, immagini uguali, due Paesi in guerra tra loro. Questo aspetto fa un po’ riflettere….

Alla vigilia della guerra Domon Ken si staccò pian piano da quel tipo di immagini patinate che non raccontavano la verità reale che lui aveva davanti al suo obiettivo e decise di allontanarsi da questo genere per avvicinarsi al reportage, ricevendo i primi arresti da parte di chi fino a quel momento si era servito di lui. Ma questo è normale che accada, non è giusto, ma normale. Iniziò in questo modo il suo Realismo fotografico, quello che come dicevo all’inizio noi oggi chiamiamo Reportage. E fu così che Domon Ken iniziò una vera e propria rivoluzione stilistica cambiando radicalmente il suo punto di vista e concentrandosi sui poveri, sugli ultimi, invece che sul regime e i suoi splendori. A questo periodo appartengono le immagini dei pescatori e delle pescatrici, quelle dei saltimbanchi e quelle degli antichi mestieri.

Iniziò così a cambiare stile approdando ad un genere di fotografia più tecnica, più riflessiva, passò dal pratico formato Leica 35 mm al Banco Ottico che richiedeva ovviamente tempi di allestimento set decisamente più lunghi, attrezzature più ingombranti, l’uso del cavalletto e tempi di scatto lunghissimi che richiedevano una non semplice complicità e partecipazione da parte dei suoi soggetti. Infatti fu questo il periodo in cui iniziò a fotografare il Bunraku, ossia il Teatro delle Marionette. I risultati sono delle immagini di altissima qualità ottenute in luce ambiente praticamente prossima allo zero ma che riportano l’occhio di noi osservatori contemporanei a notare il senso estetico modernissimo che aveva Domon Ken già 80 anni fa….
Sempre parlando di Realismo Fotografico, possiamo fare un altro parallelo di sicuro con il nostro cinema del Neorealismo che ci riporta a quegli stessi anni in cui evidentemente in tutto il mondo c’era bisogno di dire altro, di esprimere e raccontare la gente comune, quello che succedeva nelle strade, fu un po’ da questo che nacque la Street Photography. Domon Ken iniziò a raccontare la strada, lo fece in particolare modo concentrandosi sui bambini, sulle loro abitudini, i loro giochi, i loro sorrisi e la loro vita libera e fondamentalmente felice con poco. La guerra era già arrivata, ma le sue immagini raccontavano, con grande eleganza e discrezione tipicamente orientale i volti di chi nonostante tutto ha ancora una speranza.

Nel 1957 ormai a 38 anni di età era un Reporter a tutti gli effetti, i suoi esorti istituzionali non gli appartenevano più e da Giapponese sentì la necessitá di raccontare a 13 anni di distanza la più grande tragedia della storia che mai abbia colpito il suo paese: la bomba atomica esplosa ad Hiroshima. E questa credo che sia la parte più intensa di tutta la sua produzione. Domon Ken ha realizzato ad Hiroshima circa 7000 scatti nel corso di diversi suoi viaggi tra le rovine e tra i sopravvissuti alla tragedia, qui nella mostra ne vediamo una ventina.

1957
(Ken Domon Museum of Photography)
La cosa che sconvolge l’osservatore è il fatto che anche in questo caso, l’Autore non ci racconta la tragedia con il sangue, con i morti, con la distruzione. Riesce sempre ad avere uno stile pulito, mai falso, ma riesce a parlarci della speranuza che pian piano la gente ricominciava ad avere dopo la tragedia. Ci parla di ferite ben visibili ma rimarginate, ci parla degli orrori e delle ustioni ma anche delle ricostruzioni in chirurgia plastica, ci parla di un padre sopravvissuto e sfigurato ma felice e sorridente che tiene in braccio suo figlio nato sano. Hiroshima è quindi la serie della speranza, ma subito dopo sarebbe arrivata la malattia dalla quale lui stesso uscì grazie alla sua visione positiva del mondo.

457 x 560 mm.
(Ken Domon Museum of Photography)
 Arrivò la prima emorragia celebrale, arrivò il primo colpo di arresto della sua carriera fotografica, ma non smise di fotografare e andò avanti continuando a scattare le sue foto nonostante tutto. Fu questo un lungo periodo di 15 anni nei quali andò a realizzare i ritratti dei suoi amici, altri artisti e intellettuali della scena giapponese. La selezione dei soggetti andò a cascata: lasció un pennarello su una porta dentro casa e gli amici che andavano a trovarlo gli scrivevano man mano una lista sempre più lunga di altre persone da aggiungere al suo lavoro.
Arrivò la prima emorragia celebrale, arrivò il primo colpo di arresto della sua carriera fotografica, ma non smise di fotografare e andò avanti continuando a scattare le sue foto nonostante tutto. Fu questo un lungo periodo di 15 anni nei quali andò a realizzare i ritratti dei suoi amici, altri artisti e intellettuali della scena giapponese. La selezione dei soggetti andò a cascata: lasció un pennarello su una porta dentro casa e gli amici che andavano a trovarlo gli scrivevano man mano una lista sempre più lunga di altre persone da aggiungere al suo lavoro.
In seguito alla seconda emorragia celebrale finì sulla sedia a rotelle ma non perse la sua voglia nè la forza di fotografare il suo Giappone. Continuó quindi il suo lavoro ma cambiando radicalmente le modalità di eseguirlo, i soggetti, la tecnica, lo stile. Per ovvi motivi logistici legati alla sua condizione di semi-infermità, riprese a scattare con il suo banco ottico (nella vita ogni capacità acquisita non è mai fine a sè stessa) e il cavalletto, facendosi montare il tutto dai suoi Assistenti ad una altezza compatibile con il suo punto di vista ormai ribassato rispetto alla media.
 L’ultima parte della sua produzione fotografica è stata una ricerca sui luoghi sacri giapponesi, sui giardini tradizionali, sui dettagli di statue sacre. Continuò a scattare con nuove modalità, un nuovo stile, stavolta molto più rallentato, universale. In quest’ultimo periodo le sue immagini hanno perso il dinamismo coinvolgente del reportage e si sono evolute nello still life e nella fotografia di architettura che richiedono pazienza, studio, (sono pochi i Fotografi che abbiano la voglia di ristudiare il proprio stile).
L’ultima parte della sua produzione fotografica è stata una ricerca sui luoghi sacri giapponesi, sui giardini tradizionali, sui dettagli di statue sacre. Continuò a scattare con nuove modalità, un nuovo stile, stavolta molto più rallentato, universale. In quest’ultimo periodo le sue immagini hanno perso il dinamismo coinvolgente del reportage e si sono evolute nello still life e nella fotografia di architettura che richiedono pazienza, studio, (sono pochi i Fotografi che abbiano la voglia di ristudiare il proprio stile).
Dopo la terza emorragia celebrare è finito in coma e ci è rimasto praticamente per gli ultimi 12 anni della sua vita senza mai riprendersi. Da quel momento la natura ha avuto il sopravvento sulla sua voglia di fotografare, sulla sua possibilità di farlo.
Questa è la storia di un fotografo-eroe, di una persona che non ha mai smesso di evolversi, di chi ha saputo crescere, cambiare genere, ricominciare, rimettersi in gioco. Battuto ma non vinto, ha sempre avuto la forza d’animo di trovare nuovi linguaggi espressivi che lo facessero esprimere con la fotografia.
testi di Roberto Gabriele


Mai come in Mongolia ho provato un senso di infinito, di vuoto, di deserto, di enormità contrapposto ad una civiltà antica e ad un popolo nomade e civile che abita gli spazi sconfinati.

In Mongolia l’estate dura da giugno ad agosto, ci sono poi due brevi stagioni intermedie e 8 mesi di inverno durissimo con temperature che scendono a 50 gradi sotto zero, Ulaan Batar arriva a 50 gradi in estate raggiungendo un’escursione termica di 100 gradi tra le massime e le minime che mediamente si registrano ogni anno. Si aggiunga poi che su 2 milioni di persone in tutto in Mongolia il 30% della Popolazione vive da nomade nella steppa nelle caratteristiche Ger, le tende mongole: intere famiglie di allevatori che condividono i pochi metri quadrati della tenda sfidando i fortissimi e gelidi venti che arrivano da nord.

Queste premesse socioclimatiche mi erano necessarie per chiarire il significato di queste mie fotografie. La cosa che più mi ha colpito viaggiando da queste parti è il senso di confine che c’è tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, tra le case (o le tende) e la natura selvaggia che è subito fuori di esse. Unico filtro fra interno ed esterno è la lastra di vetro di una finestra o una porticina di legno.

Ho iniziato quindi ad osservare l’esterno visto dall’interno, a guardare quel mondo con gli occhi di chi lo vede tutti i giorni. Ho iniziato ad immedesimarmi nel punto di vista di chi vive contrasti tanto forti che rendono difficilissima qualsiasi forma di comunicazione e socializzazione.

Nei pochi villaggi ci sono dei piccoli minimarket che vendono i generi di prima necessità senza lasciare alcuno spazio a tutto ciò che è superfluo, non indispensabile, non necessario. Le città più grandi hanno 2-3000 abitanti, un distributore di benzina, un paio di questi minimarket, un ristorantino per i pochi che passano da quelle parti, un Tempio buddista e qualche casa di muratura che si alterna alle ger.

Dalle finestre di questi locali, così come dalle porte delle ger dei nomadi, si vedono mondi desolati, città vuote o l’immensità del Deserto di Gobi.
Ho voluto fare una analisi sociale di quello che è il mondo che queste persone hanno davanti. Da quelle finestre si vede sempre la stessa piazza, da quelle porticine sempre lo stesso orizzonte. La cosa che mi sconvolge è il fatto che siano pochissime le persone che vivono quegli spazi.

Un nomade vedrà solo il deserto o la sua famiglia: una manciata di persone solitarie. Chi sta nel villaggio vedrà comunque sempre le stesse facce per tutta la vita. Da quelle parti è difficile trovare una propria identità, difficilissimo lasciare spazio alla creatività, alla socialità, allo scambio sociale e culturale tra le persone.

Nessuna speranza di cambiamento per nessuno. La loro vita è segnata dal clima, dalla natura che non lascia spazio ai sogni.


Roma: Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale 194, fino al 28 agosto 2016 c’è la mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin. A cura di Contrasto e Fondazione FORMA per la Fotografia.
Vera Fotografia, è il timbro verde che l’Autore, così come moltissimi della sua generazione (classe 1930) erano soliti porre sul retro delle stampe da negativo per distinguerle da quelle stampate tipograficamente che erano di minor pregio e per certificarne l’autenticità di immagine ottenuta senza manipolazioni di camera oscura, nè, tantomeno con postproduzione digitale. In realtà, come sappiamo, ogni foto nel momento stesso in cui viene sviluppata (con metodi chimici o digitali) è già stata in qualche modo alterata, resa atta alla stampa e i suoi toni sono già stati modificati. Senza dubbio anche il passaggio da una realtà a colori ad una immagine in bianco e nero è già una prima alterazione (e non trascurabile nè reversibile) della realtà stessa.
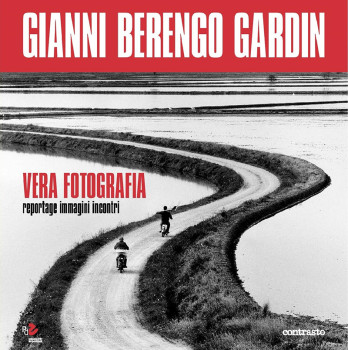
Ho visitato la mostra con un gruppo di Allievi di Viaggio Fotografico e la prima impressione che ne ho avuto è stata quella di trovarmi non solo davanti ad un Grande Maestro, ma davanti ad uno che era tale per aver scritto, ancora VIVENTE, una delle più belle pagine della Storia della Fotografia. E la differenza tra essere un bravo Fotografo e scrivere la storia è enorme. Di bravissimi Fotografi, professionisti o meno ce ne sono tanti al mondo, ma solo pochissimi sanno innovare il linguaggio fotografico ed espressivo, dettare le nuove regole alle quali poi moltissimi si ispireranno. E, ovviamente, Berengo Gardin è senz’altro uno di loro e il motivo lo capiamo proprio vedendo la sua mostra.
La prima impressione che ho avuto entrando nella mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma è quella di uno spazio ben ordinato, con sale tematiche e divise in ordine cronologico. Questo dettaglio che sembra normale, addirittura scontato, è invece quello che dimostra quanto sia longeva l’attività artistica e giornalistica di Gianni Berengo Gardin,un fotografo ancora vivente che ha esposto in centinaia di mostre in tutto il mondo e scritto oltre 250 libri fotografici. Un portento. Una vera forza della natura che produce Fotografie ininterrottamente da oltre 60 anni. E il senso della storia si sente fortissimo in questa mostra. Mi sia concesso un paragone, ma io credo che Berengo Gardin abbia raccontato un pezzo di Storia Italiana oltre che di Storia della Fotografia così come negli stessi anni fece nel cinema Alberto Sordi, raccontando gli Italiani e il loro costume che cambia. Berengo Gardin racconta una Italia senza tempo che sembra appartenerci ancora. Le sue immagini, raccontano così bene la nostra Italia che ci riconosciamo in esse, nei luoghi e nelle persone, come se facessero parte del nostro quotidiano.

Un innovatore: oggi tanto si parla di Street Photography. Probabilmente uno dei primi iniziatori della Fotografia di Strada fu proprio Gianni Berengo Gardin che ha sempre fatto della spontaneità del momento il suo cavallo di battaglia. Della semplicità di linee e forme la sua arma vincente, della innocenza delle persone ritratte il suo obiettivo finale.
Il Bianco e nero mai rinnegato per un modernistico o stilistico passaggio alla fotografia a colori uniforma i toni di tutta la mostra che sembra realizzata con immagini scattate in pochi mesi. In realtà di tempo tra le immagini ne è passato tanto, ciò che invece è rimasto uguale è lo stile che non è mai cambiato, ha sempre mantenuto una pulizia formale e un grande silenzio. Le foto di Berengo Gardin non hanno parole, non hanno rumori, le trovo ovattate, icone fortemente espressive ma che non esprimono rumori. Un pò come si esprime un mimo sul suo palco, così Berengo Gardin riesce a farci sentire la musica senza ascoltarla e anche le sue foto di fabbriche vengono percepite come spazi silenziosi.

Immagini che raccontano. Le sue immagini appaiono da subito come pensate, efficaci (è sua la famosa frase che non esistono belle fotografie ma solo buone fotografie) dirette, costruite ma mai artefatte. Se fa un ritratto in strada non sta lì a curare la luce o i set modificandoli, scatta con ciò di cui dispone, non cambia neanche obiettivo, preferendo scattare tutto con un 35 mm… Lui non crea, racconta. Ma i suoi racconti hanno la potenza delle parole di un grande poeta. Racconta come lui stesso ama dire con le immagini, come un giornalista fa con le parole. Ed è lui stesso a definirsi non più come un artista ma come un giornalista. Ma come è facile intuire, di arte nelle sue immagini ce n’è tanta.
Ogni anno viene data un’enfasi mondiale ai vincitori del prestigioso Premio di Fotogiornalismo World Press Photo, e viene immediatamente da pensare a quanto le immagini classiche e intramontabili di Berengo Gardin siano diverse da queste, pur volendo entrambe raccontare il mondo per come lo ha osservato il Fotografo. Berengo Gardin sa rendere straordinaria la normalità quotidiana. Nelle immagini del WPP assistiamo invece alla spettacolarizzazione della fotografia, oggi le immagini di fotogiornalismo non raccontano: urlano. E se le immagini non urlano nessuno le ascolta. Berengo Gardin ci dimostra che è sufficiente alzarsi di 1-2 metri al di sopra della scena per avere un punto di vista completamente nuovo, diverso, insolito ma ancora tanto rasserenante, dall’altra parte le ultime due edizioni del World Presso Photo sono letteralmente invase di immagini realizzate con costosissimi droni di ultima generazione. Il risultato che si ottiene nel primo caso è il sapersi meravigliare della semplicità che era sotto i nostri occhi e che non avremmo saputo cogliere, nel secondo caso invece ci accorgiamo che ci viene mostrato un mondo distante, diverso, sconosciuto che non ci appartiene perchè tutto viene spettacolarizzato, anche il dolore.

Ovviamente le fotografie sono tutte tecnicamente perfette, ben composte. La cosa che mi è piaciuta di più è proprio il linguaggio moderno e senza tempo delle foto di Berengo Gardin che riesce ad esprimersi con eleganza, efficacia e tanta chiarezza, sa farsi amare senza imporsi. Usa inquadrature classiche, con il soggetto al centro o sfruttando la regola dei terzi. Conosce bene l’importanza delle sequenze di piani e delle sfocature, sa usare le prospettive per comporre e condurre lo sguardo verso il soggetto principale, sa bene come utilizzare le linee di forza all’interno dell’inquadratura per creare enfasi sul soggetto, conosce perfettamente il valore dell’istante decisivo di bressoniana memoria. Leggendo queste ultime considerazioni ci si rende conto che la straordinarietà di Berengo Gardin si trova nel saper rendere eccellenti e meravigliose le cose che dovrebbe sapere un Allievo alla fine di un Corso Base di Fotografia!!!! E questo non sminuisce affatto l’importanza e la bravura del nostro Autore che al contrario riesce ad essere inarrivabile proprio su un piano al quale tutti potrebbero aspirare di arrivare essendo fatto con pochi mezzi e poca tecnica ma che necessita di una esperienza e una sensibilità unica e inimitabile.

Infine è lo stesso Gianni Berengo Gardin a raccontarci la semplicità intenzionale del suo lavoro. A raccontarci come si avvicina ad un soggetto, studiandolo prima da lontano, poi avvicinandosi pian piano ad esso, descrivendolo via via sempre più da vicino, girandogli intorno come in un rituale di avvicinamento amoroso. Mi ricorda la storia del “Piccolo Principe” che voleva creare dei legami con la Volpe la quale gli chiedeva di avvicinarsi a lei pian piano ogni giorno un pò di più e poi di sedersi senza fare nulla, affinchè lei riuscisse a conoscerlo e a fidarsi di lui per poi diventare amici. E’ proprio quello che fa Berengo Gardin con le sue immagini e i suoi soggetti.
La mostra termina con le immagini di forte denuncia di un recente lavoro sulle “Grandi Navi da Crociera” che entrano nella laguna di Venezia apparendo con la stessa grazia di un elefante in un negozio di cristalleria. Le navi appaiono gigantesche e sproporzionate all’ambiente in cui si muovono. Appaiono offensive, infinitamente più grandi della città in cui navigano. Le sentiamo minacciose per la loro forza e violenza, per la loro modernità che troppo si contrappongono con la fragilità storica della Serenissima.
Roberto Gabriele
[tbicon icon=’icon-phone-1′ size=’15px’ class=’awe’]3473790441
[tbicon icon=’icon-mail’ size=’15px’ class=’awe’] robertogabrielefotografo@gmail.com


Cosa faremo? Vedremo le foto e ascolteremo i racconti di viaggio di uno dei nostri Itinerari più belli e meglio riusciti con Viaggio Fotografico: USA la Strada della Musica. Foto e storie legate ad un viaggio e a chi lo ha fatto insieme a noi, per avere la testimonianza e i racconti di chi c’era.
La Condivisione sarà la cosa più importante della serata. Un Viaggio non è mai un evento solo privato di chi lo fa: è bello parlarne, raccontarlo, condividerne gli aspetti sociali e culturali.
Parleremo di Fotografia, di Musica, vedremo le strade e la gente, i musicisti e ascolteremo l’entusiasmo di chi lo ha fatto. E se tutto questo non bastasse, avremo anche degli intermezzi musicali live a ritmo di Blues con i quali ci allieteranno Giusy Sequino alla voce e Maurizio Noro alla chitarra.
Il tutto sarà molto dialogato, non sarà una conferenza noiosa ma ci saranno interventi dal pubblico, gli Autori presenti in sala risponderanno alle domande, racconteranno le loro emozioni legate alle foto che hanno scattato e all’esperienza vissuta nel sud degli USA, dove la gente per carattere assomiglia alla gente del nostro sud: creativi, geniali, un pò lenti e accoglienti con tutti.
Al dilà che tu stia pensando di fare un viaggio, quello che caratterizza le nostre serate è il piacere di conoscersi e di scambiare idee.
Per partecipare Ti basta riempire il Form di Iscrizione che trovi qui sotto
Come funziona? Semplice: potrai partecipare alla serata, alla proiezione, connetterti alla WIFI gratis, BERE E MANGIARE ILLIMITATAMENTE tutti i prodotti di Artcafè che sono esposti sul buffet e nel frattempo potrai conoscere nuovi amici, altri viaggiatori e appassionati di Fotografia di Roma e scoprire il senso di un Viaggio come questo. Quanto costa? Leggi sotto.
Saranno presenti in sala parecchi dei nostri Partecipanti che sono venuti l’anno scorso con noi, due di loro verranno da Milano e da Padova apposta per noi. Le foto che vedremo sono delle persone che hanno viaggiato con noi nell’Edizione 2015: un gruppo di sconosciuti che si sono incontrati per la prima volta ad Atlanta e la loro vita è cambiata.
Volete i nomi dei Fotografi Autori della serata? Eccoli rigorosamente in ordine alfabetico: Luciana Belsito, Eleonora Dazzani, Maurizio Noro, Gilberto Oriani, Maria Piccini, Laura Pierangeli, Daniela Polla, Roberto Pugliese, Bruna Risso, Giovanni Rozzo, Giusy Sequino, Giulia Vertua, Vitaliano Vitali e Silvia Zanaldi accompagnati da Simona Ottolenghi e Roberto Gabriele.

venerdì 27 maggio 2016 ore 19,30 con inizio per le 19, 45 e per la durata di circa un ora.
Il costo di tutto questo? Irrisorio: 4,00 Euro la prima ora (costo fisso minimo), poi 3,00 Euro all’ora per le ore successive pagando frazioni ogni 10 minuti. Ad esempio: 1 ora e mezza: costo totale 5,50 Euro!
Per partecipare riempi questo Form di preiscrizione, abbiamo solo 30 posti a sedere.

Quali foto vedremo? Il meglio del meglio che hanno realizzato i nostri Autori in viaggio!





 Domenica pomeriggio: siamo andati a vedere una delle nostre mostre fotografiche a Roma. L’abbiamo scoperta quasi per caso, in una galleria nuovissima inaugurata a fine 2015 dalle parti di Viale Marconi, vicino al celebre mercato di Portaportese.
Domenica pomeriggio: siamo andati a vedere una delle nostre mostre fotografiche a Roma. L’abbiamo scoperta quasi per caso, in una galleria nuovissima inaugurata a fine 2015 dalle parti di Viale Marconi, vicino al celebre mercato di Portaportese.
La Galleria è enorme, si chiama Fondazione Exlcusiva, appena ristrutturata e ricavata in una ex fonderia con un pregevole intervento di recupero architettonico e funzionale. Un bellissimo spazio completamente imbiancato che propone con uno stile minimal (less is more) una mostra di immagini fotografiche di altissimo impatto visivo perchè colorate da Madre Natura. Le foto sono perfettamente illuminate da un sistema progettato e realizzato su misura da una ditta tedesca esattamente per questo spazio.

Dovevo descrivervi la scatola prima di potervi parlare del Contenuto, perchè come ogni buon contenuto ha bisogno di una scatola degna di contenerlo, che sappia vestirlo, impreziosirlo e valorizzarlo ma senza fare clamore primeggiando in una gara di bellezza tra contenuto e contenitore.

E finalmente arriviamo alle bellissime immagini di Max Serradifalco, un Grafico prestato alla Fotografia. Un fotografo che per scattare non compra neanche la fotocamera ma preferisce scattare con quella non sua messa a disposizione dal satellite prendendo le sue foto dagli screeenshots di Google Earth; la sua modella preferita è la nostra terra vista dallo Spazio. Ancora più particolare l’atteggiamento di questo Fotografo/Grafico che non utilizza neanche Photoshop per modificare i suoi files se non per modificarne leggermente la nitidezza, operazione necessaria per poter stampare in alta risoluzione delle immagini che per forza di cose partono comunque ad una dimensione da monitor.
 Ci accoglie Max nella sua mostra, come farebbe un bravo padrone di casa, è un personaggio mite ma molto portato a parlare del suo lavoro del quale è palesemente innamorato, lo fa con toni pacati e non autocelebrativi ma con la consapevolezza di chi sa il fatto suo.
Ci accoglie Max nella sua mostra, come farebbe un bravo padrone di casa, è un personaggio mite ma molto portato a parlare del suo lavoro del quale è palesemente innamorato, lo fa con toni pacati e non autocelebrativi ma con la consapevolezza di chi sa il fatto suo.
Più volte premiato dal MIFA di Mosca ad una menzione d’onore agli International Photography Awards negli USA nel 2012, ha poi esposto dal Giffoni Festival al MIA fair di Milano fino ad una importantissima selezione come miglior Progetto sulla Piattaforma creativa Behance di Adobe.
Max, come un segugio, cerca le sue immagini scansionando ed esaminando il Pianeta Terra palmo per palmo fino a trovare in esso dei soggetti interessanti per renderli dei veri e propri quadri dipinti dalla natura e visibili solo dal cielo. Continui cambi di rapporti di ingrandimento, zoom in e out e poi spostarsi con il mouse alla ricerca di quadri già pronti che deve solo isolare dal contesto in cui si trovano.
Entrando un pò di più sul tecnico, alcune immagini hanno un lato reale che corrisponde a decine di chilometri, alcune a poche centinaia di metri sul terreno, e il suo lavoro di ingrandimento e riduzione è quello che farebbe qualsiasi altro fotografo con un obiettivo macro allontanandosi e avvicinandosi ai suoi soggetti.

Max Serradifalco oltre ad essere un Fotografo sui generis perchè scatta con fotocamere non sue, è anche un Viaggiatore originale poichè conosce tutto il mondo senza muoversi dal suo PC, vola nello spazio senza essere un astronauta e senza avere un’astronave, un esploratore che racconta luoghi che non conosce… Un pò come Jules Verne che scrisse di un Giro del Mondo in 80 giorni o di un viaggio dalla terra alla luna senza aver mai fatto nessuno dei due…. Non so se Max Serradifalco sia anche un pittore (intendo dire se sappia usare pennelli e colori), ho dimenticato di chiederglielo! Ma di sicuro Quelli che “vede” sono dei quadri che solo la geologia sa dipingere con tanta magnifica perfezione e lui diventa una sorta di Ambasciatore della Natura, un Agente Rappresentante del Pianeta, un Avvocato della Natura. Tutte rispettabilissime Professioni che hanno a che fare con cose non realizzate direttamente da loro. Non ho usato la “professione” di ladro, perchè lui non ruba nulla a nessuno, CERCA qualcosa per noi, questo non è rubare, è concedere agli altri il dono della bellezza.

I suoi soggetti preferiti sono i deserti e le foci dei fiumi, i primi generano per lui interessantissimi patterns e veri e propri quadri decorati che a volte ricordano Jackson Pollock, altre rimandano a figure antropomorfe, altre ancora sono vere e proprie campiture di colore o incredibili disegni visibili solo dal cielo. La forma delle montagne con le loro ombre riportate, i detriti portati dai fiumi, isolotti che si formano in vari luoghi del mondo in quel confine sempre mutevole tra le zone di acqua e di terra… Le istantanee di Max Serradifalco sono davvero delle opere d’arte.

Il suo lavoro di FotoRicercatore si esprime principalmente in tre direzioni:
WEB LANDSCAPE PHOTOGRAPHY Foto/Quadri generati dal Paesaggio
EARTH PORTRAIT Paesaggi terrestri che assomigliano a figure e profili umani
E-ART-H Paesaggi terrestri che assomigliano a quadri famosi

Da Viaggiatore e Fotografo quale sono, mi trovo molto in empatia con questo giovane e performante Artista nel quale riconosco la mia grande passione per le mappe (da bambino il mio libro preferito era l’Atlante De Agostini, lo sapevo a memoria), per la fotografia in generale e per quel magnifico gioco che è Google Earth che sa farci sognare. Rimango incantato anche io per ore ad esplorare la nostra terra, la cosa che più mi piace, è atterrare dove voglio con questa astronave virtuale usando Street Wiew per sentirmi completamente immerso in una realtà diversa. La Fotografia non mi da la stessa sensazione che provo con Street Wiew… Capisco insomma il suo interesse per questa materia affascinante che è il nostro mondo.
Roberto Gabriele

New York…. Adoro questa città. I LOVE NEW YORK!!!! La amo da prima di averla visitata. E forse l’avevo visitata ancor prima di andarci di persona. Non la conoscevo: quando ero un bambino un pò snob la pensavo e la immaginavo come una città troppo moderna, senza personalità, alla quale mancava la storia e monumenti importanti come ad esempio il Colosseo, o i Canali di Venezia…. Poi durante l’adolescenza iniziai a sentirmi Fotografo e Viaggiatore e iniziai a rivedere le mie idee su questa fantastica città….
Le prime esperienze di conoscenza le ho avute al cinema, quando iniziavo a vedere il grande cinema americano e a rendermi conto che forse da grande sarei diventato Fotografo. Iniziai a vedere le ambientazioni dei film più belli e a scoprire che New York era raccontata come una Protagonista della storia, e non come una ambientazione di alcune scene. New York è la città che influenza chi ci vive e ci lavora. Il rapporto è inverso a quello che succede nel resto del mondo: qui non sono le persone ma è la città stessa a raccontare le storie, la gente le vive di conseguenza. Mi resi conto che questa città era molto più di un set cinematografico a cielo aperto e disponibile agli occhi di chiunque, era il soggetto dei film, era la storia stessa, viveva di vita autonoma come un protagonista. Scoprii che dentro di me cresceva il mito della città e che oltre ai film iniziava a vivere anche dentro di me fin quando decisi che la mia iniziazione a NYC sarebbe stata nel modo più profondo: correndo la Maratona di New York. Erano passati 15 anni da quando iniziavo a pensare di andarci.
Appena arrivato, la mia prima impressione fu quella di esserci già stato, di averla già vista. Mi rendevo conto che quello che vedevo nei film non era finzione cinematografica ma era tutto vero, tutto incredibilmente uguale a 1000 scene di film a me già noti eppure, mi meravigliavo di quanto, allo stesso tempo fosse tutto nuovo. Quello che cambiava erano sicuramente le percezioni di ciò che stavo vivendo in prima persona e non al cinema.
New York sa accoglierti, non solo perchè i posti che vedi per la prima volta in realtà già li conosci, New York è anche la città in cui come dice una canzone degli U2 le strade non hanno nomi perchè sono identificate da numeri e questo vuol dire che anche senza mappa sai sempre dove sei e dove devi andare, tutto questo rende la città accogliente e familiare pur essendo una metropoli enorme.
Non parlerò di Cinema, di attori e registi, nè recensire tutti i film, non sono un Critico, oggi voglio raccontarvi di quello che ho provato io, di quelle che sono state le mie impressioni nel vivere la città come in un set, come se anche io fossi protagonista di un film che si stava girando a mia insaputa. Guardate questi film, quanto sono diversi tra loro, diverse le storie, i modi di raccontarle, le epoche e le ambientazioni eppure tutti, chi in un modo, chi in un altro, hanno significato molto per me.
Da quel giorno sono tornato a New York per 7 volte e ci torno ogni anno a fotografarla, a scoprirla, ad amarla come una generosa amante che si sappia dare senza limiti a chiunque voglia sentirla sua.

E visto che abbiamo iniziato dalla musica e dalle eleganti sonorità di Manhattan, restiamo in campo musicale e spostiamoci a Brooklyn. La Febbre del Sabato Sera non viene ricordata per la città, ma per la sua storia. Ma voi sapreste immaginare una storia come quella di Tony Manero in una città diversa da questa? La colonna sonora dei Bee Gees ha modificato il ritmo del battito cardiaco di quelli della mia generazione. Ero un bambino, nel 1978 quando uscì questo film che vidi anni dopo perchè vietato ai minori di 14 anni… Ma vedere quella metropolitana che volava su una ferrovia sopraelevata, vedere quelle case e la Lenny’s Pizza e sapere che oggi è tutto come allora mi ha fatto sussultare…
Il titolo del film già dice tutto e prende il nome dalla omonima canzone cantata da Liza Minnelli che ha legato meglio di qualunque altra una melodia alla città di New York. Più che il film, in questo caso è proprio la Colonna Sonora ad aver generato in chiunque di noi un immaginario onirico legato alle atmosfere di questa città. Accendete le casse del Vostro computer e fate play su questo video… E magari leggete anche il testo della canzone che non può che riportarvi al vero spirito di questa città incredibile: I wanna be a part of it e in effetti ci si sente davvero perte integrante di questa città, anche quando non la si conosce ancora. I wanna wake up in the city, that doesn’t sleep svegliarsi nella città che non dorme mai…. If I can make it there, I’d make it anywhere e questo senso di universalità che davvero si sente forte a NYC.
Rimaniamo ancora a Brooklyn e facciamo un salto nel tempo fino al 1995…. Erano questi gli anni in cui sentivo fortissimo il bisogno di andare a New York, a vivere questa città e facevo indigestione di chilometri di pellicola, mi saziavo solo con ore e ore al buio dei cinema di Latina a sognare di attraversare l’Oceano Atlantico per entrare in una tabaccheria come questa, a vedere e parlare con gente come gli amici del tabaccaio, ad ascoltare le loro storie e a fotografare tutto questo per raccontarlo con le mie immagini. In questo film c’è uno spaccato della vita newyorkese, la cosa incredibile è che Brooklyn è solo uno dei 5 quartieri di New York ed è immenso, è il più grande, eppure la vita lì è come quella che troviamo nei paesini dell’Appennino italiano! A Brooklyn ci si conosce tutti, la vita scorre tranquilla, i tempi non sono quelli di Manhattan, ci si può intrattenere a parlare di filosofia con gli amici… Ovviamente ogni volta che torno a New York con i Gruppi di Viaggio Fotografico, non manchiamo mai di andare a Brooklyn in diverse zone tutte da esplorare…
Vidi questo film a Roma mentre ero militare, marzo 1990, all’epoca si entrava gratis al cinema purchè ci si presentasse all’ingresso in divisa. E così feci vestito da marinaio: “Militari gratis“. Naturalmente vidi il film da solo, non erano questo un film da andare a vedere con i commilitoni, molto più propensi per altri film diciamo di… “genere”… Non potrò mai dimenticare le risate nel vedere questa scena che vi ripropongo qui di seguito che poi a sua volta è diventata una delle più famose della storia del cinema anche in chi il film non lo ha visto! Girata in un ristorante di Manhattan nel quale andiamo sempre con i Gruppi di Viaggio Fotografico a riviverne le atmosfere. Il locale in più di 25 anni non è cambiato di una virgola, se non nell’aver inserito una foto del set in un quadretto con le firme del cast del film!
Questo è l’unico film italiano che posso evidenziare in questa rassegna tra quelli che mi hanno legato alla città di New York. In realtà dovrei ricordare per completezza e con un sorriso anche altri due titoli italiani come: “Da Corleone a New York” con Mario Merola e il famosissimo “un jeans e una maglietta” con Nino D’Angelo… Ma torniamo al nostro Sergio Leone che con questo film ha scritto delle pagine di autentica poesia cinematografica con le musiche del Maestro Ennio Morricone, l’inquadratura più famosa del film è anche questa meta delle nostre visite ed è quella che si vede in questo spezzone in cui in fondo alla strada si erge imponente il pilone del Manhattan Bridge. Posso garantirvi che è uno dei posti più pazzeschi in cui andiamo a fare le nostre foto…
Immancabile film storico, girato subito dopo la costruzione del mitico Empire State Building…. Le sue inquadrature sono inscindibili dalla storia della città e di questo che è il più classico e affascinante dei suoi edifici. Il film oggi, naturalmente fa sorridere, ma gli effetti speciali ottenuti allora facevano urlare al miracolo. Questo film lo ricordo più per come il film viene vissuto nel merchandising che si trova nei negozietti di souvenir che per aver modificato il mio immaginario della città di New York. Andare oggi a Chinatown o in tutti gli altri negozietti di paccottiglia per turisti che si trovano in giro, significa imbattersi nelle icone classiche di questo film.
Pellicola strappalacrime, ma con ambientazioni fantastiche nella città e in particolare le più famose a Central Park in autunno, quando gli alberi si infiammano di rosso, le scene di interni sono meno facili da raggiungere per ovvi motivi, ma il cinema a New York va visto e vissuto in strada, i set sono dovunque. La Fotografia di questo film è così bella, e il titolo così evocativo che lo leghiamo ad un immaginario rasserenante invece che alla storia tristissima vissuta dai protagonisti…. Ma quando vai a Central Park in autunno e vedi che è veramente bello come nel film allora tendi a dimenticare la storia e a goderti il momento e i luoghi fantastici che hai davanti.
Rimaniamo ancora a Central Park dove sono ambientati gli allenamenti del Maratoneta, Dustin Hoffman, che vive una storia completamente staccata dal pretesto sportivo del titolo. Ma un film come questo ti entra nel sangue, fa parte del tuo DNA e quando vai a New York, ti infili le scarpe e vai anche tu ad allenarti lungo le sponde dei laghetti correndo intorno a quei recinti ecco…. Lì senti che la tua vita può finire anche in quel momento. Ve lo voglio dire: correre a Central Park (anche non necessariamente al traguardo della Maratona di New York) è la massima realizzazione che uno sportivo possa avere. Correre in un posto del genere, circondato da alberi e grattacieli ti fa sentire all’interno del film visto magari anni prima. Quando ero lì al quarantunesimo chilometro sentivo svanire la fatica e aumentare l’adrenalina: vivevo in un sogno che si realizzava due volte, sia dal punto di vista sportivo che cinematografico.
Altro grandissimo classico della cinematografia newyorkese: la gioielleria più famosa del mondo continua la sua attività sulla 5th Avenue. E anche in questo caso nulla è cambiato negli anni. Lo stile sobrio ed elegante di questo sfavillante negozio resta sempre unico. L’anno scorso siamo anche entrati a curiosare all’interno, non avevamo mai avuto il coraggio di varcare la porta e andare oltre le vetrine. Pur essendo un uomo e piuttosto distaccato dal fascino dei Preziosi, ricordo che mi sconvolse la vista di una collana che brillava di luce propria e aveva al centro un rubino grande come un uovo e tempestato di brillanti. Per curiosità mi presentai (vestito da Fotografo con fotocamera, bermuda e maglietta visto che era piena estate) da una elegantissima venditrice a chiederne il costo, mi rispose con molto tatto: “Quello non ha prezzo, Signore”… Credo però che non me lo avrebbe detto neanche se fossi andato in giacca e cravatta….
“Guerrieri avete paura???” chi non ricorda quella scena??? Un film degli anni ’70 girato in gran parte nei lunghi e luridi corridoi della metropolitana, racconta la storia delle gang newyorkesi che si davano battaglia per il controllo del territorio. Una carrellata di tipi umani che ci raccontano di stili di vita passati ma tanto in voga fino a pochi anni fa. Già la sigla del film che vediamo in questo spezzone è evocativa e ci porta immediatamente ai luoghi del film, al Bronx all’epoca invivibile e degradato quartiere nero inaccessibile ai bianchi. Oggi, dopo Rudolf Giuliani il Bronx gode di una nuova vita, è un luogo tranquillissimo in cui andiamo sempre a fare i nostri scatti più originali e lontani dai soliti itinerari turistici.
E passiamo dalle “stalle alle stelle”, al contrario, stavolta…. Passiamo dal Bronk lercio alle atmosfere patinate e perfette di quest’altro film molto più recente ambientato negli ambienti della moda newyorkese, con le classiche icone da stress lavorativo e competitività professionale americana. Qui New York è esaltata alla massima potenza. Vedendo questo film ho ripensato alla New York che rifiutavo quando ero bambino, ho visto un mondo lontano dalle strade che amo percorrere e fotografare in questa città. Eppure il fascino che emana anche questo film è unico, così come il personaggio irritante di Maryl Streep.
Immancabile dopo l’arrivismo economico del Diavolo veste Prada, passiamo alle aspirazioni artistiche e di fama della più famosa scuola di danza della storia del cinema. Il film lo conoscono tutti, racconta gli intrecci delle storie degli Allievi che vogliono crescere e diventare famosi, imporsi per stile e personalità. Divisi tra audizioni e spettacoli, tra formazione e allenamento, tra amori e passioni. Il film a cui facevo riferimento era quello originale del 1980, ma devo dire che il remake che vi propongo qui per una volta tanto è meglio della prima edizione. E anche qui New York è la protagonista della storia, da Times Square alla metropolitana, dalle strade sconosciute alla famosa scuola.
Il film per eccellenza di Woody Allen su New York, dal titolo alla prima scena sono tutti girati nel più incredibile dei 5 Quartieri di New York: Manhattan, quello a più alta concentrazione di grattacieli, quello che è il vero cuore pulsante, il vero baricentro del mondo economico e culturale. Tutto il resto del film parla della città, con la mitica scena della locandina girata nei pressi del Queensboro Bridge dove ogni volta andiamo a fare i nostri appostamenti fotografici al tramonto. E il bello di New York è proprio questo: puoi andare a fotografarla e trovarla sempre lì come era nel film ed è ancora a tua disposizione per trasmetterti tutto il suo fascino. Il Bianco e nero di questo film da alla città un fascino immutabile e senza tempo, un Fotografo certe cose le sente, le percepisce vive, forti e chiare.
Il Museo di Storia Naturale è una esperienza meravigliosa da non perdere e purtroppo troppo spesso snobbato dai più come un luogo per bambini. La visita del museo richiederebbe una intera giornata, ed è questo il motivo per il quale non ci andiamo quasi mai a visitarlo, se non in caso di pioggia. Il film, questo si, è rivolto ad un pubblico decisamente giovane, ma è ambientato in un edificio pieno di fascino e curiosità e non si può non citarlo tra i film dedicati alla città.
E dopo un film per bambini, passiamo al grandissimo Stanley Kubrick e al suo ultimo capolavoro girato nei “piani alti” di Manhattan. Vidi per la prima volta questo film da solo, in un multisala di Frosinone, ultimo spettacolo di una fredda sera infrasettimanale… New York ormai iniziava ad essere più vicina per me, ancora non lo sapevo ma 2 anni dopo ci sarei andato per la prima volta, e vedendo Eyes wide shut sono rimasto letteralmente ipnotizzato davanti a quello schermo, devo dire abbastanza congelato da una serie di fortissime emozioni in un mix di paura e di esaltazione, coinvolto in una storia avvincente e con nessuno per commentarla, confrontarmi, gioire o indignarmi. La New York che vediamo qui è quella sfavillante di luci e di ricchezza, una città massonica, in un giro di poteri politici ed economici, di ricatti e scambi. Non è certo la città che vediamo noi, ma è una New York che esiste in certi ambienti e che riguarda magari quello che è seduto affianco a noi in metropolitana. La colonna sonora è l’ennesima mossa geniale del grande regista, non puoi non rendertene conto mentre guardi il film, è in grado di svuotare i silenzi, di esaltare le atmosfere fosche e misteriose dense di noir e di trasgressione in cui è ambientato il film. La coppia Tom Cruise – Nicole Kidman è magistralmente diretta ed interpreta anche nel film una coppia molto reale fatta di intrighi, tradimenti, passioni e colpi di scena.
Commedia romantica girata agli esordi della Posta Elettronica, quando ancora non esistevano i Social, i siti di incontri ecc, stiamo parlando degli albori di questi sistemi di comunicazione: il 1998. Con Meg Ryan e Tom Hanks, è la storia di due personaggi assolutamente incompatibili sia dal punto di vista professionale che umano che si incontrano di persona e si odiano e si evitano come possono, ma per puro caso, nell’anonimato delle primissime email che iniziavano a girare in quel periodo, i due, senza conoscere le vere identità l’uno dell’altro si scoprono innamorati reciprocamente e sinceramente pur continuando ad odiarsi di persona. Anche in questo caso l’ambientazione ovviamente è New York.
Il resto del film e il finale sono una storiella all’americana, è bello rivedere oggi al nostro recente passato come se parlassimo della preistoria informatica….
Finisco questa mia personalissima carrellata emozionale con un film del 2015 che vede Morgan Freeman e Diane Keaton in versione marito e moglie che vivono in uno splendido attico nel quartiere di Williamsburgh con vista sull’omonimo ponte e naturalmente sullo skyline di Manhattan. Vedendo il film, una bella storia ben diretta, mi sono innamorato di questo quartiere di tipica vita newyorkese e lontanissimo dagli itinerari turistici. Sono andato a fotografare Williamsburgh pochi mesi dopo aver visto il film, è una zona multietnica della città in cui la vita scorre lentamente, in cui la gente esce a piedi per strada e si muove in metropolitana, in cui si va a fare la spesa sotto casa e dove la sera puoi prendere un drink su una terrazza come quella del film… Torneremo a fotografare Williamsburg su un nostro itinerario tra locali retrò e gente comune, lo faremo perchè…. I LOVE NEW YORK!!!!!
Commedia di Woody Allen del 2019 in cui la storia si intreccia in modo magistrale come solo un grande regista sa fare tra due ragazzi che vanno a passare un weekend nella grande città con una serie di incontri sotto la pioggia. Notevole davvero è la ricostruzione fotografica sul set: la luce della fine della giornata con il sole che tramonta con una luce calda mentre sui protagonisti ancora cade la pioggia… New York è così: da vivere in ogni attimo, con ogni condizione meteo: il suo fascino non tramonta mai.
uno straordinario Leonardo Di Caprio diretto da Martin Scorzese nel pieno della sua arte cinematografica, racconta la storia vera di Jordan Belfort, “Il Lupo di Wall Street” nato nel Bronx che negli anni ’90 ha fondato “Stratton Oakmont” vendendo azioni per penny e truffando gli investitori e conducendo uno stile di vita pieno di eccessi, droga, prostituzione oltre che operazioni finanziarie scriteriate.
Il film racconta con un ritmo mozzafiato la storia dell’ascesa di questo uomo e la sua caduta. Di Caprio risulta credibile nel suo ruolo e New York, in particolare Wall Street fa da sfondo sociale a tutta la storia.
chi come me ha vissuto tra gli anni ’80 e ’90 non può dimenticare la scena di Ghost famosa per demi Moore che lavora il suo vaso con l’abbraccio emotivo del suo fidanzato morto pochi giorni prima… Al dilà della favoletta strappalacrime comunque ben raccontata, forse non tutti ricordano che anche questo film era girato a New York e molte scene erano ambientate nella Subway, sui treni lerci e arrugginiti e nei corridoi fatiscenti della metropolitana… E noi in questo Viaggio Fotografico useremo più volte al giorno la metropolitana, la vivremo e sarà per noi un modo di viaggiare ancor prima che un mezzo di trasporto. La metropolitana di New York è un viaggio nel viaggio e se vuoi approfondire questo aspetto del viaggio te ne parlo qui in QUESTO ARTICOLO.

 Erano i rampanti anni ’80 e io guardavo quelle foto di Venezia scattate durante il Carnevale alla fine degli Anni’70. Sono passati quasi 40 anni e quelle immagini ci portano ad una Venezia che non c’è più. La Venezia di Fulvio Roiter infatti è una Venezia ancora relativamente poco turistica.
Erano i rampanti anni ’80 e io guardavo quelle foto di Venezia scattate durante il Carnevale alla fine degli Anni’70. Sono passati quasi 40 anni e quelle immagini ci portano ad una Venezia che non c’è più. La Venezia di Fulvio Roiter infatti è una Venezia ancora relativamente poco turistica. Nelle sue immagini ci sono vastissimi scorci della città quasi completamente deserta, oggi sarebbe impensabile per chiunque poter pensare di scattare foto di giorno con Piazza San Marco vuota e senza turisti.
Nelle sue immagini ci sono vastissimi scorci della città quasi completamente deserta, oggi sarebbe impensabile per chiunque poter pensare di scattare foto di giorno con Piazza San Marco vuota e senza turisti. Appena ho saputo della sua morte, che è stata oggi 19 aprile 2016 all’età di 89 anni, sono andato a cercare il suo libro che avevo gelosamente conservato in tutti questi anni e puntualmente l’ho ritrovato dopo 4 traslochi esattamente dove doveva stare, insieme agli altri libri della stessa Collana dei Grandi Maestri dei Fratelli Fabbri Editori. Si trovava in ottima compagnia, a stretto tra le copertine di Tina Modotti e Jeanloup Sieff (in ordine alfabetico) e poco più in là della stessa serie c’erano David Hamilton, Cartier Bresson e altri illustri colleghi. Stranamente il nostro Roiter era l’unico con la copertina grigia invece che nera… “Serie Argento“….
Appena ho saputo della sua morte, che è stata oggi 19 aprile 2016 all’età di 89 anni, sono andato a cercare il suo libro che avevo gelosamente conservato in tutti questi anni e puntualmente l’ho ritrovato dopo 4 traslochi esattamente dove doveva stare, insieme agli altri libri della stessa Collana dei Grandi Maestri dei Fratelli Fabbri Editori. Si trovava in ottima compagnia, a stretto tra le copertine di Tina Modotti e Jeanloup Sieff (in ordine alfabetico) e poco più in là della stessa serie c’erano David Hamilton, Cartier Bresson e altri illustri colleghi. Stranamente il nostro Roiter era l’unico con la copertina grigia invece che nera… “Serie Argento“….
Riceviamo da Donatella Bisutti un bel contributo, un racconto vissuto in prima persona di un viaggio fatto con Fulvio Roiter. Un pezzo di vita vera, il ritratto di un grande Fotografo
RICORDO DI FULVIO ROITER – UN VIAGGIO IN CAPPADOCIA
Ieri è morto a 89 anni un grande fotografo, Fulvio Roiter. Abitava da anni al Lido di Venezia ed era diventato famoso soprattutto per le foto che aveva dedicato a Venezia e al suo Carnevale. Ma in realtà per anni la sua grande passione era stata viaggiare e aveva percorso mezzo mondo ricavandone una serie di libri fotografici che si distinguevano per il rigore e l’originalità compositiva con cui trasformava il reportage in opera d’arte secondo uno stile del tutto personale. Roiter era in certo modo un “pittore della fotografia”.
Io l’avevo conosciuto tantissimi anni fa e da allora eravamo diventati amici, anche con la moglie belga. Io allora ero una ragazza molto giovane e, per circostanze familiari – mio padre aveva fondato a Istanbul una società per conto della Pirelli – abitavo con i miei in Turchia, un Paese che mi affascinava e a cui per questo mi sento ancora legata. Ma siccome volevo tornare in Italia e costruirmi una vita mia – mi ero appena laureata, in Belgio, sempre per via del lavoro all’estero di mio padre – e sognavo di diventare giornalista, scrissi di mia iniziativa il diario di un viaggio alla scoperta delle antiche colonie greche dell’Asia minore, principalmente Smirne ed Efeso. Allora non c’era in quella regione alcuna attività turistica e gli archeologi francesi e tedeschi stavano solo cominciando a disseppellire rovine che ridisegnavano quelle città facendole risorgere da un paesaggio deserto, da cui nei secoli il mare si era ritirato. Fu così che scoprii, tra parentesi, l’archeologia – che fino ad allora avevo associato al chiuso un po’ muffito dei musei – come un’eccitante avventura. Mandai questo articolo all’unica rivista che avevo allora a portata di mano, e cioè alla rivista Pirelli, una rivista insigne che per qualche tempo aveva avuto come direttore anche un grande poeta come Vittorio Sereni. Il direttore di allora che credo fosse Castellani, dopo aver precisato che non pubblicava l’articolo per via di mio padre ma perché gli era piaciuto – e questo mi riempì di orgoglio, e riempì mio padre di stupore – a riprova di questo fatto inviò sul campo Fulvio Roiter che allora era ovviamente un giovane fotografo . Lui arrivò con la moglie Louise detta Lu, che per combinazione era belga, Paese in cui io avevo vissuto per anni. Facemmo subito amicizia. Fulvio Roiter allora non era ancora famoso, ma chi se ne intendeva lo considerava già un grande fotografo. Lui e la moglie erano una giovane coppia povera, perché lui era molto selettivo: non voleva lavorare per giornali e settimanali come avrebbe potuto, ma solo per due riviste che secondo lui gli davano la garanzia di una qualità di stampa ottimale, la rivista Pirelli appunto e la storica rivista svizzera Du. Avendo pochi soldi alloggiarono in qualche sorta di ostello e ricordo che venivano a fare la doccia a casa nostra.
Insomma Fulvio arrivò in una tenuta un po’ hippy e subito disse: ok, ho letto l’articolo e vado a fare le foto in Asia minore, però tu devi scrivere un altro articolo sulla Cappadocia e insieme dobbiamo andare a Goreme. Goreme oggi è famosa per le sue chiese e abitazioni scavate nel tufo ed é una delle mete turistiche privilegiate in Turchia, sfondo per ambientazioni cinematografiche. Ma allora nessuno ne sentiva parlare. Io c’ero stata qualche tempo prima con un gruppo della cosiddetta colonia italiana locale, che comprendeva alcune persone di origine italiana che vivevano a Istanbul o ci erano venute per lavoro, come un simpaticissimo professore di matematica napoletano che insegnava al liceo italiano, liceo che esiste credo ancora oggi. Avevamo noleggiato uno scassatissimo pullman e avevamo affrontato un viaggio non da poco. Di turisti nemmeno l’ombra. Credo che fummo i primi ad arrivare a Goreme. Ricordo che ci facevano entrare nelle case e ci facevano sedere a un tavolo, ci portavano frutta, dolci e loro in piedi ci circondavano e ci guardavano mangiare.
Le donne ci toccavano i vestiti per vedere com’erano fatti , palpare la stoffa, e siccome allora andavano di moda in Italia delle sottogonne di una sorta di crinolina, ci sollevavano le gonne per guardare sotto e così anch’io ne approfittai e scoprii che i loro pantaloni “turchi” erano in realtà gonne cucite nel mezzo.
Tornando a Roiter, non era possibile dirgli di no, anche se era estate e c’erano più di quaranta gradi. A Istanbul era arrivato anche il mio fidanzato, poi diventato mio marito, e mio padre gli affidò la sua macchina con mille raccomandazioni. Così partimmo in quattro per un viaggio di mille chilometri che si rivelò una vera avventura. Un’avventura indimenticabile. Il viaggio procedeva a rilento, perché Fulvio ogni poco gridava a Roberto di fermarsi perché aveva visto qualcosa da fotografare e si buttava fuori dalla macchina con la sua Canon appesa al collo. Ma non era mai questione di un attimo, perché lui, proprio come un pittore, non accettava la realtà com’era, ma voleva crearla. Per esempio vedeva alcune donne che lavavano i panni in un torrente, però non formavano quella composizione che aveva in mente lui, e che si ispirava a un’idea grafica, in cui la natura e la presenza dell’uomo si accordavano in una forma che tendeva all’astrazione. Allora lui si metteva in attesa, e noi con lui, ma chiaramente con un interesse minore del suo. Tuttavia non c’era verso di smuoverlo, finché spontaneamente le figure del quadro non avessero assunto le posizioni e il ritmo giusto. Chiaro che non bisognava avere fretta. Finalmente scattava e potevamo ripartire.
A questo ritmo arrivammo all’ora del tramonto in vista di Goreme, dove sapevamo esistere da poco una piccola locanda. Ci stavamo inoltrando nel paesaggio lunare di Goreme, fra pareti e coni di tufo rosato perché illuminato dalla luce obliqua del tramonto, quando con un soprassalto una scena magica, a una curva, si presentò davanti ai nostri occhi: la Fuga in Egitto!
Su un asinello che procedeva lungo il bordo della strada, davanti a noi, c’era una donna vestita come la Madonna di azzurro, con il capo ricoperto di una stoffa bianca che le scendeva a guisa di velo lungo le spalle, l’asino era condotto dal marito che camminava a piedi tenendolo per la cavezza. Fermo! gridò immediatamente Fulvio e la nostra macchina si arrestò di botto, mentre lui come un pazzo si buttava sulla strada e cominciava a fotografare. Ma l’uomo, infastidito, subito aveva fatto cenno alla moglie di nascondere il viso e lei aveva girato il capo verso la parete di tufo , dandoci le spalle e stringendosi addosso il velo bianco, mentre l’uomo pungolava l’asino perché si affrettasse ad allontanarsi e intanto faceva segno a Fulvio di smettere, di andarsene, con aria va via più minacciosa. Fulvio!, lo chiamammo io e Lu, preoccupate. Ma lui niente. Non poteva perdersi una scena così. Tutto successe in un attimo: l’uomo aveva improvvisamente estratto una roncola e si stava gettando su Fulvio, in un secondo gli avrebbe forse staccato la testa. Lì ammirai la freddezza e la presenza di spirito di quello che allora era il mio fidanzato: poiché Fulvio e l ‘uomo si trovavano alle nostre spalle rispetto alla posizione della macchina ferma, lui innestò subitamente la retromarcia puntando con l’auto dritto contro l’uomo, che arretrò, e intanto passando accanto a Fulvio io e Lu lo afferravamo e lo trascinavamo dentro la macchina senza riguardo per la preziosa attrezzatura fotografica penzolante dal suo collo e sbatacchiata qua e là. Innesto della prima e via, mentre una pietra mancava di poco il lunotto posteriore dell’auto affidataci da mio padre con tante raccomandazioni .
Scendeva la sera, trovammo un luogo dove nasconderci e aspettare. Come entrare nel villaggio, ci chiedevamo, dove nel frattempo il vecchio doveva essere arrivato e aver dato l’allarme? Come saremmo stati accolti?
Decidemmo di aspettare il calare delle tenebre per raggiungere la locanda inosservati. E così andò. Eravamo in salvo. Ma l’indomani?
Anche qui ci venne in soccorso un’idea: chiedemmo al proprietario della locanda se poteva procurarci qualcuno del luogo che ci facesse da guida. E al mattino presto arrivò Mehmed , un ragazzo giovane, aitante e simpatico, che miracolosamente parlava anche inglese. Andammo a piedi all’interno del villaggio con lui, che coscienziosamente voleva illustrarci tutto quanto c’era da vedere. Davanti al nostro disinteresse per le sue spiegazioni, rimase perplesso e deluso, finché gli dicemmo la verità: in realtà quello di cui avevamo bisogno era una guardia dl corpo e anche qualcuno che persuadesse gli abitanti a farsi fotografare. Quando Mehmed ebbe capito, ritornò di buon umore e si divertì ad aiutarci: grazie ai suoi buoni uffici Fulvio poté fotografare tutti quanti. Mehmed salì in macchina con noi e cantava in turco delle ballate bellissime, ci eravamo affezionati a lui ed eravamo diventati amici. Con grande dolore apprendemmo pochi mesi dopo che era morto in un incidente stradale.
Donatella Bisutti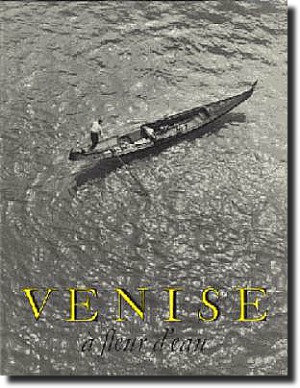 il Critico Michele Smargiassi su Repubblica.it pubblica su Fulvio Roiter un Articolo che puoi leggere cliccando qui.
il Critico Michele Smargiassi su Repubblica.it pubblica su Fulvio Roiter un Articolo che puoi leggere cliccando qui.

Non è facile raccontare l’India. Un Paese così vasto, quasi un continente, dalle infinite sfumature, ricco di contraddizioni e di profonda spiritualità, un mosaico di volti che si intrecciano.
L’India.
Una terra antica, capace di confondere e incantare allo stesso tempo.
Molte persone, quando sono tornata, mi hanno chiesto “Ma perché proprio l’India? E’ sporca, povera, inquinata”. Perché è un altro mondo, e quando viaggio cerco sempre di andare in posti lontani, non solo geograficamente, ma anche culturalmente. Perché sono affascinata dalla diversità. Per le contraddizioni di quel paese, i colori, le persone e la loro spiritualità.
Non è semplice spiegare perché si rimane rapiti dall’India, e per questo ho cercato di raccontarlo attraverso la fotografia. Le mie foto riguardano il popolo. Sono proprio le persone che ho incontrato, a farmi “dimenticare” che mi trovavo in un luogo sporco e povero, dove la miseria è ovunque e in ogni momento. Persone che accolgono un viaggiatore sconosciuto e mai viso prima, come se lo conoscessero da sempre.
Il mio viaggio, difficile e meraviglioso, inizia da Delhi, dalle sue baraccopoli e dal suo
caos. E’ un posto indimenticabile che sconvolge qualsiasi viaggiatore e che dà la sensazione di essere catapultati in un altro mondo, soprattutto per la povertà in cui versa molta gente.
Persone povere ma ricche di una dignità e una fierezza senza pari.
Sguardi profondi, mai indifferenti, dentro volti segnati dalle difficoltà della vita.
Donne avvolte in bellissimi sari colorati, bimbi curiosi di conoscerti e di sapere
da dove vieni e che cosa fai. Il colore non manca mai, è nei muri, negli abiti, negli sguardi: un inno alla vita.
L’India. Un paese in cui religione diventa ragione di vita, dove la spiritualità trova spazio nella quotidianità e trova il culmine in città sacre come Varanasi. E’ la città più antica al mondo ancora popolata, dove tutto ha una fine, ma anche un nuovo inizio. Bagnata dal sacro Gange, che accoglie i fedeli per purificazioni e battesimi, è il luogo in cui gli induisti vanno a morire, per poi essere cremati sulle sue rive, così da poter rinascere.
di Silvia Pasqual

Voglio parlarvi di questa mostra che ho visto nel 2013 a Parigi, a due passi dal Centre George Pompidou, durante quello che fu il primo Viaggio Fotografico della nostra storia. Il Viaggio si chiamava Parigi in Bianco e Nero e questa esposizione (a sua volta in Bianco e nero) la scoprimmo per puro caso durante le nostre visite in città.
A tre anni di distanza ho conservato il materiale e i riferimenti della mostra e ora che mi ritrovo tutto tra le mani mi torna in mente quella mostra e voglio raccontarvi le mie impressioni avute all’epoca.
“Nha Terra” – era il titolo della mostra di questo fotografo ossia la mia terra tradotto dal portoghese, che è la lingua parlata in Guinea Bissau.
Di mostre bellissime sull’Africa ne ho viste tante, a partire da quelle stranote di Sebastiao Salgado che contengono sempre delle sezioni incredibili sul Continente Nero, fino ad arrivare ai vari vincitori del World Press Photo che in un modo o nell’altro trattano altri temi legati alle migrazioni, a guerre, carestie, sfruttamenti e ogni altro genere di scempi fatti da noi occidentali direttamente o indirettamente ai danni degli Africani.
 Invece questa mostra di Nedjima Berder (totalmente sconosciuto nel panorama dei grandi nomi della Fotografia) mi colpì veramente. Mi colpì per il suo allestimento fatto all’interno della chiesa di Saint-Merry, già questo è un elemento di nota che da noi in Italia risulterebbe alquanto bizzarro se non addirittura impensabile. Una bella chiesa che accoglie una bella mostra. Viste le tematiche della mostra, anche la scelta del luogo mi sembra appropriata: un luogo nato per accogliere, che accoglie realmente. Un luogo per tutti che parla degli Ultimi. Al dilà della ritualità sacramentale, assistiamo qui alla condivisione di storie reali che raccontano e divulgano un mondo lontano al quale non siamo estranei.
Invece questa mostra di Nedjima Berder (totalmente sconosciuto nel panorama dei grandi nomi della Fotografia) mi colpì veramente. Mi colpì per il suo allestimento fatto all’interno della chiesa di Saint-Merry, già questo è un elemento di nota che da noi in Italia risulterebbe alquanto bizzarro se non addirittura impensabile. Una bella chiesa che accoglie una bella mostra. Viste le tematiche della mostra, anche la scelta del luogo mi sembra appropriata: un luogo nato per accogliere, che accoglie realmente. Un luogo per tutti che parla degli Ultimi. Al dilà della ritualità sacramentale, assistiamo qui alla condivisione di storie reali che raccontano e divulgano un mondo lontano al quale non siamo estranei.
Le immagini, se vogliamo, non sono neanche particolarmente originali e usano una tecnica che andava di moda forse una quindicina di anni fa: rendere una foto in bianco e nero lasciando solo un colore. Qui assistiamo alla stessa tecnica leggermente rivisitata che invece di un solo colore evidenzia un oggetto (con tutti i suoi colori) della foto nelle mani di uno dei soggetti ritratti.

La cosa che mi piace è che queste foto raccontano di un’Africa che esiste e che per fortuna pur vivendo con poco, non muore di fame. Le foto sono state scattate nei pressi di un mercato in Guinea Bissau, uno dei paesi più poveri al mondo, molti non sanno neanche esattamente dove collocarlo sul mappamondo, ma ci parlano della dignità di queste persone, e del loro rapporto con la terra e con ciò che mangiano. Sono infatti i ritratti dei contadini, pescatori o allevatori che vanno a vendere i loro prodotti al mercato.

Le foto non hanno le classiche pose da “Bambino povero che sorride” e neanche quelle altrettanto viste da “Disperato e perseguitato vittima di violenze e torture”. Qui vediamo gente fiera di vivere la propria quotidianità africana. Gente che ostenta la forza della natura della propria terra mostrandoci quanto questa sia generosa verso di loro donando abbondanza a costo zero, anche senza fatica.

I prodotti vengono sempre raccolti e presentati con una cura estrema, il loro basso valore economico viene invece venduto con la sconcertante semplicità di chi conosce solo la bellezza, la semplicità e la freschezza di quel poco che ha. E così vengono presentate enormi radici o mazzi di peperoncini, o il frutto di una pesca miracolosa portata in un mercato nel quale anche parlare di “banco” è una parola grossa.
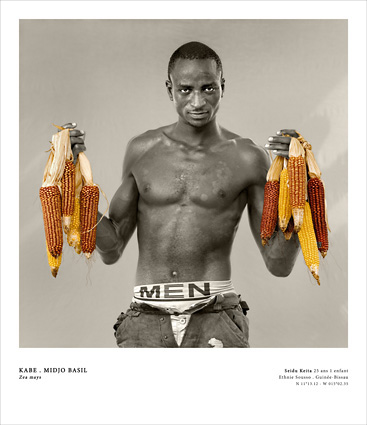
I fisici di queste persone hanno la forza e l’eleganza di chi vive in armonia con la natura, lontano dai grassi, lontano dagli additivi chimici. E’ chiaro l’intento selettivo del fotografo Nedjima Berder che sceglie con cura i suoi modelli per enfatizzarne la bellezza e la loro perfetta armonia e simbiosi con i luoghi in cui vivono. I suoi set sono fatti in luce ambiente, con uno sfondo bianco che rende asettico un angolo di mondo che sarebbe invece circondato da polvere e fango, perchè il Fotografo nel cercare l’immediatezza dei suoi scatti, riesce ad ottenere queste pose fermando i modelli per pochi secondi davanti al suo set mentre loro passano per andare a vendere le merci. Portarli in uno studio significherebbe perderne la spontaneità e l’innocenza. Fotografarli di sorpresa al volo porterebbe all’ennesimo scatto rubato che abbiamo già visto altre volte.

Nelle foto di Nedjima Berder troviamo l’intero ciclo della vita, che sfila davanti alla fotocamera. Taglio quadrato, oggettivo, simmetrico, semplice. I suoi modelli hanno qualsiasi età e vivono il lavoro e la vendita con dignità e non sono mai autocompassionevoli e autocommiserevoli. Nelle immagini di questo fotografo c’è l’inno alla fertilità intesa come riproduzione umana ma anche come frutti della terra. I frutti sono sempre enormi e generosi, colorati e allegri, sono essi stessi un inno alla vita e attraverso essi il fotografo ci trasmette tutta la sua passione per il continente nero.

Infine la scelta del fondale bianco. Anche questa è funzionale al discorso di semplicità che l’Autore si pone di trasmetterci. Un fondale diverso avrebbe portato lo sguardo dell’osservatore a distrarsi dal soggetto, a contestualizzare con altri riferimenti il senso della storia. Lo sfondo viene qui lasciato di un bianco naturale, con quelle tipiche imperfezioni e rugosità che rendono particolarmente unico e fascinoso il Continente Nero. Il bianco, poi, che si contrappone al nero della pelle, diventa anche una scelta grafica e formale di tutto rispetto. La scelta di non utilizzare Photoshop per scontornare il soggetto è, quindi tutt’altro che casuale per questo cameraman-documentarista che in questa occasione si è prestato alla Fotografia.

Ho amato particolarmente questa mostra, mi ha parlato di un’Africa che pensavo di conoscere, avendola a mia volta fotografata 15 volte, ma che in realtà non avevo mai visto così bella e raccontata in modo così originale. Mi piace questo lavoro fotografico, mi piace per la sua coerenza, per il suo stile, per la sua potenza visiva seppur ottenuta con mezzi essenziali e di basso costo. L’Africa ci insegna che la vita può scorrere anche in un altro modo, con lentezza, essenzialità, e senza sovrastrutture, questo Continente riesce sempre ad appassionare anche chi la conosce.
L’Africa sa raccontare storie senza parlare e sa far molto rumore anche senza muoversi.
Roberto Gabriele


Nessuno fermerà la mia scelta di essere felice da quando faccio colazione con la vita a quando chiudo gli occhi perché sono stanca di vita e ne voglio ancora di più per il giorno seguente.
 É proprio vero, prima di partire avevo mille perplessità ( non paure, perplessità!) ma ora che sono in viaggio, tutto è così semplice e…terribilmente fantastico, anche semplicemente la terra su cui poggio le mie Birkenstock(Grazie Rose!). Ogni qualvolta si crea un punto interrogativo sulla mia testa c’è la soluzione, c’é sempre la via di uscita e non é nemmeno troppo complicata!
É proprio vero, prima di partire avevo mille perplessità ( non paure, perplessità!) ma ora che sono in viaggio, tutto è così semplice e…terribilmente fantastico, anche semplicemente la terra su cui poggio le mie Birkenstock(Grazie Rose!). Ogni qualvolta si crea un punto interrogativo sulla mia testa c’è la soluzione, c’é sempre la via di uscita e non é nemmeno troppo complicata!
6mesi di libertà assoluta, senza regole, senza limiti, a braccia aperte ad accogliere tutto ciò capita, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. Mi sento una particella di vita, viva, selvaggia, che lascia tracce di cui un giorno essere orgogliosa!
6 mesi, spero possano diventare 6 anni o 60.. Nel contempo mi vivo a pieno ogni singolo istante!
E sapete qual’é la cosa più bella che sto riscontrando? Condivido giornalmente emozioni, paesaggi, stati d’animo con voi, voi, “perfetti sconosciuti” che vorrebbero intraprendere questo viaggio ma non sanno da dove iniziare. In realtà non lo so nemmeno io da dove ho iniziato.. So che ad un certo punto ho dato la disdetta del mio contratto di affitto, ho dato le dimissioni e sono partita.
Per dove sono partita? Beh inizialmente dovevo partire per l’Irlanda.. volevo ottenere la certificazione internazionale d’Inglese (avevo ancora piccoli dubbi che questa vita da backpackers potesse non piacermi), e mi sono ritrovata in Togo , ospite di un orfanotrofio con 12 splendidi bimbi. La mia prima destinazione dopo il Togo, doveva essere la Spagna e poi il Brasile.. Beh sono in Africa, in Namibia..e domani lascerò questa terra alla volta di Cape Town in Sudafrica. Una cosa che ho imparato: lasciarmi andare al viaggio e cogliere tutti i segnali che il viaggio stesso mi manda.
Come viaggio? L’ultimo volo per la Namibia, d’ora in poi solo via terra/mare. Per passare la frontiera Sudafricana domani ad esempio ho trovato un bus con Intercape a bassissimo costo che mi porta laggiù.. certo con i tempi africani, resterò in viaggio per 22 ore, ma questo è il prezzo da pagare se si vuole viaggiare con lentezza. Ed io ne sono felice. In ogni caso, con auto locali, taxi, taximoto e capitato autostop, ma in Africa non è molto usato questo autostop.
 Dormire e mangiare, come fai? In Africa è poco diffuso lo scambio di vitto e alloggio con qualche piccolo lavoretto, ma ho trovato chi ha accettato lo scambio. In caso contrario devo prendere un ostello, o una tenda.. insomma qualcosa dove poter passare la notte. Anche un divano di uno sconosciuto come ho fatto con il mio amico Dominik (ragazzo che ho conosciuto in Windhoek). Non è semplice, ma in questo ultimo anno ho imparato, credo, a chiedere e devo dire che a parte pochi casi, spesso mi va bene :), é anche vero che la faccia tosta non mi manca. Mi è capitato di lavorare in una casa per un paio di giorni, stavano facendo gli scatoloni per un trasloco o in un ostello (con delle colazioni fantastiche) e ero addetta al lavaggio piatti per tuta la durata delle colazioni..Insomma nulla di pesante e faticoso. Certo bisogna capire qual’è lo scopo del vostro viaggio, se riposare oppure realizzare un sogno.
Dormire e mangiare, come fai? In Africa è poco diffuso lo scambio di vitto e alloggio con qualche piccolo lavoretto, ma ho trovato chi ha accettato lo scambio. In caso contrario devo prendere un ostello, o una tenda.. insomma qualcosa dove poter passare la notte. Anche un divano di uno sconosciuto come ho fatto con il mio amico Dominik (ragazzo che ho conosciuto in Windhoek). Non è semplice, ma in questo ultimo anno ho imparato, credo, a chiedere e devo dire che a parte pochi casi, spesso mi va bene :), é anche vero che la faccia tosta non mi manca. Mi è capitato di lavorare in una casa per un paio di giorni, stavano facendo gli scatoloni per un trasloco o in un ostello (con delle colazioni fantastiche) e ero addetta al lavaggio piatti per tuta la durata delle colazioni..Insomma nulla di pesante e faticoso. Certo bisogna capire qual’è lo scopo del vostro viaggio, se riposare oppure realizzare un sogno.
Siccome voglio fare questa vita tutta la vita, dovro’ in ogni caso cercare lavoro se voglio continuare nella mia impresa.
Ah, sono sempre pronta a ricevere contatti di amici/parenti/amici di amici che possono ospitarmi ![]()
Testi e foto dell’Autrice: Francesca Naglieri
Vai al suo Blog: http://www.viaggiavolavivisogna.it/sei-mesi-in-viaggio/
Francesca Naglieri è Blogger, Viaggiatrice, esperta di Viaggi e Turismo


C’è sempre un motivo, c’è sempre un’emozione che ti fa scegliere di fare un Viaggio piuttosto che un altro… Un Viaggio non si sceglie per segnare un’altra bandierina sulla mappa del mondo, lo fai perchè è quel viaggio stesso a chiamarti a sè. Non sei tu a sceglierlo.
Io, ad esempio, ho fatto gli USA dopo aver scoperto nel mio DNA la mia essenza di Viaggiatore On the Road dopo aver visto decine di film che avevano come protagonisti non dei personaggi, ma i LUOGHI del no where americano, la grande Provincia, i deserti e i Parchi. Le storie raccontate in questo genere cinematografico sono storie fatte di viaggi e di strade, di incontri e di percorsi interiori alla scoperta di se stessi in nome di un protagonista assoluto che è il valore della LIBERTA’. Già…. La libertà…. E’ questo il motore che spinge il Viaggiatore On the Road a ricercare dentro se stesso ciò che a casa non trova, ciò che a casa non riesce ad essere. Il Viaggio diventa quindi lo strumento a nostra disposizione per incontrare noi stessi.
I film di cui ti voglio parlare in questo Articolo forse già li conosci, forse li hai già sentiti nominare o li hai visti, ma sono tutti film con i quali sono cresciuto e ho sognato di partire per un Viaggio da quelle parti. Speravo di fare almeno una volta nella vita un viaggio negli USA, e finora ci sono stato già 8 volte, di cui 2 viaggi Coast to Coast su strada, sognando la libertà, sognando i grandi spazi e il sole brillante di quelle parti di mondo… E altre 6 volte a New York.
La ricerca che ho fatto stavolta è per lasciar parlare le immagini, per darti un pò di spunti per sognare, per misurare il tuo DNA da Viaggiatore On the Road. Questo Articolo quindi non è da leggere, ma da godere, accendi le casse del tuo computer e mettiti comodo., ci metterai un pò a rivedere tutte queste scene, ma ne varrà sicuramente la pena…
Guarda gli spezzoni qui sotto e vota il tuo film preferito! Non vinci nulla e non cambierà nulla nella tua vita, ma scopriremo insieme quale è tra questi il preferito dai nostri lettori…
Non potevo che iniziare da questo film. Nel 1991 avevo 23 anni, ancora studiavo al primo anno di scuola di Fotografia e per la prima volta iniziai a sognare l’America On the Road… Due donne normali che si trovano ad essere braccate dalla polizia in seguito ad eventi normali che hanno avuto delle conseguenze esagerate nella loro vita. Un finale degno di un GRANDISSIMO FILM che ha lasciato il segno nella Storia del Cinema. Libertà dagli uomini, libertà dalle leggi, un viaggio fino alla libertà di scegliere se vivere o morire. Nota: il film contiene uno dei primi Selfie della storia, realizzato con una Polaroid che a quei tempi era di gran moda…. Anche questo un segno iniziatico per la mia carriera di Fotografo che era allora ancora in formazione…. Alcune scene assolutamente esaltanti di vita On the Road, una di queste te la ripropongo qui sotto…
Anche questo film ha avuto per me una sorta di rito di iniziazione al cinema su strada, al viaggio in quanto tale. La storia la ricorderete tutti, due fratelli (di cui uno autistico geniale) si incontrano dopo la morte del padre, e devono attraversare l’America in auto perchè l’autistico aveva il terore di volare in aereo e costringe il fratello a guidare. I due naturalmente vivono nel viaggio una serie di incontri e di esperienze che hanno molto più valore del viaggio stesso. Tom Cruise scopre grazie a Dustin Hoffman i valori della famiglia e il piacere di viaggiare lentamente. Io da questo film ho imparato più di Tom Cruise su ciò che erano i temi del film! Anno 1988, ancora prima di Thelma & Louise, ma fu per me solo un inizio, non una svolta nella mia vita.
1997, era già passato qualche anno…. Ancora guardavo i film e sognavo, i tempi per partire ancora non erano maturi per me…. In pochi conoscono questo film di Oliver Stone con Jennifer Lopez e Nick Nolte. Film molto divertente e, altrettanto, decisamente “fastidioso” per la storia che riguardava una specie di povero gangster (Sean Penn) piuttosto sfortunato che vede la sua vita bruciarsi con una serie di sventure che gli capitano in poche ore e che lo porteranno a fuggire da quelli della sua banda. La cosa bella di questo film è che è girato in Arizona, nelle zone che vedremo durante il nostro Viaggio Fotografico Deep South ad agosto 2015. Qui sotto Vi propongo il trailer oppure la versione integrale del film. Se avete un pò di tempo guardatelo, ne vale la pena…
Vai al film: http://it.wikipedia.org/wiki/U_Turn_-_Inversione_di_marcia
Guarda qui sotto la versione integrale e SE VUOI PARTIRE CON NOI CLICCA SU QUESTO LINK.
E chi se lo sarebbe immaginato nel 1994 che dopo aver visto questo film di Quentin Tarantino sarei diventato un suo fan? Così è stato. Questo NON è un film esattamente On the Road come gli altri, qui voglio condividere alcune scene che si svolgono nelle strade della California e che danno una visione decisamente personale degli Stati Uniti fino ad arrivare alla notissima scena di Mister Wolf che “risolve problemi”.
Iniziamo con la scena della declamazione dei versetti del Libro di Ezechiele fatta durante una vera esecuzione.
Passiamo poi ad un “incidente” che darà luogo alla scena poi di Mister Wolf
Trovo esilaranti i dialoghi surreali di questa scena sul chopper e la colazione della ragazza dopo che Bruce Willis aveva appena ucciso un uomo e stava fuggendo dalla città.
E questo è il finale di Mister Wolf che non poteva mancare nella mia carrellata di Pulp Fiction.
Anno 1989, a Roma questo film arrivò nelle sale a febbraio 1990 e lo vidi mentre ero militare in Marina, naturalmente andai da solo a vederlo perchè all’epoca i film che si vedevano con i Commilitoni erano di tutt’altro genere e, per così dire, riservati solo ai Militari….. Scelsi bene. Questo film mi cambiò la vita. Uno dei film più divertenti che abbia mai visto. Qui torniamo a parlare dell’America On the Road: i due ragazzi si incontrano a Chicago per condividere un viaggio in auto fino a New York. 18 ore di guida da fare con uno sconosciuto che si rivelerà per loro essere l’inizio di un lungo percorso che va ben oltre la destinazione raggiunta.
Iniziamo con la prima scena del film, è l’incipit da cui parte tutto. Siamo in auto, proprio all’uscita da Chicago, all’inizio del loro viaggio, inizia l’America on the Road. Iniziano i dialoghi tra i due definendo i ruoli di viaggio e nella vita…
Il Viaggio in auto dà modo di parlare, di conoscere l’altro e se stesso. Vedendo scene come questa che segue ho iniziato fortemente a desiderare di andare in America. Cosa non avrei fatto all’epoca per partire apposta dall’Italia, andare a mangiare in un ristorantino come questo. Poi, per fortuna ci sono stato tante volte e ci torneremo anche ad agosto con il nostro Viaggio Fotografico nel Deep South.
Purtroppo non sono riuscito a trovare scene in italiano delle parti di questo film girate On the Road. Accontentatevi di questo stralcio di America vera e Sociale. Il film racconta la storia di una famiglia in viaggio verso il sud degli Stati Uniti per portare una bambina ad un concorso di bellezza che, viste le sue caratteristiche, difficilmente riuscirà a vincere. Uno spaccato di vita familiare il cui racconto si snoda lungo le strade assolate che portano dal New Mexico alla California.
Questo film l’ho visto solo di recente, dopo essere già andato negli USA diverse volte, è la quintessenza del viaggio On the Road americano, è il film simbolo degli Anni ’70, dei bikers e delle loro roboanti Harley Davidson che sfrecciano lungo le strade nei deserti del West americano in totale libertà. Vedendo questo film ti verrà la voglia di attraversare l’America su due ruote…
Una sorta di parodia di Easy Rider, rivisto in chiave comica 30 anni dopo. Un film gustoso da vedere che ha scene divertentissime di questi motociclisti piuttosto inesperti. L’altro lato dell’America borghese e irrealizzata in cerca di emozioni forti senza essere preparati alla sfida che li aspetta rendendosi anche goffi e correndo qualche rischio. Anche in questo caso, scopriamo la voglia di viaggiare in libertà, concetto a quanto pare di largo interesse nel cinema americano…
Il Viaggio portato alle estreme conseguenze nella più selvaggia natura americana. Film straordinario con meravigliose ambientazioni nei Parchi americani. Una storia vera, straordinaria e incredibile di un Viaggio in Solitaria vissuta da un ragazzo che sceglie il Viaggio come stile di vita e non come vacanza. Per gli amanti dell’avventura, per chi vuole stare a contatto con la perfezione e l’infinito.
Altro Viaggio lontano dalle strade ma nell’America di Indiani e Cow Boys, nel Deep South degli USA: quattro amici quarantenni si trovano a fare il punto della loro vita durante una vacanza a cavallo in cui devono accompagnare una mandria di vacche attraverso le grandi praterie. Film bellissimo fatto di dialoghi intensi come questo che ti suggerisco di vedere.
La musica è la protagonista di questo film che racconta il Viaggio di una giovanissima promessa del Blues che sceglie di seguire il suo mentore in viaggio, un musicista molto più anziano di lui che sarà per il ragazzo un Maestro di vita più che un maestro di musica. Il titolo Crossroads è riferito all’incrocio tra le Highway 61 e 49 in cui nasce la cittadina di Clarksdale famosa per il più importante Festival Blues del mondo. Vivere quei posti è entrare nel mito americano.
Di nuovo sulla strada, di nuovo a raccontare una storia fatta al volante, la storia di due pazzi cocainomani che assumono impressionanti mix di ogni tipo di sostanze psicotrope durante il loro soggiorno a Las Vegas. Storia surreale legata alle strade americane. Un film relativamente poco noto, da scoprire e apprezzare in questo breve trailer.

La mostra allestita al Museo di Roma in Trastevere

Finalmente si è ridotta la quantità di sangue e di morti esposti e vincitori delle passate Edizioni del World Press Photo!
Diciamolo, da appassionati di questo genere fotografico, da cultori del Reportage, da frequentatori di mostre e fedelissimi proprio di World Press Photo, possiamo dire che le ultime Edizioni di questo prestigiosissimo Premio Fotografico si erano caratterizzate per essere ogni anno delle lunghe carrellate di morti e di sangue, di esplosioni e di violenze. Fatte salve le foto sportive, per anni l’attenzione era concentrata sulla crudezza delle immagini.
L’Edizione 2015 invece si è contraddistinta a mio avviso per un deciso cambio di stile e di tecnica che è servito a smorzare i toni e a far vincere la bella fotografia.
 Foto: © Darcy Padilla
Foto: © Darcy Padilla
Come sappiamo la Fotografia, come qualsiasi altro linguaggio si evolve, qualcuno direbbe che segue le mode, ma io preferisco vederne l’evoluzione e il cambiamento e pensare che siano le mode a seguire i linguaggi visivi e non il contrario. Ricorderai quando negli anni ’70 a Roma si diceva “‘na piotta” per indicare 100 lire, o quando dopo il film di Carlo Verdone le parole più ricorrenti tra i giovani erano “un sacco bello” e “cioè”… Ecco…. Ora queste espressioni non hanno più alcuna rilevanza nel lessico quotidiano e da fenomeno di costume che erano all’epoca, un diciottenne di oggi non sa neanche a cosa si faccia riferimento. In fotografia è accaduta la stessa cosa. Anni fa si parlava di Analogico/Digitale per chi era a favore del vecchio o del nuovo. Ora nessuno più si pone il problema. Semplicemente sono rimaste alcune persone a volersi divertire a scattare in pellicola non più come preferenza, ma solo per piacere personale. Tutto si evolve.
 Foto: © Anand Varma
Foto: © Anand Varma
Anche i linguaggi delle foto esposte e premiate al World Press Photo di quest’anno sono evoluti e influenzati dalla presenza di uno strumento di ripresa che fino allo scorso anno non era mai stato presente e del quale fino a 2 anni fa non si sentiva neanche parlare… Ora i costi di questi strumenti sono crollati, sono diventati oggetto di uso comune in pochi mesi e i lavori fatti con essi iniziano a diventare Fotografie d’Autore e non solo mezzi tecnici di ripresa. Si sta insomma evolvendo un vero e proprio nuovo stile fotografico assolutamente inimmaginabile e impensabile fino alla loro invenzione. Naturalmente sto parlando dei Droni!

Il Drone insomma quest’anno è sbarcato al World Press Photo 2015 dimostrando che nelle mani di un bravo fotografo questo strumento di ripresa diventa un potente mezzo espressivo e non solo un mero metodo di rilievo dall’alto. Ma la foto qui esposta non è l’unica che sia stata fatta con questa tecnica. E tutte quelle esposte sono davvero spettacolari, ci propongono una visione del mondo a volo d’uccello, a bassa quota e in modo del tutto insolito per la nostra visione umana. Il drone insomma trova una sua collocazione come quella a suo tempo trovata dalla macrofotografia o dall’utilizzo di sensori ad alti ISO che hanno fatto dimenticare l’uso dei flash in modo quasi naturale e senza alcun rimpianto. E l’abbassamento dei costi di acquisto di un drone ne hanno facilitato la diffusione, solo due anni fa il costo di un drone professionale era di 20.000 Euro, oggi con 5.000 Euro hai una versione ancora superiore, stabilizzata e più evoluta rimanendo sempre tra le apparecchiature professionali senza scendere in qualcosa che sia ben sotto i 1000 Euro ma che è un giocattolo evoluto, in grado di fare il suo lavoro, ma non in modo professionale.
[caption id="attachment_14719" align="aligncenter" width="640"] Foto: © Massimo Sestini
Foto: © Massimo Sestini
L’altro elemento caratteristico che mi ha colpito quest’anno è stato un minore uso di Photoshop, meno saturazioni esagerate, meno forzature nelle desaturazioni, ma un più autentico lavoro di pulizia e naturalezza dell’immagine. Anche qui il segno di un mondo che cambia. Anche nel caso dell’uso degli strumenti di correzione cromatica nelle precedenti Edizioni si è parlato a lungo in questi anni: foto eliminate “per eccessivo uso di Photoshop” fotografi radiati dall’Ordine dei Fotogiornalisti per aver eliminato parti di foto con il “Timbro clone”, ecco di queste cose e queste polemiche quest’anno non se ne sono viste. Non credo che i Fotografi abbiano capito la lezione dagli episodi citati. Credo che invece anche lo stile e il modo di usare gli strumenti preesistenti sia una naturale evoluzione dell’Arte fotografica. Quando i Fotografi (di bassa lega) iniziarono a scoprire Photoshop, qualche anno fa, il primo istinto era quello di stravolgere completamente la gamma tonale delle foto aumentando i contrasti, solarizzando le foto fino a renderle “alla Andy Warhol” e “drammatizzarle” il più possibile giustificando il loro operato con “Mi piacciono le tinte forti o le ombre profonde” o in altri casi dicendo:”preferisco sottoesporre”….

Quest’anno per magia il trend è andato verso la natura e la naturalezza dei toni cromatici, delle ombre, delle luci. Abbiamo visto immagini di ottima qualità, belle, ma senza clamori. Sono mancate, per fortuna le forzature cui eravamo abituati e alle quali iniziavamo a stancarci da tempo. L’uso di Photoshop non è stato bandito, ci mancherebbe, ma è servito più a “pulire” le immagini che non a caricarle, come si dice: “il trucco c’è ma non si vede”.

quest’anno sono arrivate in Giuria 97.912 foto inviate da 5.692 fotografi professionisti di 131 Paesi diversi.
La giuria ha creato 8 categorie: Spot News, Notizie Generali, Storie d’attualità, Vita quotidiana, Ritratti, Natura, Sport, Progetti a lungo termine. Sono stati premiati 41 fotografi di 17 diverse nazionalità: Australia, Bangladesh, Belgio, Cina, Danimarca, Eritrea, Francia, Germania, Iran, Irlanda, Italia, Polonia, Russia, Svezia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.
La Foto dell’anno 2014 è del danese Mads Nissen. L’immagine mostra una coppia gay russa in intimità.
Nove i fotografi italiani vincitori: Fulvio Bugani, Turi Calafato, Giulio Di Sturco, Paolo Marchetti, Michele Palazzi, Andy Rocchelli, Massimo Sestini, Gianfranco Tripodo e Paolo Verzone.
L’Agenzia Contrasto si è aggiudicata due premi assegnati a Michele Palazzi (Primo Premio, Vita quotidiana, Storie) e Gianfranco Tripodo (Terzo Premio, Notizie generali, Foto singole).


Quando si pensa all’India, immediatamente si pensa al COLORE in tutte le sue forme: gli sgargianti Sari che le donne di ogni casta e ceto sociale indossano sempre con grande grazia ed eleganza, i TEMPLI induisti tempestati di migliaia di decorazioni e divinità colorate, le SPEZIE, che caratterizzano tutti i piatti tradizionali e che sono le protagoniste degli affollatissimi mercati con tutte le gradazioni del rosso e del giallo… insomma l’India senza colori non sarebbe l’India!!!
Ma c’è un periodo dell’anno, che corrisponde all’inizio della primavera, in cui l’esplosione di colori assume la sua massima potenza: si tratta di HOLI, il festival dei colori più famoso del Mondo, durante il quale migliaia, se non milioni di persone, scendono in strada imbrattando con polveri colorate chiunque capiti a tiro.
E’ una delle feste più antiche della mitologia Indù, e viene celebrata il giorno successivo alla prima notte di luna piena nel mese di Phalgun, che segna anche l’inizio della primavera.
Holi significa ‘bruciare’ e trae origine dalla leggenda di Holika: durante la sera della luna piena, si accendano infatti falò per allontanare gli spiriti e celebrare la Vittoria del Bene sul Male.
Il rito ricorda anche la miracolosa fuga del giovane Prahalad, devoto di Vishnu, dalla demone Holika che voleva darlo alle fiamme: Prahalad grazie alla sua fede in Vishnu scampò illeso mentre Holika morì arsa.
Il giorno successivo all’accensione dei falò la gente si ammassa per il lancio di acqua e polveri colorate per le vie delle città e nei villaggi.
La Leggenda di Radha-Krishna ricorda proprio il lancio di colori: il giovane Khrisna, geloso dell’amata Rada per la bellezza della sua pelle, le dipinse tutta la faccia.
Così, i Templi durante Holi sono decorati con i colori e un idolo di Radha sull’altare.
Nel nostro Viaggio Fotografico abbiamo partecipato con grande entusiasmo, divertimento e qualche piacevole sorpresa ai festeggiamenti di questa fantastica festa dalle lontane origini religiose.
Il nostro Holi è iniziato in un piccolissimo Tempio della bellissima Bundi, nel cuore del Rajastan dove siamo stati invitati a partecipare ad una loro cerimonia. Siamo stati accolti con grande calore e subito coinvolti a stare in mezzo alla folla ed a ballare con loro. Non c’era differenza tra loro e noi, eravamo lì, ballavamo e scattavamo foto, quando improvvisamente, senza accorgercene, eravamo completamente colorati! Mancava ancora qualche giorno ad Holi, quindi non eravamo assolutamente preparati a ciò che ci avrebbe attesi. Avevano infatti iniziato a lanciare prima fiori e poi polveri di tutti i colori trasformando il Tempio in un fantastico e gioioso arcobaleno!
Per fortuna siamo riusciti a salvare in qualche modo le fotocamere che non avevamo avuto modo di proteggere con le migliaia di buste che avevamo portato proprio per l’occasione.
Tra i partecipanti alla festa c’era anche un fotografo indiano che ci ha scattato qualche foto con la promessa di inviarcele via mail… certo non ci aspettavamo che quelle foto erano destinate ad una delle più famose testate del Rajastan!!!!
Dopo questo primo assaggio di Holi a Bundi, siamo andati a Jaipur dove abbiamo partecipato ai falò sulle strade della città e ci siamo immersi il giorno dopo nei veri festeggiamenti trasformandoci in divertite macchiette colorate! In giro per la città sui risciò ci fermavamo non appena individuavamo situazioni interessanti anche dal punto di vista fotografico… ma non facevamo a tempo a scendere che le nostre facce ed i nostri vestiti venivano ricoperti di ulteriori strati di colori fino a renderci assolutamente irriconoscibili!
E’ stata una bellissima esperienza che ripeteremo sicuramente il prossimo anno e che spero possa essere di augurio per un anno pieno di gioia e colori per tutti!


Ogni anno, ad agosto la piccola cittadina di Clarksdale in Mississippi diventa la Capitale del Blues diventando la sede del più grande festival del mondo dedicato a questo genere musicale quando dai 17.000 Abitanti la cittadina esplode a oltre 100.000 durante il Sunflower Blues Festival…
Ci troviamo nel sud degli Stati Uniti d’America, in quelle zone dove tra il XVI e il XIX secolo vennero portati gli schiavi dall’Africa per coltivare il cotone negli immensi campi dei bianchi che abbiamo visto in film come Via col vento…. La cosa bella è che da quelle parti vivono ancora oggi quasi esclusivamente i discendenti di quegli stessi schiavi. Gli americani che sono lì sono tutti neri e hanno i tipici caratteri somatici africani, da questa gente e dalle loro storie è nato il blues, la più “malinconica” musica americana.

Partecipare al Sunflower diventa quindi un modo non solo per ascoltare i migliori musicisti del mondo di questo genere che è nato qui da loro e dai loro padri, ma è anche un modo per conoscerli dal vivo. I Bluesman non sono certo persone schive, nè divi del Rock che devono tenere a distanza i loro fans. Venendo al Festival Vi capiterà, di sedervi accanto a loro la mattina dopo al bancone di un saloon e di mettervi a chiacchierare con loro e magari di ricevere un Cd in omaggio in cambio del tuo indirizzo email. Ed è proprio quello che è successo a noi con Josh “Razorblade” Stewart del quale puoi ascoltare le note che abbiamo registrato dal vivo durante il suo concerto…. Clicca sul player qui sotto e inizia a sognare…

Già all’entrata in città ti capiterà di accorgeryi che sei proprio all’incrocio della musica: dove si incontrano la Route 49 e 61 lì nasce il blues e lo si capisce da subito, non potrebbe che essere così. Tutto da queste parti è fatto per favorire l’industria e l’indotto della musica. Dai negozi ai locali in cui ascoltare musica dal vivo, dai servizi agli hotel in perfetto stile Mississippi. Ma qui la musica non è solo business, è un vero e proprio stile di vita, un modo di essere che si tramanda da generazioni.
Qui siamo nel sud degli Stati Uniti e come diceva Renzo Arbore (Bluesman anche lui) “Siamo sempre Meridionali di qualcuno”, qui nel Mississippi ti sembrerà di stare nel nostro meridione per la cortese ospitalità della gente di queste parti, per l’ottima cucina ben condita e per la tipica tradizione contadina che qui viene conservata dai pronipoti di quegli schiavi neri portati qui dall’Africa Orientale nelle Piantagioni di cotone, i bianchi sono ancora pochissimi e quando sarai qui ti accorgerai che la gente ti sorride quando ti incontra per strada.
Qui in città naturalmente c’è anche il Delta Blues Museum che ha una parte importantissima nel Festival in quanto partner e promotore culturale del Festival e di tutte le sue attività formative e concerti. Una visita qui servirà sicuramente a capire meglio cosa si sta per vivere durante i concerti live che durano 3 giorni. A proposito di musei, a poca distanza da Clarksdale, a Indianola c’è il Museo di BB King che forse in assoluto è il nome più famoso che ricordi questo genere musicale.

Ma a Clarksdale tutto è “Black Style”, anche, naturalmente, il parrucchiere del villaggio in cui il tempo pare si sia fermato agli anni ’50 con i suoi caschi per capelli da signora, con la sua clientela rigorosamente nera di carnagione e con le acconciature che qui si usa fare, molto più simili alla tradizione africana che non alla modernità americana. Qui per molti versi ti sembrerà di essere in Africa: per la gente, per la trascuratezza dei luoghi, per lo stile di vita… L’unica cosa che ti ricorderà l’america sarà la musica che sentirai già appartenere alla tua cultura, al tuo modo di essere, il Blues ti scorre nelle vene, mentre sei li scopri la tua vera Black Soul, una vera anima nera che forse non sapevi ti appartenesse, eppure scopri di averla dentro da sempre. Questa musica ti entra dentro al cuore e non ti abbandona. Mai. Nemmeno dopo che sarai tornato a casa.

E’ il più mitico e inconfondibile locale che esiste in città, acquistato da Morgan Freeman si dice per per salvarlo dalla sua fine e ora è un pezzo vivente e cuore pulsante della Storia della musica e del Blues. Se riuscirai a sederti sui suoi lerci e schifosi divani damascati e in pelle che sono sulla terrazzetta esterna potrai godere del miglior posto possibile per capire a fondo lo stile spartano ed essenziale del Blues e di questo locale in particolare.

Al Ground Zero puoi passarci la vita senza invecchiare. Al Ground zero il tempo viene scandito non dall’orologio ma dal ritmo della batteria, dal tempo del basso elettrico e dalle melodie della chitarra acustica dei musicisti che iniziano a suonare musica live alle 10,00 del mattino mentre gli ospiti seduti mangiano i famosissimi Pomodori Verdi Fritti cucinati secondo la più classica delle ricettte e annaffiati da fiumi di birra che vengono consumati non solo ai tavoli ma anche in piedi, fuori dal locale dove le note arrivano e si sentono a decine di metri di distanza…

I Musicisti qui vengono per divertirsi, per suonare ma fondamentalmente ti accorgi che lo fanno per incontrare e allietare i loro amici che vanno a trovarli, sono i migliori del mondo e raccolgono le offerte con il piattino e mentre cantano li senti ringraziare per ogni singola mancia che qualcuno gli lascia durante il concerto. Qui la musica si sente ad alto volume ma si riesce sempre a parlare ed è impossibile non battere il tempo con la testa e con tutto te stesso mentre sei lì sorseggiando l’ennesima birra…
Lo stile del locale è il più scarno e autentico che possa esserci: pareti fatte con assi di legno inchiodate e su di esse trovi attaccata e scritta la testimonianza di chi è stato qui prima di te: locandine, fotografie, giornali, stumenti musicali e copertine di dischi sono attaccati a tratti sui muri, affinchè nulla prevalga sul resto qui vince la regola che chi scrive dopo domina su tutti gli altri. Persino le pareti dei bagni sono completamente ricoperte dalle firme praticamente di tutti i clienti che sono transitati di là e che lasciano alla storia il segno del loro passaggio…

A Clarksdale durante il Delta Blues Music Festival in Mississippi la musica va avanti per tre giorni e ogni luogo è buono per suonare: la mattina i concerti ufficiali si tengono nella scuola della piccola cittadina, nella palestra in cui ti immagini le ragazzine che durante il resto dell’anno si allenano lì a fare le Majorette. Qui al mattino suonano gli stessi grandi musicisti che suonano la sera in piazza, è solo un fatto di compatibilità di orari e non di qualità della musica.

Il grande palco ad ingresso libero è montato in un piazzale e lì si suona durante tutto il pomeriggio e la serata. La folla arriva con i caravan e si accampano dove capita per ascoltare ogni nota che esce dagli strumenti e dalle voci di questa gente fatta per fare musica.
I concerti sono tutti rigorosamente gratuiti e si susseguono l’uno dopo l’altro in un clima caldo e davvero friendly, per dirla a modo loro. due giorni qui volano, le cose da vedere, la musica da ascoltare, gli ambienti da fotografare sono così tanti che di certo non ci si annoia.
Su quel palco hanno suonato tutti i più grandi Bluesman della storia da BB King a Eddie Cusic, Denise LaSalle, Lisa Knowles & the Brown Singers… Impossibile perdersi questi concerti destinati tutti ad entrare nel mito di questo luogo incantato.
Quando sei nel prato di Clarksdale al Sunflover Blues Festival senti un senso di appartenenza a qualcosa che non sapevi facesse parte così intensamente di te, senti che sei lì con altre migliaia di persone a costruire un pezzo di Storia della Musica.

Fare un Viaggio Fotografico con noi è un’esperienza che non finisce rientrando a casa.
Il lavoro fatto insieme, la condivisione delle foto dopo il rientro, lo spirito collaborativo che si creano durante e dopo il Viaggio portano a iniziare dei rapporti personali e professionali tra gli Allievi e i Docenti che si trovano riuniti tutti come Soci della Associazione “Viaggio Fotografico”.
Ed è proprio questo che è capitato ad Alessandro Pasqualini, partito nel 2014 per un primo pionieristico itinerario a New York, quarto Viaggio Fotografico a New York per il Capogruppo Roberto Gabriele, prima esperienza per lui, primo viaggio intercontinentale per Viaggio Fotografico.
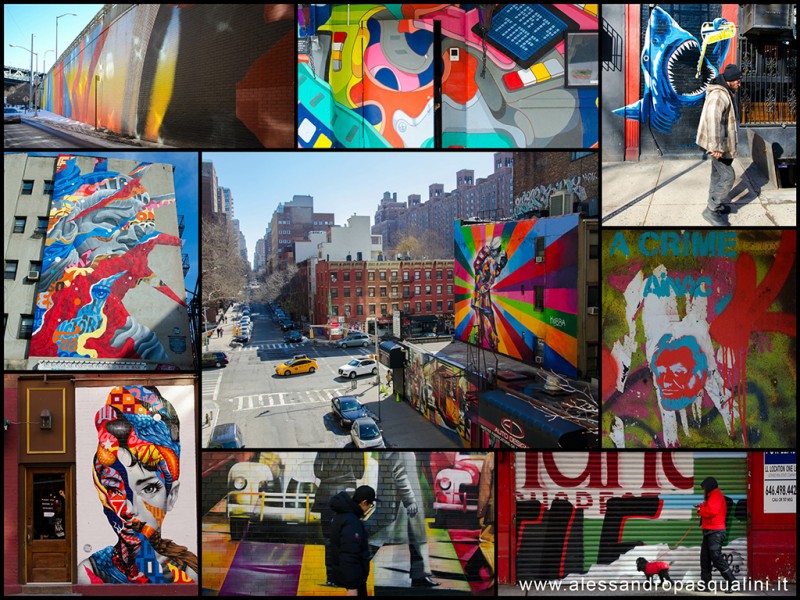
Alessandro Pasqualini in questi 12 mesi ne ha fatta di strada: è diventato un Professionista e ha esposto le sue foto già in due importanti mostre di cui vogliamo condividere alcune immagini e i relativi link ufficiali.
Nato con una grande passione per il reportage, Alessandro Pasqualini ha poi fatto della fotografia sportiva la sua attività fotografica, ma in queste foto vediamo il suo racconto di una città come New York. Street Photography, immagini dinamiche costruite e raccolte in strada, a volte con intuito, altre con faticose attese a 22 gradi sotto zero appostati con i cavalletti in mezzo a 40 cm di neve per oltre 2 ore a fotografare tramonti e notturni di Manhattan vista da Brooklyn.
Mostra Fotografica Chalet Amerigo Village: http://www.alessandropasqualini.it/myalbum.php?id=4809 , a San Benedetto del Tronto (A.P )
[highlight]Una[/highlight]bella esperienza, nata da una mia idea, in collaborazione con uno studio fotografico e con dei ragazzi che mi hanno fatto partecipare al loro festival itinerante.
Ho realizzato la mia prima mostra fotografica utilizzando le foto di un mio viaggio fotografico fatto con Roberto Gabriele nel febbraio scorso. Ho selezionato 21 foto tra le tante scattate a NY, dando volutamente un tipo di impronta a quello che avrei voluto raccontare.
La stampa mi è stata consigliata dallo studio fotografico, invece la realizzazione e la messa in mostra delle foto è stata ideata e progettata da me. Posso dire che sono rimasto soddisfatto tantissimo, sia per le persone che sono venute a visitarl ma soprattutto per i complimenti ricevuti da amici e turisti venuti da diverse parte d’italia a San benedetto in vacanza. Inoltre da pochi giorni ho avuto la fortuna di vendere le mie prime foto. Soddisfazioni che restano.”
Alessandro Pasqualini
Questa mostra nasce in maniera diversa, è direttamente l’associazione dotArt che ha selezionato le mie foto per una loro mostra internazionale che per quest’anno hanno svolto all’aeroporto FVG. Io e la dotArt ci conosciamo tramite un concorso urban del 2014 proprio con loro, dove ho presentato un mio portfolio e da li i primi contatti e scambi di idee e possibilita’ di collaborazione. Dalla loro selezione nasce questa esposizione e messa in mostra: http://www.alessandropasqualini.it/myalbum.php?id=5350
Alessandro Pasqualini

Questo luogo è il Fortino 52 “Borek” ed è stato costruito a metà ‘800 dagli Austriaci, poi è stato rifortificato dai Tedeschi e dai Polacchi…. Insomma una storia legata a guerre e dominazioni, nella sofferta cultura polacca.
Abbiamo conosciuto Cracovia visitandola lentamente, scoprendola passo per passo in 10 lunghi giorni in cui ne abbiamo apprezzato le bellezze, ma anche molti aspetti meno noti. E’ il caso di questo fortino militare abbandonato che si trova poco fuori città. Di sicuro lontanissimo da qualunque itinerario turistico ma non privo di interessi storici.
La cosa che ci ha sconvolti è non tanto e non solo la possenza delle mura del fortino militare, quanto, in particolar modo, la natura che pian piano sta riappropriandosi dei suoi spazi . Il tempo sta ricoprendo tutto ciò che dall’uomo era stato costruito per resistere alla forza di altri uomini, ma che è impotente alla forza della natura.
Lentamente la natura avanza, la foresta cresce e copre ciò che l’uomo aveva costruito. La sensazione è quella del tempio di Angkor Wat in Cambogia anche se qui di sacro non c’è nulla.
Il fortino, vista la sua posizione lontana dalla città e il clima freddo di quelle zone, non è abitato da barboni e il silenzio che si sente entrando nei locali nati per proteggere dai bombardamenti è davvero spettrale.
Puoi trovare altre informazioni sul sito ufficiale: http://www.twierdza.art.pl/ è scritto in polacco, ma se attivi il traduttore di Google sarà tutto più semplice da capire!!!!
Foto e parole di Roberto Gabriele











Viaggio Fotografico in Polonia, oggi siamo a Nowa Huta, alla fabbrica Sendzimira, nei pressi di Cracovia. Una fabbrica-città grande il doppio della stessa Cracovia.

Qui è nata Nowa Huta, un quartiere satellite nato appositamente per ospitare gli operai con le loro famiglie. Il regime russo all’epoca ha creato intorno alla fabbrica i soliti quartieri-dormitorio che ancora oggi vivono cono lo stile di allora. Parliamo di fine anni ’80 quando la Polonia era una Nazione povera e ridotta allo strenuo, quando la gente non aveva cosa mangiare e comprava la benzina in cambio di uova….

Oggi la Polonia è un Paese moderno che sta vivendo il suo boom economico così come fu per l’Italia negli anni ’60, un vero risveglio sociale, industriale, imprenditoriale. Si sente un grandissimo fermento culturale.

A Nowa Huta, invece, il tempo si è fermato in una bolla senza collocazione cronologica, senza una datazione certa. Questo vale nei negozi che sono come erano ai tempi della guerra fredda, lo si vede nella gente che abita qui, che a meno di 10 Kilometri da Cracovia è completamente diversa: sono infatti gli stessi operai che lavoravano nella fabbrica che ora continuano a vivere nelle sue vicinanze, e con lo stesso stile di vita di allora, con gli stessi abiti che indossavano all’epoca, prima di Solidarnosc quando erano oltre la cortina di ferro.

Se siete da queste parti questo quartiere/città è il luogo ideale per fare i vostri reportages fotografici sociali, per avvicinarvi alla gente, per capire e documentare come si viveva qui 25 anni fa, quando l’Italia era in pieno rampantismo anni ’80

Foto e parole di Roberto Gabriele

La pioggia scende prepotente, le prime foglie si staccano dai rami degli alberi con fare sconsolato, la gente si rifugia nelle proprie case e pensa già al cambio dei vestiti negli armadi. È così che la mia mente vola ad altre latitudini, a quella terra tanto martoriata, turbolenta e poco definita nell’immaginario comune, a quella terra sorridente e magica nei miei pensieri. La Colombia!
Parlare della Colombia non è facile, non si sa mai da che parte cominciare… Di solito la conversazione inizia col dover in qualche modo rispondere ad una battuta sulla cocaina. Facciamo che di questo vi parlo in un’altra occasione, oggi vi racconto un’altra storia. Vi parlo, ad esempio, di quello che oggi è considerato il miglior caffè del mondo. Turchi, libanesi e siriani portarono la pregiata qualitá arabica nel XVII secolo trovando condizioni climatiche perfette per la coltivazione. I paesaggi ed il contesto culturale delle verdi vallate del “Triangolo del caffè” sono riconosciuti come patrimoni dell’umanitá dall’UNESCO.
Immaginate la Colombia come un tessuto cucito nei secoli col profumo e le influenze di tante razze e culture che dando vita ad un mosaico multicolore dal fascino indigeno, europeo, africano, medio-orientale. La Colombia è un paese con una biodiversità incredibile e di rara bellezza ma la sua vera ricchezza sta in quel particolare “melting pot” che si è venuto a creare nel corso dei secoli. Lo si può scorgere nelle architetture coloniali deliziosamente conservate, nell’artigianato, nella gastronomia, nelle molteplici espressioni musicali e soprattutto nei tratti dominanti e in quelli meno evidenti dei visi della gente.
La Colombia è un paese in cui un viaggio ne contiene molti altri, un paese in cui ancora si possono vivere esperienze autentiche ed emozioni genuine essendo sempre stato fuori dalle rotte tradizionali del turismo. Un paese in cui si può camminare per le strade acciottolate del centro storico della Candelaria nella capitale Bogotà, alzare gli occhi al cielo ed ammirare le Ande, acuire l’udito e sentire i suoni dolci di una fisarmonica che richiama le storie del Mar dei Caraibi, girare l’angolo di un vicolo e sentire l’aroma di caffè.
Potrebbe essere più immediato descrivere paesaggi e luoghi, ma come fare a farvi sentire l’incanto delle emozioni, la brezza che vi accarezza la pelle, il caldo rovente della sabbia sotto i piedi del deserto della Guajira o i suoni emessi dalle balene che svezzano i cuccioli nella acque calde di Nuquí o Bahia Solano. Un paese che profuma di Realismo Magico e custodisce con gelosia i segreti della Leggenda di “El Dorado”.
Testo e foto di Dario Gonzalez
EMAIL: dario@worldtraveldesigner.it
MOBILE: +39 333 3166283

Dal Romanzo Il comandante della caccia reale di Renato Gabriele (Genesi, Torino 2008). Il libro narra la vicenda, intorno all’anno 1830, di Nicandro Ferrante, master di caccia di Francesco I di Borbone. Il Romanzo è stato selezionato per il Premio Campiello 2008. Clicca qui per vedere la scheda del libro
Il libro sarà in vendita durante il workshop.
S’incamminò per la lieve discesa di Toledo inondata di sole ed ormai molto animata. Era completamente stordito dall’alto rumore che vi risuonava come un cacofonico sottofondo musicale dal quale a strappi, secondo il prevalere dell’uno o dell’altro strumento, si poteva distinguere ora un sonoro zoccolare ora un arrotare o un battito metallico ora il richiamo d’un venditore ora il vociare di un gruppo di persone o una canzone proveniente da una finestra.
Diversi lo seguivano con lo sguardo e qualcuno addirittura si voltava, forse incuriosito dal contrasto che fra loro facevano i vestiti dal tono tanto discorde e dal fucile che portava con la canna in giù, a spasso per la città, unitamente alla borsaccia. Gli si avvicinò un fratacchione di cerca che gli chiese l’elemosina per le anime del purgatorio ma lo fece con un tono che gli suonò insultante. Dette una moneta e pensò che forse avrebbe fatto meglio a tenere la giacca vecchia ed a lasciare la nuova al sarto, per ritirarla l’indomani insieme con le brache.
Considerato che il sole scaldava a sufficienza ed anzi finanche troppo, si svestì della giacca ed andava portandola ripiegata sul braccio, restando con il solo panciotto sulla camicia.
Il largo di San Ferdinando a Chiaia brulicava di gente intorno ad un paio di saltimbanchi. I due caffè erano pieni di uomini in tuba e vestiti di nero. In giro c’erano donne con l’ombrellino e nugoli di ragazzini rattoppati, da cui don Nicandro si tenne accuratamente alla larga, reputandoli pericolosi marioncelli ed avendo per giunta l’impaccio del bagaglio e dell’arma, che sicuramente riducevano le sue difese contro i borseggiatori. E tra quella gente dovevano essercene molti.
Si fermò sulla piazza di palazzo. Eccola là davanti, la chiesa di Pietro Bianchi, la intravedeva dietro l’impalcatura. Non gli parve una cosa speciale, almeno per quello che ne avrebbe potuto capire lui; doveva però essere importante, se lo stesso architetto aveva saputo ideare quella grande macchina del teatro mobile alla Fagianeria, un marchingegno poderoso, per l’Anticristo!, che aveva potuto essere smontato in così poco tempo e trasportato altrove.
*
*
*
*

*
*
*
*
Camminando per la via fu costretto a mettere i piedi in certi rivoli d’acqua o d’altri liquami, cercando intanto di schivare scoli e iatture che potessero macchiargli la chamberga. Ma non poté schivare le continue richieste d’elemosina che gli faceva una moltitudine di persone malridotte, coperte di stracci e chiaramente denutrite, con gli occhi infossati dalla fame, emaciate, ingobbite e bitorzolute, zoppe e gozzute, cieche e mutilate, che suscitavano in lui uno schifo istintivo e nessun intenerimento caritativo ma reazioni d’insofferenza per nulla temperate:-Passa là, dannato zelluso…fetente! Non me toccare co’ ‘ste luride mani, per l’Anticristo!
Queste oltraggiose proteste gli causarono alla fine un’aggressione in un vicolo stretto in cui, ignorando che fosse a cul di sacco, era andato a cacciarsi. Se la cavò menando cazzotti poderosi e calci da mulo, senza neppur dover toccare la sferra che portava infilata alla cintura. Dovette però cambiare itinerario e portarsi a Toledo, dove c’era tanta gente e dove il numero dei mendicanti, pur non scemando, era più concentrato nei pressi delle chiese, dove ormai sul far della sera andava parecchia gente per la funzione vesperale, ed all’uscita dei palazzi gentilizi e dei conventi, dove restavano ad aspettare gli avanzi della cena.
Dopo aver bighellonato per fondachi e botteghe, guardando con insistenza negli occhi alle donne che passavano a piedi o in carrozza, quando gli riusciva di farlo, senza essere per nulla intimorito dalla presenza degli uomini che le accompagnavano, pensò di rientrare a palazzo. Non prima però di aver fatto le compere progettate e che volle abbondanti: di maccaroni e di zampi di porco arrostiti, di zeppolelle e di altre fritture. Per terminare con le dolcezze, aveva comprato frutti canditi e cioccolatte.
*
*
*
Stava dirigendosi al Montedidio con lo scopo di vedere la ragazza, di presentarsi a lei sia per levarsi l’uzzolo che le trame della madre gli avevano messo in capo, sia per provare, non si sa mai, a corteggiarla, come aveva ormai capito di dover fare, corteggiare le donne che non amavano le maniere spicce alle quali lui era aduso, lui che per la verità trovava ridicole le mosse del suo mentore in proposito, il dolcissimo Fergola.Lui, il guardiacaccia, non aveva mai imparato a corteggiare ed al più era stato capace di fare due regali, trovando che questa fosse una facile strada di approccio alle grazie femminili.
Per la strada però aveva cambiato idea sullo scopo della visita. Il nuovo proposito gli era stato suggerito dalla sensazione che gli avevano dato, quel giorno come quello precedente, le continue richieste d’elemosina di certi poveri cenciosi e gli sguardi di alcuni che incontrava: la senzasione di essere da quelli reputato un signore, e forse anche facoltoso. Avrebbe allora ben potuto presentarsi in una modisteria, anche per comprare qualche cosa di più costoso ed importante di una cuffia ricamata.
La modisteria si riconosceva da lontano per un’insegna a bandiera a forma di cappello. Da un braccio metallico infisso nel muro pendeva una sagoma di lamiera piuttosto sottile, ritagliata sul profilo di una cappina femminile alla moda, del tipo a sporta, e tutta dipinta a colori vivaci, così il passamano che accostava le tese per annodarsi sotto il mento, così i fiorellini e le aigrettes che ornavano la piatta cupoletta. Sulla cornice alta della porta, per chi provenisse dall’incrocio delle strade, e perciò visibile ben da lontano, era posta una vasta tabella di bandone leggermente curvato di foggia rococò, con dipinta la scritta Mode al centro di due silouettes, l’una di un paio di guanti lunghi, l’altra ancora di un cappellino.
L’interno ebbe su Nicandro l’effetto di una cappella di preghiera, per il sommesso mormorio che l’attraversava, senza che si distinguesse da quali labbra provenisse quel parlottare, se non da un’indistinta origine posta al centro di certi gruppi di due o tre giovani lavoranti a capo chino, la cui calma operosità fatta di svelti gesti di mani sicure, l’affascinava a guardare.
*
*
*
Nicandro veleggiava a lunghi passi nel vento, che davanti al Castiello tirava gelido e gagliardo. Ad Astroni avevano forse già indossato i tabarri, a scanso che l’umido respiro del bosco intaccasse le ossa; forse avevano anche acceso i camini ed allungavano già le gambe alla fiamma, arrostendo le prime castagne per ingannare le ore del buio, che nel cono profondo della foresta anticipava la notte.
L’autunno che pareva in quei giorni talvolta smentito da certe brevi sopravvivenze dell’estate, si capiva comunque definitivamente arrivato: dalla qualità e dal colore dell’aria nelle sere e dai voli degli uccelli bruni, partiti ormai le rondini e i balestrucci, a rigare i più pallidi tramonti.
Anche a Napoli, finiti i fichi tardivi, s’erano già visti i frutti autunnali e soprattutto le ceste ricolme di castagne di Mercogliano, quei bei frutti così freschi e lucenti, e dentro così bianchi e sodi, con la barba dei fioricini ancora intatta.
A falcate s’era lasciato alle spalle l’Incoronatella ed in breve era giunto alla rua catalana, ancora alquanto animata, anche se i garzoni delle botteghe avevano cominciato a sgomberare, dagli attrezzi di lavoro e dai materiali d’ogni genere, la stretta strada che, tutta quant’era lunga, era selciata. Restavano all’aperto soltanto le opere finite e la merce, insomma soltanto gli oggetti da vendere. E così restavano appesi ai ganci esterni delle botteghe i panari e i canestri, i cordami d’ogni tipo e misura e, ammonticchiati com’era possibile alla meglio, per non ostruire il traffico dei carri e della gente, botti e varrili, mastelli e tinozze, e banchetti carichi di scelle di baccalà e d’arenghe affummichiate…
Negli interni già riluceva qualche lampa, come nell’officina d’un ferraro e nel fondaco d’un carbonaio, un uomo dalla faccia totalmente nera, in cui roteavano gli occhi d’un bianco inusitato, intento a spalare, per ammassarli in gruppi più grossi, i residui della vendita del giorno, che puzzavano del piscio d’ogni cane di passaggio.
Uscendo per recarsi al teatro di San Carlo, ch’era proprio a due passi, girato l’angolo del palazzo reale, si ricordò di dover avvertire il guardaporta che sarebbe rincasato dopo l’ora normale di chiusura ma questi lo rassicurò che lo avrebbe trovato anche a quell’ora nella bussola a vetri, essendo previsti alcuni rientri a quattr’ore di notte, per via di altri spettatori dell’opera, gente importante del secondo piano.
Giunto sulla vasta piazza di palazzo, si volse alla sua sinistra, nella direzione del mare, scrutando il cielo, ma brevemente perché l’addensamento delle nubi attestava chiaramente come stesse mettendosi il tempo. Pioggia, di certo, e neanche poca! L’inverno, pensò Nicandro, si promette acquoso. Si lasciò andare al pensiero o piuttosto alla visione, tanto gli era nitida l’immagine davanti agli occhi, della pioggia, quando cadeva a fiumi su Astroni.
Mancando ancora un paio d’ore all’incontro con il barone, che doveva avvenire sotto il porticato del teatro, andò alla ricerca d’un barbiere per farsi radere. Presto trovò una bottega in cui c’era da attendere poco essendovi soltanto due avventori da servire, meno che nelle altre barberie, che aveva incontrato numerose nei quartieri spagnoli.
Entrò senza salutare e rispose con un salute a voi ai salamelecchi dell’untuoso padrone, che lo aveva chiamato cavaliere eccellenza. Tre erano i clienti serviti in quel momento, in turno c’era poi un giovane musicista o studente, che di continuo apriva con uno scatto la custodia del suo strumento, una sfavillante cornetta, che traeva fuori e soppesava per provarne i tasti con le dita e quindi riporla sul velluto rosso cupo e richiudere poi la nera scatola sagomata. L’altro in attesa era un barbogio in calze nere di seta e scarpe verniciate e dalle fibbie dorate, alla moda delle calzature che Nicandro aveva visto indossare solo dai prelati.
*
*
*
Dopo circa un’ora ritornarono sulla piazza di palazzo, ormai sulla via di rientrare a casa per il pranzo domenicale. In piazza c’era un assembramento di gente che pareva far ali ad uno spettacolo o ad una gara che si stesse svolgendo lì in mezzo. Molti infatti urlavano incitamenti e sbattevano le mani o alzavano i pugni. Domandarono ai presenti senza però ben comprendere le risposte. Si trattava di una gara tra uomini che montavano…sì! certi cavalli meccanici, una diavoleria che veniva esibita per la prima volta in pubblico.
Si avvicinarono al canapo che delimitava lo spazio di quella giostra e videro da lontano, su certi stranissimi trabiccoli, due uomini scamiciati che affannavano a girare intorno ad una meta e si urtavano urlando come ossessi indiavolati. La prima a riconoscere Nicandro in uno dei due concorrenti, prima ancora di sentirlo urlare: per l’Anticristo t’afferro e te passo!, fu Pompilia. Lo vide che sgomitava allungando quelle zampacce da cane, chillo farabutto d’uno tradetore, per fare leva in terra e spingere in avanti quel marchingegno. Alla fine, arrivato per primo in mezzo a due panzoni in tuba, uno di qua uno di là, scese dal trabiccolo trafelato ed ansante, con le narici da cane ancor più dilatate del solito, ma possente, sangue di Giuda!, ed imponente, e ricevette da uno dei panzoni, che gridava: il vincitore, il vincitore!, una ghirlanda infiocchettata. E Pompilia dovette anche sopportare l’umiliazione di assistere al gesto plateale che il comandante fece, ma da chi l’aveva mai visto fare quell’orso cicisbeo?, di consegnare la ghirlanda a Margareta, che gli reggeva, quella smorfiosa inguantata di bianco, la giacca: proprio come una di famiglia, una mogliera!, e di nominarla regina davanti alla folla acclamante:- La ghirlanda la dongo a chesta regina jonna, a chesta figliola ch’è la rigina de chesta jurnata, a ‘sta bardascia affatata e gentile, che ave d’oro li capilli!
*
*
*
Si diresse dunque alla rua catalana dove trovò una babilonia di gente nelle cui voci risuonavano lingue e dialetti incomprensibili. Oh maronna! Pure li Turchi ce stanno! Per ogni dove si vendeva qualcosa, sia roba da mangiare che cianfrusaglie. Si soffermò un poco a guardare un grassone con un turbante sormontato da una piccola falce di luna, ma che parlava napolitano con una voce pastosa ed arrochita, che gli gonfiava il collo, ad ogni parola, come quello di un rospo. L’uomo era impegnato in quell’uguale cantilena ipnotica che accompagna sempre il gioco delle tre carte, in cui era intento con le sue grassocce ma mobilissime mani dalle unghie cerchiate di una farda nera.
Allontanatosi da quel crocchio si sentì chiamare dalla voce di un ragazzetto alle sue spalle. Avrà avuto sette od al massimo otto anni ed era in compagnia d’una torma di coetanei scalzi e smandrappati come lui.-Signo’, signo’, vedite ccà…- Gl’indicava quella che diceva una grossa macchia, una lordura di grasso, giusto al centro delle spalle, su quella sciammeria tanto bella.
Nicandro non riusciva a guardare in quel punto della schiena e fece spallucce scacciando la banda di ragazzini con un gesto della mano e continuando a camminare. Ma uno di quelli, per convincerlo, gli aveva passato un dito su quell’untume nero e glielo aveva mostrato.- La vedite ‘sta ‘nzogna nera?- Nicandro allora si tolse la giacca e quelli l’aiutarono, facendo di tutto, ancorché lui li scacciasse come mosche fastidiose, per grattare il grosso di quella spessa e densa materia.- Vabbuono, iatevenne mo! Guarda tu che canchero m’hanno cumbinato a ‘sta sciamberga nova nova! Vabbuono accussì, iatevenne, iatevenne!-
I ragazzini, che fino a quel momento ridacchiavano sfottenti, che peccato…’sta bella sciammeria…guarda ccà!, e si davano di gomito strizzandosi l’occhio, si mostrarono come risentiti ed offesi dalle urla di don Nicandro e si dileguarono rapidamente. Fu allora, appena quelli furono spariti dalla sua vista, che Nicandro portò istintivamente la mano alla tasca della chamberga. Vuota. Un tuffo al cuore.
Meccanicamente tastò il giustacuore. Il rigonfio era lì, quello almeno per fortuna. Certo avevano dovuto tastarlo anche chilli nati da cane, bastardi mariuoli. Adesso che ci pensava, si rendeva conto di averli scacciati , ed in malo modo, non per reazione a quella finzione d’aiutarlo ma per il fastidio d’essere toccato simultaneamente da tante mani in ogni parte del corpo. Ecco, cercavano il fagottone, il pacco grosso, e dovevano aver urtato anche la sferra che portava alla cintura, dovevano averla subito vista, ‘sti muccusi delinquenti! E lui, la sferra, quella no che non gliel’avrebbe lasciata sfilare; i denari sì, in quello erano riusciti. Altra cosa sarebbe stato il tentativo di sottrargli il coltello, la cui presenza al suo fianco era né più né meno che quella di un arto aggiuntivo e di cui serbava la coscienza che si ha delle membra del corpo.
 Renato Gabriele è scrittore, poeta e saggista.
Renato Gabriele è scrittore, poeta e saggista.
Cell. +39 349 6678755
Email: renatogabriele43@gmail.com

Ciao a tutti. Mi chiamo Karen Pozzi e sono responsabile contenuti di leichic.it (www.leichic.it), magazine online di moda femminile e Karen P. by leichic (http://karenp.leichic.it), un blog nel quale racconto le mie passioni: moda, sport e viaggi. Oggi sono qui per raccontarvi il mio tour di quest’estate. Avevo 20 giorni a disposizione, qualche risparmio e tanta voglia di visitare l’oriente. Ho deciso di andare in Thailandia, Indonesia e Singapore.
E’ stato un viaggio faticoso, ma davvero molto emozionante grazie a quei posti paradisiaci che mi hanno fatto sognare. In questo articolo vi parlerò della Thailandia, poi, se avrete voglia di seguire il resto del mio tour dovrete attendere qualche giorno.
Sono atterrata a Bangkok il 27 luglio e il mio tour ha toccato questa splendidà città, l’isola di Phi Phi Island e Krabi. La Thailandia è un posto magnifico. La città di Bangkok è increbibile, nonostante il caos, l’inquinamento, lo sporco e molto altro di negativo, mi ha trasmesso moltissime sensazioni positive. Era la prima volta che andavo in oriente e il primo approccio con una città come questa che ingloba i sapori e dissapori di questa parte di mondo mi ha regalato tanto.
Tutto è iniziato da un giro nel centro, nell’affollatissima Kaho San Road, per poi proseguire sul fiume, al flotting market, sugli elefanti, al palazzo reale, al big Buddha e infine nel mega centro commerciale per un pò di shopping. Dopo tre giorni a Bangkok abbiamo preso un pullman per Krabi, dove avremmo preso la barca per Phi Phi Island. Un viaggio infinito, dodici ore su un pullman vecchissimo che per fortuna ci ha portati a destinazione.
Ci siaqmo imbarcati e ci siamo ritrovati in paradiso, in un’isola da sogno: niente macchine, moto e altri mezzi a motore, solo bici, stradine e tantissimi negozietti dove poter assaporare il buonissimo cibo locale a pochissimo prezzo. Siamo stati nella spiaggia di Loh Dalum, Long Beach e nelle isole vicine dove abbiamo potuto assistere ad uno spettacolo della natura: MAya Bay, la spiaggia dov’è stato girato il film The Beach di Leonardo Di Caprio.
Il nostro viaggio è proseguito in Indonesia, ve ne parlerò nel prossimo articolo.

 Color cerbiatto, zuccherino, un liquido denso, carico di latte. Lo passano attraverso un tessuto bianco, di dubbia pulizia, per arrivare alla consistenza giusta, mentre un capannello di gente guarda attenta. Dicono che i rickshaw pullers, gli “uomini cavallo”, lo bevano per resistere alla fame, per farsi forza in mancanza di cibo. Ora i turisti ne fanno un rito di passaggio, un modo per sentirsi integrati in questa terra distante, un sapore zuccherino in un’amara, irrisolvibile povertà.
Color cerbiatto, zuccherino, un liquido denso, carico di latte. Lo passano attraverso un tessuto bianco, di dubbia pulizia, per arrivare alla consistenza giusta, mentre un capannello di gente guarda attenta. Dicono che i rickshaw pullers, gli “uomini cavallo”, lo bevano per resistere alla fame, per farsi forza in mancanza di cibo. Ora i turisti ne fanno un rito di passaggio, un modo per sentirsi integrati in questa terra distante, un sapore zuccherino in un’amara, irrisolvibile povertà.
Li si trova ovunque, i venditori di thé: a ogni angolo delle strade, accovacciati, apparentemente insensibili al dolore di tante ore rannicchiati sulle ginocchia. In un lillipuziano vasetto di terracotta, versano il liquido bollente, aspettando che si getti via il bicchiere appena finito, aggiungendolo al mucchio di immondizia per le strade. Nella mia camera fa ancora capolino, quel piccolo contenitore, scambiato da tutti per un oggetto bioetico, uscito illeso dalle immancabili liti in aeroporto, tra i chili in più nel bagaglio verso casa.
E’ già passata una settimana, mi sto abituando al traffico che non conosce riposo: allo zoo a due, tre, quattro ruote e due gambe che popola le strade. “Tuc tuc”, moto, macchine, bici, tram e autobus: città della gioia o inferno di dolore?
Fa freddo, alle cinque e mezzo del mattino di questo lunedì.
Con altre quattro ragazze, anche loro volontarie con le suore di Madre Teresa, cammino ogni mattina dalla mia guesthouse alla chiesa, in tempo per la messa delle sei. Sono arrivata da quasi un mese, e già sento che sarà dura andar via. Ho cominciato il servizio con le suore di Madre Teresa, A Pren Dam, casa di accoglienza per malati e moribondi, oasi di pace tra le pieghe di AJC Bose Road, dove intere famiglie vivono per strada, quasi invisibili nella loro povertà.
Calcutta è una città che scuote, che distrugge, mettendoti al muro, in un odi et amo gridato dai cumuli di immondizia agli angoli delle strade. Non ci sono fogne, né bagni, né strade asfaltate: in giro mucche, cani, galline, uomini cavallo e bambini. E’ una città di impressioni: alcune forti, urlate, impresse sopra il rumore del traffico che non conosce riposo; altre silenziose, delicate, difficili da ascoltare e da comprendere. Ci sono voci nascoste dai clacson delle moto e delle macchine, canti mariani e richiami di muezzin, segnali di panico e richieste di aiuto, sottolineate dalle grida di chi da questa città vorrebbe fuggire, perché quello che vede è davvero troppo. Ma ci sono anche le parole che vincono il frastuono e penetrano nel nostro silenzio interiore, facendo breccia, imprimendosi nella a memoria.
Me l’hanno chiesto in tanti cosa mi ha lasciato questo viaggio.
Dei tanti giorni di volontariato in una città estrema che ho imparato ad amare mi resterà nel cuore una frase: “God still loves the world through me and you today”.
www.nataliapazzaglia.com
http://www.viaggiinteriori.blogspot.it/
http://traveleasyguides.blogspot.it/
https://www.facebook.com/Traveleasyguide


Siamo andati a vedere la mostra Danubius di Marco Bulgarelli al Museo di Roma in Trastevere. Per chi non lo conoscesse, questo bellissimo spazio espositivo si trova nel bel mezzo di uno dei quartieri più storici e caratteristici della Capitale, Trastevere, appunto. Il museo è ricavato nelle sale di un ex convento con tanto di chiostro ora riadattato a galleria espositiva, e le foto sul Danubio sono esposte nella Galleria al piano superiore, in quelli che furono i corridoi tra le varie stanze.
 Descrivo lo spazio perchè ben si presta alle foto di Marco Bulgarelli, la cosa che si nota infatti è proprio il percorso di avvicinamento che fa il Visitatore per arrivare a fruire di queste immagini. Trastevere è una zona pedonale e per arrivare alla mostra fortunatamente si è obbligati (uno dei pochissimi posti di Roma) ad attraversare a piedi una vasta isola pedonale chiusa al traffico e piena di persone. Si cammina, quindi, almeno una decina di minuti dal più vicino luogo di transito delle auto. Il camminare riduce la velocità degli spostamenti e allontana dallo stress del traffico. Insomma, per quando arrivi al Museo sei rientrato in empatia con te stesso, hai lasciato i rumori dei motori lontano, hai dimenticato il fattore tempo, così importante per vivere in una città come Roma. Quando arrivi insomma le tue orecchie hanno iniziato a riascoltare il canto dei gabbiani che ti volano sulla testa, ti sei accorto che Trastevere è un luogo a misura d’uomo in cui l’auto non serve e le persone ancora possono salutarsi per strada perchè riescono a parlare, a sentire le voci anche se i toni sono bassi. Quando arrivi alla mostra anche gli occhi sono più attenti ai dettagli, più liberi di guardarsi intorno e di relazionarsi prima con la città, ora con le opere. Camminando tra la gente hai seguito per circa un chilometro un flusso di persone, una serie di incontri con Turisti e Romani e hai seguito una direzione, lentamente. Tutto questo in un ritmo a misura d’uomo, riuscendo a percepire la temperatura dell’aria e altri fattori in cui non siamo abituati a muoverci e proprio per questo quindi ci risultano particolarmente congeniali.
Descrivo lo spazio perchè ben si presta alle foto di Marco Bulgarelli, la cosa che si nota infatti è proprio il percorso di avvicinamento che fa il Visitatore per arrivare a fruire di queste immagini. Trastevere è una zona pedonale e per arrivare alla mostra fortunatamente si è obbligati (uno dei pochissimi posti di Roma) ad attraversare a piedi una vasta isola pedonale chiusa al traffico e piena di persone. Si cammina, quindi, almeno una decina di minuti dal più vicino luogo di transito delle auto. Il camminare riduce la velocità degli spostamenti e allontana dallo stress del traffico. Insomma, per quando arrivi al Museo sei rientrato in empatia con te stesso, hai lasciato i rumori dei motori lontano, hai dimenticato il fattore tempo, così importante per vivere in una città come Roma. Quando arrivi insomma le tue orecchie hanno iniziato a riascoltare il canto dei gabbiani che ti volano sulla testa, ti sei accorto che Trastevere è un luogo a misura d’uomo in cui l’auto non serve e le persone ancora possono salutarsi per strada perchè riescono a parlare, a sentire le voci anche se i toni sono bassi. Quando arrivi alla mostra anche gli occhi sono più attenti ai dettagli, più liberi di guardarsi intorno e di relazionarsi prima con la città, ora con le opere. Camminando tra la gente hai seguito per circa un chilometro un flusso di persone, una serie di incontri con Turisti e Romani e hai seguito una direzione, lentamente. Tutto questo in un ritmo a misura d’uomo, riuscendo a percepire la temperatura dell’aria e altri fattori in cui non siamo abituati a muoverci e proprio per questo quindi ci risultano particolarmente congeniali.
Senza accorgertene sei arrivato fin qui imitando, senza volerlo, il lento percorso silenzioso che fa il fiume Danubio nel suo scorrere e fluire fino al Mar Nero per 2860 chilometri attraversando 10 Stati. Tu stesso sei diventato fiume, goccia umana in un flusso di uomini, sei arrivato fin qui seguendo il corso della natura. Silenziosamente.
 E il silenzio è proprio ciò che di più colpisce vedendo le bellissime fotografie di questa mostra. Il silenzio dei passi che camminano dentro Trastevere, il silenzio di un ex Convento in cui sono esposte le foto, il silenzio che esplode senza far rumore dalle immagini di questo silenzioso Fotoreporter romano che espone nella Galleria più caratteristica e bella della sua Città.
E il silenzio è proprio ciò che di più colpisce vedendo le bellissime fotografie di questa mostra. Il silenzio dei passi che camminano dentro Trastevere, il silenzio di un ex Convento in cui sono esposte le foto, il silenzio che esplode senza far rumore dalle immagini di questo silenzioso Fotoreporter romano che espone nella Galleria più caratteristica e bella della sua Città.
Già, quel silenzio ti pervade mentre guardi la mostra. Sarà forse la neve a rendere l’osservazione più ovattata? Sarà per quel fenomeno gestaltico che riorganizziamo il nostro campo percettivo e ci sembra di sentire silenzio mentre vediamo la neve? Forse si…. Tutta quella neve che imbianca le foto di Bulgarelli amplifica il silenzio che circonda l’osservatore rendendolo ancora più profondo.
Vedendo le foto di Bulgarelli noto il silenzio di quei luoghi innevati in cui ci sono si, sempre persone, ma non c’è mai fracasso, mai sembra di percepire alcun rumore al dilà di un leggero brusio di sottofondo. Le foto di Bulgarelli emettono il silenzio del momento in cui sono state scattate, in quei paesaggi invernali con sconfinate pianure innevate. E’ un pò il motivo di questa mostra. Anche le persone presenti nelle immagini appaiono sospese in un luogo senza rumori. Anche lo scatto in cui si vedono decine di persone in fila che appaiono essere profondamente vuoti dal punto di vista acustico. Le persone non parlano, non schiamazzano… Anche le foto fatte in estate hanno gli stessi silenzi ovattati di quelle invernali. Già, perchè le foto della mostra sono frutto di numerosi viaggi fatti lungo il Danubio in tutte le stagioni dell’anno, la ricerca di Bulgarelli si è protratta per anni nell’esplorazione di tutto il fiume dalla sorgente al sul delta…
E questo silenzio accompagna il Viaggio di un Viaggiatore Solitario come Bulgarelli che esplora il Danubio spostandosi in bicicletta, anche in questo caso senza eccedere in velocità, e, ovviamente, senza far rumore. Il Danubio scorre lentamente, non è un ruscello di montagna fragoroso, è un grosso Fiume che porta migliaia di metri cubi di acqua, merci, persone, il tutto senza clamore. Come Bulgarelli: non fa clamore ma è una persona straordinaria portata a stare con le persone, che nei suoi viaggi avvicina persone con il linguaggio non verbale (e stavolta neanche fotografico!) fatto dalle persone sincere che sanno scambiarsi stima, simpatia e ospitalità attraverso la semplicità e la spontaneità di un sorriso: codice universale di accoglienza e predisposizione verso l’altro. Avvicinare Bulgarelli non è difficile, non fa il divo Bulgarelli, ha la guardia bassa, non sta in difesa, ha la calma delle persone sicure di se che non hanno paura di nulla.
Andate a vederla, questa mostra al Museo di Roma In Trastevere, per leggere una presentazione ufficiale vai sull’Evento di Facebook cliccando qui.
Per info e orari andate sul sito Ufficiale cliccando su questo link.
Il LIBRO della mostra “DANUBIUS” (Museo di Roma in Trastevere, fino al 12 gennaio 2014) uscirà a metà dicembre, è un ottimo regalo di Natale, parlane anche con i tuoi amici e parenti. Sarò eternamente grato per questo piccolo gesto di grande valore. ACQUISTALO ONLINE SUL SITO DELLA CASA EDITRICE: http://www.postcart.com/danubius.php

Quante immagini offre di sé una città? Quante ne mostra Roma? Infinite, tante quanti sono gli occhi che la guardano, quanti sono i passi che la attraversano…Tra le tante vi proponiamo questa volta la visione di una prima volta, quella di un bambino degli anni quaranta dello scorso secolo. Si tratta di un racconto bellissimo e struggente, pieno di meraviglia e di stupore; una narrazione attenta a cogliere le irripetibili atmosfere di un’epoca storica irritornabile. Ecco dunque questo racconto dal titolo “Elegia romana”, pubblicato nel 2003 da L’argonauta, nel volume “Il giorno dell’ira e altri racconti” di Renato Gabriele.
Racconto: Renato Gabriele
Fotografie: Roberto Gabriele
“Stiamo arrivando, mi aveva detto lo zio, siamo sul binario”. Era stato lungo quel viaggio, avevamo ingoiato il fumo del treno nelle gallerie; sentivo in bocca un sapore di fuliggine. Nello scompartimento s’era formata una nebbia densa, tante le sigarette che gli uomini avevano fumato. Uno, seduto di fronte a me, ne aveva confezionate tante con quelle mani dure, callose. Gli riuscivano male, storte,mezze vuote. Le leccava per incollare i lembi della cartina e, così bagnate di saliva, le fumava con boccate piene strizzando gli occhi e lasciando che il fumo gli uscisse dagli angoli della bocca.
Durante il viaggio ero stato al finestrino a guardare gli alberi e le case sfilare veloci. C’erano autocarri abbandonati sulle strade, qualcuno rovesciato in un fosso. Erano carcasse spoliate di tutto, senza più motore, senza copertoni. Avevano perso ogni cosa, con il tempo avrebbero smontato e portato via anche il resto. Avevo visto un piccolo autoblindo e perfino un aereo che sembrava un giocattolo dimenticato su un prato. “ I segni del conflitto”, aveva detto lo zio, con quel suo parlare preciso. Mi dava brevi ma complete spiegazioni che non ammettevano domande né repliche.
Ad una fermata del treno avevo avuto paura di aver perso lo zio, avevo provato il panico di essere solo, abbandonato. Lo zio, che era sceso per bere alla fontanina della stazione, non era ancora tornato quando il treno si era rimesso in movimento, L’uomo che fumava mi aveva però rassicurato:” Non preoccuparti, vedrai che viene subito…tuo padre, sarà salito in un vagone dietro”. L’avevo visto esitare ma non avevo voluto dirgli che quegli era mio zio, che mio padre era morto. Adesso lo zio era lì, davanti a me, con gli occhi chiusi.
 Uno strattone, un rumore di ferraglia, un urto, un sussulto:”Ci siamo, vedrai com’è Roma”, fece lo zio con voce atona, senza enfasi, con la serietà di che propone di assolvere un dovere, un compito. Mi domandai subito se quella di Sassa, da dove ero partito quella mattina, fosse una stazione vera, se potesse chiamarsi una stazione, con le sue aiuole fiorite, lo zampillo, le panchine: tutto al sole, all’aperto, dove a certi intervalli regolari passava un trenino per bambini. Qui a Roma era tutto più scuro. C’erano molti treni allineati, ed erano neri, enormi. A Sassa passava soltanto la littorina, un trenino con un solo vagone, che si annunciava con un rombo come di un tuono che vada spegnendosi, nel silenzio assoluto della valletta.
Uno strattone, un rumore di ferraglia, un urto, un sussulto:”Ci siamo, vedrai com’è Roma”, fece lo zio con voce atona, senza enfasi, con la serietà di che propone di assolvere un dovere, un compito. Mi domandai subito se quella di Sassa, da dove ero partito quella mattina, fosse una stazione vera, se potesse chiamarsi una stazione, con le sue aiuole fiorite, lo zampillo, le panchine: tutto al sole, all’aperto, dove a certi intervalli regolari passava un trenino per bambini. Qui a Roma era tutto più scuro. C’erano molti treni allineati, ed erano neri, enormi. A Sassa passava soltanto la littorina, un trenino con un solo vagone, che si annunciava con un rombo come di un tuono che vada spegnendosi, nel silenzio assoluto della valletta.
C’incamminammo tra tutta quella gente vociante che pareva andare verso un’unica direzione comune. Tutti parevano presi da una smania che li accelerava. Trascinavano vecchie valigie di fibra, segnate e graffiate, stracariche, legate con lo spago e con grosse cinghie. Pensai che quella gente non desiderasse, dopo di là, andare in nessun altro luogo. Sembravano arrivati per restare ma continuavano a muoversi in quel posto su itinerari prestabiliti, a volte paralleli, a volte incrociati. Come le formiche. Non sapevo se io fossi arrivato per restare.
Quattro giorni prima giocavo ancora ai banditi con Nicolino. Ci appostavamo in mezzo al malvone, ai sambuchi, dietro le fratte del biancospino. Poi era arrivata tutta quella gente, che veniva su verso la nostra casa dallo stradone bianco. Erano scesi dalla corriera poco più sotto, a Madonna della Strada. Erano bianchi di pelle, molti di loro portavano gli occhiali. Mi pareva strano, mi ero chiesto per quale motivo tanta gente insieme portasse gli occhiali. Il giorno dopo era stato mio fratello a dirmi che nostro padre era morto, che quelli erano parenti venuti per la sua morte, per il suo funerale. Non conoscevo nessuno di loro, neppure lo zio che mi aveva portato a Roma con sé.
Ed eccomi qui, arrivato a Roma, tra quella folla frenetica, disordinata. Lo zio aveva portato con sé un incarto con un quadro di mio padre. In treno, un momento che eravamo soli, mi aveva parlato un poco di lui, della sua vita sfortunata. Avevo sentito per la prima volta che la vita di mio padre era stata sfortunata. Non sapevo che una vita potesse essere sfortunata. “Chi di voi sa disegnare, chi ha ripreso da lui?”aveva chiesto lo zio. Io avevo fatto spallucce lasciando cadere la domanda. Lo zio mi rassicurava, con la sua voce paziente. In quei giorni le voci di tutti quelli che erano venuti nella nostra casa avevano un comune accento, che non uniformava però la sostanza della voce. La voce della Bolognese era rimasta una musica per me, come sempre.
 Adesso camminavamo in silenzio, io portavo il mio pacco con la biancheria. Sul treno lo zio aveva detto:”Io porto i miei colli, tu porta il tuo pacco.” Non sapevo che cosa fosse un collo ma lo capii quando vidi che lui dava di piglio ai suoi involti. Presi il mio pacco fatto con la carta di giornali e tenuto con lo spago. Molti passeggeri avevano pacchi come il mio.
Adesso camminavamo in silenzio, io portavo il mio pacco con la biancheria. Sul treno lo zio aveva detto:”Io porto i miei colli, tu porta il tuo pacco.” Non sapevo che cosa fosse un collo ma lo capii quando vidi che lui dava di piglio ai suoi involti. Presi il mio pacco fatto con la carta di giornali e tenuto con lo spago. Molti passeggeri avevano pacchi come il mio.
Camminavamo affiancati, immersi nei nostri pensieri, tra uomini in maniche di camicia, con le maniche arrotolate, tra donne in abiti colorati. Qualcuno portava la giacca sul braccio o appoggiata alle spalle senza infilare le maniche.
Usciti da quella fiumana, aspettammo a lungo alla fermata del tram. Non ne avevo mai veduto uno prima di quella volta. Passava scorrendo pesantemente sui binari, con gente appesa dovunque fosse possibile, all’esterno. Dietro, però, su un rigonfiamento da cui partiva un grosso cavo, c’era solo un ragazzo perché l’appoggio era difficile. Riuscimmo anche noi a salire, impacciati nei nostri colli e restammo in piedi, pigiati da ogni lato.
 Scendemmo in un viale di periferia. Qui c’era gente più distesa, una folla ilare il cui vociare si dondolava a momenti sui rami delle acacie e restava talora come improvvisamente fermo nell’aria. Aspiravo profondamente l’odore delle gaggie, che mi riportava celermente al ricordo di Madonna della Strada. Qui però era costruito tutt’intorno, la strada era incassata tra gli alti fabbricati come un fiume tra alte rive scavate. Una strada di Roma era un po’ come una cupa di campagna, solo che al posto delle sponde di terra con gli arbusti penduli c’erano alte sponde di mattoni e steli di fanali. Adesso sentivo l’odore di frittura che usciva denso da una friggitoria. Odori nuovi per me; buono, piacevole quello che annusai passando davanti a un negozio con la scritta Pizzicheria. Dentro c’erano meravigliose torri di tonde scatolette rosse.
Scendemmo in un viale di periferia. Qui c’era gente più distesa, una folla ilare il cui vociare si dondolava a momenti sui rami delle acacie e restava talora come improvvisamente fermo nell’aria. Aspiravo profondamente l’odore delle gaggie, che mi riportava celermente al ricordo di Madonna della Strada. Qui però era costruito tutt’intorno, la strada era incassata tra gli alti fabbricati come un fiume tra alte rive scavate. Una strada di Roma era un po’ come una cupa di campagna, solo che al posto delle sponde di terra con gli arbusti penduli c’erano alte sponde di mattoni e steli di fanali. Adesso sentivo l’odore di frittura che usciva denso da una friggitoria. Odori nuovi per me; buono, piacevole quello che annusai passando davanti a un negozio con la scritta Pizzicheria. Dentro c’erano meravigliose torri di tonde scatolette rosse.
Voltammo in una strada morta, buia, dove non passava nessuno. Lo zio mi condusse in una latteria, un posto bianco di infinita tristezza. L’odore qui mi stomacava, detestavo il latte. Al banco c’era un uomo tutto vestito di bianco, aveva un lungo grembiule. Odorava di latte, aveva bianchissime le mani. A servire c’era anche una ragazza con un berrettino bianco a forma di bustina. La ragazza rideva con un militare, mentre gli serviva una coppa di panna. Trangugiai senza fiatare il bicchiere di latte che lo zio mi aveva porto. Mi domandò se ne desiderassi ancora. Risposi “Nz, grazie”. Lo zio mi suggerì di dire no invece di nz. “No, grazie”, feci io.
 In quel posto di desolante disperazione, in quel limbo albicante ebbi un urto del sangue, un soprassalto di palpiti nella gola:avevo visto mio padre, seduto a uno dei tavoli lungo il muro, mio padre che mangiava un uovo fritto intingendo nel rosso i pezzetti di pane. In quel sepolcro imbiancato e piastrellato.
In quel posto di desolante disperazione, in quel limbo albicante ebbi un urto del sangue, un soprassalto di palpiti nella gola:avevo visto mio padre, seduto a uno dei tavoli lungo il muro, mio padre che mangiava un uovo fritto intingendo nel rosso i pezzetti di pane. In quel sepolcro imbiancato e piastrellato.
Riprendemmo il tragitto per la strada morta. Passò una solitaria motocicletta a tutto gas, lasciandosi dietro un penetrante odore di olio bruciato. La strada mi pesava nelle gambe, camminavo in silenzio senza sapere dove fossimo diretti, neppure lo avevo domandato. Affrettavo il passo per uguagliare le falcate dello zio taciturno. M’ero incupito, attristato, sentivo un dolore indefinibile, oscuro. Mi entrava dentro per vie sconosciute, non era il dolore delle sassate di Nicolino. Questo era un disgusto, una nausea. Mi dissi che Roma era quel dolore, il mio spasmo indefinibile.
 Eravamo accaldati, camminavamo senza una parola. L’asfalto era molle ed esalava un odore acuto. Le case s’erano fatte rade, finché la strada morta andò a perdersi in un luogo aperto, buio, da cui si vedevano lontani fanali. Arrivammo sotto un caseggiato immenso, altissimo, una enorme scatola grigia che s’innalzava da un terrapieno in mezzo a sterri, al centro di una radura di sterpaglia, dove c’erano cumuli di detriti disseminati qua e là. Ai margini nereggiava l’imponente torre di tubi di un gasometro e, sotto, la sagoma a denti di sega di un tetto di fabbrica dalla tozza ciminiera.
Eravamo accaldati, camminavamo senza una parola. L’asfalto era molle ed esalava un odore acuto. Le case s’erano fatte rade, finché la strada morta andò a perdersi in un luogo aperto, buio, da cui si vedevano lontani fanali. Arrivammo sotto un caseggiato immenso, altissimo, una enorme scatola grigia che s’innalzava da un terrapieno in mezzo a sterri, al centro di una radura di sterpaglia, dove c’erano cumuli di detriti disseminati qua e là. Ai margini nereggiava l’imponente torre di tubi di un gasometro e, sotto, la sagoma a denti di sega di un tetto di fabbrica dalla tozza ciminiera.
Salimmo per una scala che mi parve interminabile, fino alla cima del caseggiato, là dove c’era l’appartamento dello zio. Lì dentro mi sentivo soffocare, lo spazio mi si chiudeva intorno. La zia scambiò brevi parole con lo zio. Mi prepararono una branda nella camera da pranzo e mi mandarono a letto. Ma non potei dormire. Guardavo l’ombra listata della persiana. Noi a casa non avevamo persiane ma imposte e tra queste passavano spiragli di luce, lame in tralice che dividevano il buio della stanza, quando nei pomeriggi di caldura , mia madre ci obbligava ad andare a letto.
Mi alzai e mi misi alla finestra. L’altezza mi sembrava vertiginosa, non ero mai stato così in alto. Guardavo l’abisso della radura,laggiù. Scrutavo il cielo. Le stelle brillavano pallide,sbiadite. Lassù arrivava un indistinto rumore, come un sommesso grugnito. Sentivo una radio, da basso. Una voce falso-flautata cantava:”Vecchia Romaaa, sotto la lunaa, non canti piùùùù…”
Da “Il Giorno dell’ira e altri racconti”di Renato Gabriele, L’Argonauta Editore, 2003

C’è una terra straordinaria in Oriente capace di imprigionare il cuore di chi l’attraversa. La paragonerei ad una stella caduta sulla terra, un angolo di paradiso dimenticato. L’altopiano del Ladakh, chiamato anche il piccolo Tibet. I pendii rocciosi delle valli sono un libro aperto di geologia che affascina chiunque per la varietà dei colori, con l’alternarsi degli strati e delle cenge, con i grandi mammelloni sabbiosi.

Il paese degli alti valichi, nomi che provano a evocare, senza riuscirci completamente, la meravigliosa sensazione di trovarsi in una terra unica al mondo. Oasi polverose circondate che si alternano ai monasteri lamaisti, fortezze in miniatura dove il tempo sembra fermo a un’epoca lontana, un luogo remoto e dalla natura sproporzionata dove tutto ha una sua spiegazione poetica o mistica, frutto della serenità e della fede di uno dei popoli più intimamente religiosi del pianeta.

Entrando silenziosamente nei monasteri della valle dell’Indo, camminando nelle immense distese aride e selvagge circondate dalle vette innevate, sono riuscita a scivolare nella pace di un mondo antico, fatto di persone dai gesti semplici e di una spiritualità così profonda da lasciare tracce indelebili nella propria memoria.
Non puoi percorrere la Via prima di essere diventato la Via stessa.
Gautama Buddh

…… E Tutto scorre
E’ l’antico testo del Kata Sarit Sagar a rammentarci che fra questi due estremi il mondo si evolve e si dissolve in una serie interminabile di cicli attraverso milioni di anni. L’uomo partecipa a questo dilemma, appare e scompare di volta in volta nel corso delle ere.

Il pensiero indiano provvede ad offrire una via di salvezza in questo trauma, attraverso il distacco del proprio io dalla ruota senza fine dell’esistenza. Questo distacco può essere operato quando si raggiunge l’asceteismo e la meditazione, annullando il desiderio di possesso, così che ognuno possa guardare aldilà dell’esperienza umana ed apparente.

Altre vie sono offerte al Karma, raggiungimento degli obiettivi positivi, dalla Bakti, amore e adorazione per dio, dal dharma, senso della giusta azione. Questi percorsi spirituali permettono di raggiungere la moskha (liberazione) che conduce il se aldilà del tempo dove il legame con la causa è profondo ed entriamo in uno stato di sonno senza sogni, conosciuto come turiya.

L’uomo ideale (uttam purusha ) è chi ricerca questa visione e gioisce per il benessere di tutte le creature
Chhandogya Upanishadd 8.12


“Qui dove regna il silenzio , dove il vento arriva annunciato dal fruscio delle foglie , dove i condor dispiegano le ali lanciandosi nel loro volo…
Solo qui la mia anima vagabonda potrebbe restare, per contemplare ogni giorno questa immensità”

Potrei chiudere qui il racconto del mio viaggio in USA perché queste poche mie righe raccontano tutto l’incanto di questa seconda meravigliosa esperienza alla scoperta del continente e di un pezzo di storia americana.
Andare nel cuore dell’America vera, in un viaggio “on the road” é come entrare in un mondo irreale, dove i confini tra il sogno e la realtà sono indefiniti, dove tutto cospira contro l’affannata ricerca di una linea di demarcazione che é difficile trovare, perché in questo posto sogno e realtà si mescolano in un tutt’uno dando vita ad emozioni indescrivibili a parole.
 Cosa si prova andando alla ricerca dei grandi Parchi Nazionali del Colorado, Arizona , Utah, nella “Four Corners Region” fino ad arrivare nel New Mexico a Santa Fe , alla scoperta delle riserve dei Nativi Americani dislocate in questa zona degli States per soddisfare il desiderio di entrare nel mito e con esso diventare parte di quel mito stesso e sentirsi albero, roccia, cielo…insomma, un tutt’uno con l’Universo?
Cosa si prova andando alla ricerca dei grandi Parchi Nazionali del Colorado, Arizona , Utah, nella “Four Corners Region” fino ad arrivare nel New Mexico a Santa Fe , alla scoperta delle riserve dei Nativi Americani dislocate in questa zona degli States per soddisfare il desiderio di entrare nel mito e con esso diventare parte di quel mito stesso e sentirsi albero, roccia, cielo…insomma, un tutt’uno con l’Universo?
E che dire dell’incontro con gli “Harley drivers” che ora come allora percorrono le strade , bandane ed capelli al vento, dritti ed orgogliosi sulla sella nella loro interminabile , inesauribile “easy ride” ?
 Qui le emozioni sono tante: ben delineate eppure indistinte, perché arrivano a raffica. Inaspettatamente. É sufficiente guidare…Basta guardare dal finestrino della tua macchina e, complice la musica country, non fai nemmeno in tempo ad osservare, perché il panorama cambia costantemente e ti avvolge, ti avviluppa, ti sorprende, ti ammalia, ti strega…
Qui le emozioni sono tante: ben delineate eppure indistinte, perché arrivano a raffica. Inaspettatamente. É sufficiente guidare…Basta guardare dal finestrino della tua macchina e, complice la musica country, non fai nemmeno in tempo ad osservare, perché il panorama cambia costantemente e ti avvolge, ti avviluppa, ti sorprende, ti ammalia, ti strega…
Ho attraversato le strade più deserte, contornate da monoliti multiformi e incantati, strade costeggiate da interminabili filari di pali della luce, quelli che si vedono nei film e che adesso sono lì, davanti a te e non ci credi, non ce la fai a credere che quella é la realtà e non un film, perchè tutto si confonde in un mix di desiderio ed appagamento. Ho visto i tramonti più intensi, di quelli che quando ci ripensi ti batte forte il cuore, come per me in questo momento al solo ricordo, ed hai un nodo in gola sopraffatta dalla nostalgia.Ho visto la terra rossa dell’Arizona scivolare sotto le ruote del nostro SUV, dopo aver volteggiato per noi in una meravigliosa danza d’amore, in un turbinio di forme e colori, avanti ai nostri occhi sconvolti da tanta semplice bellezza; occhi desiderosi di posarsi ovunque e di assaporare tutto l’inverosimile che quei posti possano mostrare.

Ci siamo regalati , io e mio marito, compagno di vita e di viaggi, emozioni intense ed abbiamo invidiato il volo dei Condor che si tuffano nelle infinità del Grand Canyon e che con i loro volteggi sono i guardiani della silenziosa immensità che ti avvolge, ti prende, ti inebria e ti fa quasi delirare perché vorresti tuffarti anche tu, con loro, tra le rupi scoscese , laggiù , verso il Colorado che puoi solo vedere da lontano così sorprendentemente verde smeraldo, scorrere maestoso con incedere quasi regale.
E poi, nel viaggio di ritorno verso Los Angeles ci siamo immersi nella storia, quella della “Mother Road” la mitica Route 66 * che, ancora abbigliata in perfetto stile ’50-60 ( e pure ’70, ogni tanto) ci ha fatto divertire e sbarrare gli occhi come bambini difronte alla più bella delle vetrine, perché c’è solo un vetro che ti separa dagli oggetti tanto desiderati ed amati e che sai che, oltrepassando quella barriera, quelle cose saranno tue, anche solo per un momento, anche solo per uno sguardo, perché te li porterai dentro, con te, in quel bagaglio che ti trascini dietro, come una chiocciola e che é la tua memoria.

Si, perché queste sono state emozioni profonde, strabilianti, che ci hanno segnato, ci hanno stregato, perché sentire un vecchio menestrello che con la sua chitarra ti racconta storie nella fragile lunghezza di una ballata e ti culla nella sua melodia che ti riporta indietro nel tempo e nel nirvana dei tuoi ricordi più appassionati non ha prezzo, ed allora tu inforchi gli occhiali affinché nessuno veda le tue lacrime di pura felicitá scorrere sul viso, perché l’impatto con quel pezzetto di vita é stato così forte e così acuto, che non lo puoi condividere con nessuno.
~~~
 *Le città di Kingston, Seligman, Williams, in Arizona,si possono visitare percorrendo l’ultima sezione dell’Interstate 40 che scorre parallela con la Route 66 e che si snoda tra le stesse città , ad ovest di Flagstaff, venendo dall’Arizona verso la California.
*Le città di Kingston, Seligman, Williams, in Arizona,si possono visitare percorrendo l’ultima sezione dell’Interstate 40 che scorre parallela con la Route 66 e che si snoda tra le stesse città , ad ovest di Flagstaff, venendo dall’Arizona verso la California.
Una menzione particolare meritano Peaches Spring e Durango.
La prima bisogna andarsela a cercare. Si trova in Arizona ma il percorso é semplicissimo. Noi siamo partiti dal villaggio di Tusayan, uno dei villaggi per accedere al Grand Canyon South Rim che é raggiungibile transitando sulla 64 che si incrocia sulla Interstate 40, prima di Williams. Da Tusayan si va verso Peaches Spring, percorrendo la Route 66, seguendo le indicazioni. Questa località, composta di quattro casupole e di un paio Hotel xké vicina al Grand Canyon si trova nel territorio della riserva degli Hualapai ed é una delle città che ha maggiormente pagato lo scotto del decadimento della Mother Road a seguito della costruzione della i40.

In questo posto rimangono i resti del Trading Post building e posso dire che qui c’è il nulla assoluto ma questo posto ha un fascino particolare, con le carcasse delle vecchie macchine arrugginite abbandonate dovunque .Oltre a ciò in questo particolare tratto della Mother Road, parlo, nello specifico di quello tra Kingman ed Ash Fork, che rappresenta il tratto più bello della Road 66, c’è qualcosa di peculiare e caratteristico che appartiene alla storia americana. Attraversandola, troverete dei curiosi segnali stradali consecutivi prevalentemente di colore rosso , di forma rettangolare ad “altezza di macchina”. È una serie di cartelli posti a circa 100 metri l’uno dall’altro e che, se letti consecutivamente, formano un breve verso in rima ma che hanno la funzione di attirare l’attenzione del guidatore che, x leggerli, deve necessariamente diminuire l’andatura. in effetti la finalità della presenza di questi segnali é proprio questa.Come si sa, in America si guida piano: ora come allora gli “Highway Patrols” sono sempre in agguato!Questi segnali ricalcano una tecnica pubblicitaria utilizzata da una vecchia marca di schiuma da barba degli anni ’50 :Burma-Shave.

Durango si trova in Colorado, nella regione dei “Four Corners”. Se volete assaporare l’atmosfera vecchio west, se volete entrare nella storia ( ed io ve lo consiglio) se volete rimanere a bocca aperta e rivivere le emozioni che vi riportano alla vostra infanzia quando guardavate i film western o leggevate Tex Will, questo é il posto che fa per voi. Imperdibile.
La “Four Corners Region” é la regione ovest degli USA situata nei pressi del punto in cui le frontiere dell’Arizona, del Colorado, del Nuovo Messico e dello Utah si incontrano. Le parti situate in Arizona, Nuovo Messico e Utah, fanno parte della riserva Navajo, mentre quella del Colorado, é nella riserva Ute.
In essa, si trovano i Parchi Nazionali più particolari e più decantati degli Stati Uniti: la Monument Valley, il Grand Canyon (Arizona),la Foresta Pietrificata (Interstate 40- Arizona)’il Canyon de Chelly, l’Antelope Canyon ( Highway 98-Page-Arizona)


“Il vostro Paese ha la forma di uno stivale, il nostro quella di un gatto!”, così dicono in Iran a noi italiani.
Questo approccio è stato senza dubbio il più curioso tra quelli mesi in atto da chi per tutta la durata del nostro viaggio ci ha avvicinato desideroso di praticare il proprio inglese e di sapere da dove venivamo.
Di questo paese a forma di gatto, con le orecchie a segnare il confine con Turchia ed Azerbaijan, il dorso a segnare i confini con il Turkmenistan e l’Afghanistan, e la coda quello con il Pakistan, ci ha colpito la curiosità (neanche a farlo apposta caratteristica tipicamente felina) dei suoi abitanti, così interessati a sapere che cosa si pensa in occidente dell’Iran e soprattutto di loro, che mai avremmo immaginato essere così ospitali, cordiali, amichevoli e soprattutto così lontani dall’immagine che le informazioni che ci arrivano ci inducono a prefigurare.

E proprio perché inaspettata, la cordialità ed ospitalità dei suoi abitanti è stato l’elemento senza dubbio più caratterizzante del viaggio di tre settimane che mia moglie ed io abbiamo effettuato nella Repubblica Islamica dell’Iran. Eppure un viaggio in Iran offre molteplici spunti di interesse: la storia, l’archeologia, l’architettura, i paesaggi, l’aspetto etnico.
La storia dell’Iran è la storia del mondo. Qui si sono succeduti i maggiori imperi della storia: Medi, Persiani, Greci, Arabi. Persino i Mongoli di Gengis Khan hanno occupato a più riprese il territorio dell’odierno Iran contaminandolo con le proprie culture, tradizioni, religioni.
L’impero persiano è stato tra i più grandi della storia, arrivando ad includere nella sua massima estensione il territorio compreso tra la valle del fiume Indo (nell’odierno Pakistan) e le coste del nord africa e del Mar Rosso.

Le conoscenze sviluppate da questo popolo spaziano in tutti i campi dello scibile umano. Costruirono nel V secolo a.C. la prima strada, un’arteria che collegava il centro dell’Asia con il Mediterraneo per uno sviluppo di circa 2700 chilometri. Implementarono poi un sistema di collegamenti “postali” che consentiva, utilizzando proprio questa strada, di trasmettere informazioni da una parte all’altra dell’impero in una settimana.
Al tempo una carovana mercantile impiegava, su quello stesso percorso, almeno 90 giorni. Questi determinarono con estrema precisione la durata dell’anno solare in un’epoca in cui in Europa si pensava ancora che la terra fosse piatta.
Tra le discipline scientifiche cui gli eruditi persiani dettero un sensibile apporto vi sono la logica, la teoria musicale, l’idrologia, la botanica, la zoologia, la gemmologia, la mineralogia.
Ma è l’architettura l’ambito in cui la Persia ha offerto i maggiori contributi alla cultura mondiale. Ciò è visibile soprattutto con le coperture a cupola delle moschee, le cui stupende decorazioni in ceramica che le arricchiscono sono tra i ricordi più vivi del viaggio.

Già il viaggio: noi avevamo a disposizione tre settimane, tra giugno e luglio, e abbiamo pensato ad un itinerario che ci permettesse una prima conoscenza generale del Paese, traendo ispirazione sia da itinerari percorsi da altri amici che dalle descrizioni delle guide turistiche.
Contattata via e-mail un’agenzia locale, abbiamo iniziato una fitta corrispondenza che ci ha portato a definire compiutamente l’itinerario alcune settimane prima della partenza.
L’agenzia ha inoltre provveduto ad inoltrare al Ministero degli Affari Esteri iraniano la documentazione necessaria per il rilascio, tramite il consolato in Italia, del visto di ingresso. Il nostro viaggio inizia da Teheran, dove rimaniamo un paio di giorni. Giusto il tempo di vedere il bazar, alcuni musei ed imparare ad usare la valuta locale.
Beh, a dire il vero abbiamo avuto incertezze sui prezzi fino alla fine del viaggio, ma del resto come potrebbe essere altrimenti? Hanno una moneta che si chiama Rial, però i prezzi li indicano in Toman (la decima parte del Rial) … insomma, le figuracce al momento di pagare qualcosa sono pressochè inevitabili.

Nella capitale, ma la sensazione ci accompagnerà in tutte le principali città visitate, prendiamo subito atto di quale sia il vero, grande pericolo per chi viaggia in Iran: il traffico!
Non esistono regole: i semafori sono considerati poco più di un suggerimento, in autostrada sono ammesse le inversioni ad U, la precedenza agli incroci è di chi arriva prima o del più grande. Nonostante questa sorta di caos organizzato incredibilmente non abbiamo mai visto incidenti.

Lasciata Teheran abbiamo iniziato il tour verso il nord del Paese, che ci ha portato a Tabriz dopo aver toccato le città di Qazvim, Anzali Abbas, Astara, Ardabil ed i villaggi di Mausoleh e Kandovan.

Da Tabriz in volo abbiamo raggiunto la città di Shiraz, nel sud ovest dell’Iran, dove si dice sia stato “inventato” il vino settemila anni fa. E’ considerata la culla della poesia persiana, avendo dato i natali a due dei massimi poeti iraniani: Saadi e Hafez. In Iran la poesia è amatissima.
Le tombe dei poeti sono spesso inserite in giardini o piccoli parchi, frequentatissimi soprattutto al tramonto dalla gente e da molti giovani, che amano leggere i versi dei grandi maestri.
Si dice che tutti gli iraniani abbiano almeno due libri nelle proprie case: il Corano e le liriche di Hafez, e non sempre in quest’ordine di importanza …

Shiraz può costituire un’ottima base per escursioni giornaliere nei dintorni. Da segnalare in particolare verso Persepolis e la vicina necropoli con le tombe scavate sulla roccia di Dario, Serse ed Artaserse.
Le rovine di Persepolis, il luogo più visitato dell’intero Iran, danno immediatamente l’idea di quale possa essere stata la grandezza di uno dei più potenti imperi del mondo antico.

Da Shiraz ci siamo spinti ulteriormente verso est fino alla città di Kerman. Questa appare come un’oasi nella vasta area che costituisce l’appendice meridionale del deserto Dasht-e Luth, che occupa la gran parte dell’est Iran. La città è una delle più antiche dell’Iran. La sua vicinanza con le principali direttrici del commercio con l’estremo oriente ne ha fatto un crogiuolo di etnie e culture diverse.

Da Kerman abbiamo raggiunto, con un’escursione giornaliera, il punto più meridionale del nostro itinerario: la cittadella di Bam. Bam è stata completamente distrutta dal violento terremoto del 2003 ma ora in avanzata fase di ricostruzione.
Prima del cataclisma rappresentava il massimo esempio mondiale di cittadella interamente realizzata in mattoni crudi.
Ora questo primato è detenuto dalla cittadella di Rayen, ad un centinaio di chilometri da Kerman e da qui facilmente raggiungibile.
Nel corso della stessa escursione che ci ha portati a visitare Bam e Reyan. Abbiamo poi visitato anche gli splendidi giardini di Mahan, caratterizzati da una serie di fontane e ruscelletti circondati da alberi e fiori, una vera e propria oasi immersa nell’arido paesaggio desertico del sud est dell’Iran.

Da Kerman è iniziato quindi il percorso di ritorno verso Teheran, con tappe nelle città di Yazd, Isfahan e Kashan. Isfahan per noi è la città che più di ogni altra evoca il fascino dell’antica Persia e sintetizza l’Iran attuale.
La sua piazza principale, Imam Square, attrae come una calamita i visitatori che durante le passeggiate alla scoperta della città vi ritornano continuamente.
Questa splendida piazza è seconda per dimensioni solo alla piazza Tien An Men, ed è racchiusa da lunghe mura in mattoni ad arcate sovrapposte, con il piano inferiore occupato da negozi.

Al tramonto la piazza si anima di moltissime persone. Alcune si portano da casa il cibo che consumano seduti sulle panchine o sul prato che circonda la grande fontana centrale. I ricordi e le emozioni maggiori del viaggio li dobbiamo proprio a questo posto.
Seduti ad osservare questo spettacolo di varia umanità, ci siamo lasciati avvicinare dai più curiosi ed intraprendenti di loro ed abbiamo conversato a lungo dei più disparati argomenti.
La pallavolo (“avete visto alla televisione l’Iran battere l’Italia?”), il lavoro (“che lavoro fate? Quanto si guadagna in Italia? Che cosa fanno gli italiani quando vanno in pensione?”), la famiglia (“quanti figli avete? Non avete figli?!?, Perché?”).
E poi… la politica (“non dovete pensare che il popolo iraniano sia come il governo iraniano …”), la condizione femminile (“il vero problema non è dover indossare il velo, è che alle donne sono proibite molte professioni e che in caso di divorzio i figli vengono affidati sempre al padre …”).
Sarà forse perché questa esperienza l’abbiamo vissuta ormai alla fine del viaggio, ma quando ripensiamo all’Iran (e ci capita molte volte di farlo) il ricordo va subito ad Isfahan ed alle ore trascorse nella sua magica piazza.

Dal punto di vista fotografico, l’Iran è tra i luoghi più fotogenici che ho visitato. Ci sono bellissimi paesaggi, soprattutto al limite dell’area desertica. Non oso pensare quanto meravigliosi possano essere certi paesaggi montani in primavera o in autunno, con la vegetazione al suo massimo splendore.

Ci sono architetture tra le più belle e raffinate che mi sia mai capitato di vedere. Le persone poi, se glielo si chiede, sono per lo più disponibili a farsi fotografare, e per la prima volta ci è capitato che qualcuno ci chieda di potersi fotografare in nostra compagnia.
In virtù di questa disponibilità da parte delle persone, mi sono ritrovato ad usare prevalentemente obiettivi zoom grandangolari. Questi sono essenziali anche per enfatizzare gli imponenti elementi architettonici delle moschee e degli altri palazzi (portali, archi, colonnati, cupole).
Qualche problema tecnico di esposizione corretta lo si ha per la forte luce ed il riverbero (dovuto alla presenza di pulviscolo in sospensione nell’aria) presenti soprattutto nelle zone del centro e del sud vicine al grande deserto orientale. Per questo motivo può capitare di ricorrere ad esposizioni manuali per compensare l’escursione di oltre tre diaframmi tra zone illuminate e zone in ombra.

E’ un viaggio che mi sento di raccomandare caldamente, non vi deluderà. Ritengo che il periodo migliore sia la primavera o l’autunno, ma il caldo estivo è comunque facilmente sopportabile dato il bassissimo tenore di umidità dell’aria.

E allora, BUON VIAGGIO!
Riccardo Panozzo
333 5743082
rikipan@alice.it

A chi fosse eventualmente interessato ad organizzarsi autonomamente il viaggio, posso fornire i riferimenti della guida che ci ha accompagnato nella seconda parte del viaggio. E’ un ottimo autista oltre che guida molto competente, può supportarvi nell’organizzazione del viaggio anche se doveste essere un piccolo gruppo.


Questo ci dice Umberto Saba:” Trieste ha una scontrosa/ grazia. Se piace,/ è come un ragazzaccio aspro e vorace,/ con gli occhi azzurri e mani troppo grandi/ per regalare un fiore;/ come un amore/ con gelosia.”
 Sono versi che ritroviamo nel libro”Trieste e una donna”, che raccoglie le poesie scritte tra l’anno 1910 e il ’12 e che in particolare include i versi ispiratigli dalla sua città. Di essa egli compone un ritratto intimo, velato di una sorta di gelosia per i luoghi che a lui sono di conforto e che non vorrebbe condividere con nessuno. Quei luoghi stessi, che egli nomina indicandone talvolta la reale toponomastica, sono da lui ricercati come ricetto e rifugio alla sua agitata esistenza, che sappiamo turbata da ricorrenti stati di perniciosa malinconia e di depressione. Nonostante questo male dell’anima le poesie di cui parlo, come del resto gran parte della poesia di Umberto Saba, hanno la singolare trasparenza e la trasognata delicatezza di cui è capace la sua lingua piana e persuasiva, la lingua, appunto, degli affetti e degli intimi moti del cuore.
Sono versi che ritroviamo nel libro”Trieste e una donna”, che raccoglie le poesie scritte tra l’anno 1910 e il ’12 e che in particolare include i versi ispiratigli dalla sua città. Di essa egli compone un ritratto intimo, velato di una sorta di gelosia per i luoghi che a lui sono di conforto e che non vorrebbe condividere con nessuno. Quei luoghi stessi, che egli nomina indicandone talvolta la reale toponomastica, sono da lui ricercati come ricetto e rifugio alla sua agitata esistenza, che sappiamo turbata da ricorrenti stati di perniciosa malinconia e di depressione. Nonostante questo male dell’anima le poesie di cui parlo, come del resto gran parte della poesia di Umberto Saba, hanno la singolare trasparenza e la trasognata delicatezza di cui è capace la sua lingua piana e persuasiva, la lingua, appunto, degli affetti e degli intimi moti del cuore.
 Una singolare attrattiva dei luoghi può talvolta consistere nella ricerca di rispondenze, per quanto tenui, per quanto affievolite dal tempo e dalle mutazioni subite dai contesti urbani, di rispondenze, dicevo, tra la descrizione fattane da taluno, in specie da uno scrittore o da un pittore, e lo stato attuale. E, in questo caso, il possibile intento sarebbe quello di verificare la residuale esistenza di quelle impressioni, di quell’archeologia del sentimento: impresa ardua, è vero, ma proprio per questo appassionante.
Una singolare attrattiva dei luoghi può talvolta consistere nella ricerca di rispondenze, per quanto tenui, per quanto affievolite dal tempo e dalle mutazioni subite dai contesti urbani, di rispondenze, dicevo, tra la descrizione fattane da taluno, in specie da uno scrittore o da un pittore, e lo stato attuale. E, in questo caso, il possibile intento sarebbe quello di verificare la residuale esistenza di quelle impressioni, di quell’archeologia del sentimento: impresa ardua, è vero, ma proprio per questo appassionante.

Umberto Saba ci dà di Trieste sia la veduta complessiva: quell’azzurra luminosità, quei colori (“circola ad ogni cosa/ un’aria strana, un’aria tormentosa,/ l’aria natia”) sia la veduta particolareggiata: quel mare, quella gente (“Qui prostituta e marinaio, il vecchio/ che bestemmia, la femmina che bega,/ il dragone che siede alla bottega/ del friggitore,/ la tumultuante giovane impazzita/ d’amore…”). La possibile rivisitazione dei luoghi non raffigura dunque una sorta di convenzionale pellegrinaggio turistico, bensì un’appassionata ricerca di atmosfere, quelle che certi posti sanno restituirci semplicemente con il mostrare l’opera del tempo. Del resto non si tratta qui di luoghi celeberrimi come la “siepe dell’infinito”, autenticamente mitizzata, non si tratta di luoghi citati con intento celebrativo ma semplicemente di posti dai nomi familiari e dunque direttamente evocativi di umani affetti.
 Restando ai versi di Umberto Saba, si potrebbe dunque ricercare la Via del Lazzaretto Vecchio: “C’è a Trieste una via dove mi specchio/ nei lunghi giorni di chiusa tristezza:/ si chiama Via del Lazzaretto Vecchio./ Tra case come ospizi antiche uguali,/ ha una nota,una sola, d’allegrezza:/ il mare in fondo alle sue laterali./ Odorata di droghe e di catrame/ dai magazzini desolati a fronte,/ fa commercio di reti,di cordame/ per le navi…” E ancora: “ A Trieste ove son tristezze molte,/ e bellezze di cielo e di contrada,/ c’è un’erta che si chiama Via del Monte. Incomincia con una sinagoga,/ e termina ad un chiostro; a mezza strada/ ha una cappella, indi la nera foga della vita scoprire puoi da un prato,/ e il mare con le navi e il promontorio,/ e la folla e le tende del mercato./ Pure, a fianco dell’erta, è un camposanto/ abbandonato…”, “ ma la via della gioia e dell’amore/ è sempre Via Domenico Rossetti./ Questa verde contrada suburbana,/ che perde dì per dì del suo colore,/ che è sempre più città,meno campagna/ serba il fascino ancora dei suoi belli/ anni, delle sue prime ville sperse,/ dei suoi radi filari d’alberelli…” Il poeta ci parla anche della Via della Pietà, “sì lunga e stretta come una barella./ Hanno abbattute le sue vecchie mura,/ e di qualche ippocastano si abbella.”
Restando ai versi di Umberto Saba, si potrebbe dunque ricercare la Via del Lazzaretto Vecchio: “C’è a Trieste una via dove mi specchio/ nei lunghi giorni di chiusa tristezza:/ si chiama Via del Lazzaretto Vecchio./ Tra case come ospizi antiche uguali,/ ha una nota,una sola, d’allegrezza:/ il mare in fondo alle sue laterali./ Odorata di droghe e di catrame/ dai magazzini desolati a fronte,/ fa commercio di reti,di cordame/ per le navi…” E ancora: “ A Trieste ove son tristezze molte,/ e bellezze di cielo e di contrada,/ c’è un’erta che si chiama Via del Monte. Incomincia con una sinagoga,/ e termina ad un chiostro; a mezza strada/ ha una cappella, indi la nera foga della vita scoprire puoi da un prato,/ e il mare con le navi e il promontorio,/ e la folla e le tende del mercato./ Pure, a fianco dell’erta, è un camposanto/ abbandonato…”, “ ma la via della gioia e dell’amore/ è sempre Via Domenico Rossetti./ Questa verde contrada suburbana,/ che perde dì per dì del suo colore,/ che è sempre più città,meno campagna/ serba il fascino ancora dei suoi belli/ anni, delle sue prime ville sperse,/ dei suoi radi filari d’alberelli…” Il poeta ci parla anche della Via della Pietà, “sì lunga e stretta come una barella./ Hanno abbattute le sue vecchie mura,/ e di qualche ippocastano si abbella.”
L’intima cosmologia del poeta si compone di molti posti non nominati ma descritti con vaghezza come altrettanti topoi dell’anima, luoghi che esercitano su di lui quel fascino recondito che percorre le strade del cuore e che è bello e ci commuove senza un motivo preciso, un motivo che noi stessi non vogliamo approfondire al solo scopo di restare nella suggestione dell’intenerita maraviglia. Un ultimo posto voglio citare. Questo è il Molo: “ Per me al mondo non v’ha un più caro e fido/ luogo di questo. Dove mai più solo/ mi sento e in buona compagnia che al molo/ San Carlo, e più mi piace l’onda e il lido?”
 Molto si è scritto di Trieste, molti passi vi sono e anche saggi ad opera dei suoi celebri scrittori, molto si può dire di questa città, città giovane e cresciuta con foga. A me piace pensarla come la città del vento, come la città spazzata dal vento. Le strade del vento s’incrociano nel cielo, in un freddo mattino di campane. Sotto un cielo d’ardesia, lentamente marcisce l’autunno nei giardini.
Molto si è scritto di Trieste, molti passi vi sono e anche saggi ad opera dei suoi celebri scrittori, molto si può dire di questa città, città giovane e cresciuta con foga. A me piace pensarla come la città del vento, come la città spazzata dal vento. Le strade del vento s’incrociano nel cielo, in un freddo mattino di campane. Sotto un cielo d’ardesia, lentamente marcisce l’autunno nei giardini.

Il 24 settembre si è conclusa, con la proclamazione dei vincitori, la seconda edizione del “Premio per il Reportage” intitolato al giornalista e scrittore polacco Ryszard Kapuściński, manifestazione che si è tenuta come anteprima della più ampia rassegna intitolata “Festival della letteratura di viaggio“, in svolgimento a Roma fino al 29 settembre.
Questo premio vive grazie all’iniziativa dell’Istituto Polacco di Roma in collaborazione con la famiglia Kapuściński e con Feltrinelli Editore.
 Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, anche Alicja Kapuścińska, vedova dello scrittore, Jaroslaw Mikolajewski, il noto poeta e giornalista polacco, che è stato fino a pochi mesi fa direttore dell’Istituto Polacco di Roma, e Marino Sinibaldi, giornalista di Radio Rai e conduttore radiofonico, molto noto come instancabile promotore e animatore di grandi iniziative culturali, il quale ha coordinato gli interventi dei partecipanti alla serata ed ha intervistato i premiati.
Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, anche Alicja Kapuścińska, vedova dello scrittore, Jaroslaw Mikolajewski, il noto poeta e giornalista polacco, che è stato fino a pochi mesi fa direttore dell’Istituto Polacco di Roma, e Marino Sinibaldi, giornalista di Radio Rai e conduttore radiofonico, molto noto come instancabile promotore e animatore di grandi iniziative culturali, il quale ha coordinato gli interventi dei partecipanti alla serata ed ha intervistato i premiati.
La manifestazione si è svolta a Roma, in Campidoglio nella splendida sala Pietro da Cortona, alla presenza di un folto pubblico, nel quale abbiamo riconosciuto persone di grande spicco del mondo culturale italiano e polacco.
Sono stati premiati, nell’ordine, il fotografo Ferdinando Scianna, lo scrittore Francesco M.Cataluccio, e il giornalista e scrittore Paolo Rumiz, tutti e tre personaggi di alto profilo che non hanno bisogno di presentazioni.
Il clima della serata è stato molto piacevole, direi soprattutto per il modo informale in cui si è svolta, un modo improntato all’amicizia e soprattutto alla rievocazione della figura di Kapuściński, del quale, oltreché i meriti di grande reporter e scrittore, nonché di poeta, come forse non molti sanno, è stata delineata la figura umana in aspetti inediti quanto interessanti.
Le prospettive più squisitamente umane e personali di lui sono state messe in risalto dagli interventi della vedova di Kapuściński e dai tre premiati, che con grande generosità hanno poco parlato del proprio lavoro e invece hanno molto parlato di lui, dei loro ricordi provenienti dalla frequentazione diretta con lo scrittore e del significato da lui avuto, quando vi è stato, come punto di riferimento pratico,e anche simbolico, di un modo di lavorare e di scrivere.
Io stesso ho avuto il piacere di conoscere personalmente lo scrittore, che ho incontrato varie volte, e sempre ne ho ammirato la figura schiva e come inconsapevole della propria grandezza, quella che invece gli è stata universalmente riconosciuta fino a consacrarlo come l’autentico scopritore del reportage giornalistico.
 Renato Gabriele
Renato Gabriele

con la direzione artistica del fotografo Roberto Gabriele e l’aiuto di numerosi Partner, tra cui VISIVA, Photographers.it, Fotolia, TuttoDigitale, Trasportando.com, Viaggiofotografico.it e FotoSciamanna organizzano la “Prima Maratona Fotografica di Roma”. Un evento fotografico originale per tutti i Romani e non solo: Ambientato nelle atmosfere della Roma degli Anni 50 e 60, dedicato alle bellezze della Capitale e alla voglia di vivere, avrà come riferimento il film Vacanze Romane, che proprio quest’anno compie sessant’anni.
La “Prima Maratona Fotografica di Roma” si terrà il 20 Ottobre 2013 alle ore 9,00, nel weekend di apertura dei Photographers Days.
La Roma degli Anni ’60 al tempo del film Vacanze Romane. L’Organizzazione mette a disposizione lungo il percorso dei Figuranti in Costume Anni ’60 che saranno liberamente fotografabili e avranno già fornito apposita Liberatoria di utilizzo valida per tutti i Partecipanti regolarmente iscritti.
Possono partecipare Professionisti e Fotoamatori che abbiano compiuto almeno 18 anni, e i minorenni accompagnati da un genitore.
Non sono ammessi a partecipare alla Maratona Fotografica: i membri della Giuria, i componenti della Segreteria, tutti i soggetti che a vario titolo collaborino all’organizzazione della Maratona Fotografica ed i rispettivi familiari.
Si può partecipare una fotocamera di qualsiasi tipo: Reflex, Mirrorless, Compatte e Cellulari. Sono ammesse fotografie in Bianco e nero, a Colori, comunque scattate o postprodotte, sono anche ammessi tutti i tipi di supporti digitali, su pellicola o a Sviluppo Immediato.
Ciascun Partecipante potrà fotografare liberamente i Figuranti in costume anni ‘60 messi a disposizione dall’Organizzazione e ottenere delle immagini che evochino visivamente quel periodo. E’ anche possibile per ciascun Autore organizzare dei propri set personali portando dei propri figuranti in costume e abbellire il proprio set con auto e moto d’epoca.
La manifestazione NON è una gara a tempo e si svolge su strade aperte al traffico e al pubblico, il percorso è itinerante ma molto breve proprio per dedicare la massima attenzione alla qualità fotografica nel rispetto delle norme di Circolazione previste dal Codice della Strada il cui rispetto è fatto comunque obbligo a tutti i Partecipanti ed eventuali infrazioni sono assolutamente da NON imputare nè direttamente nè indirettamente agli Organizzatori.
Quote di Iscrizione a persona:
15 euro Easy Card
30 euro vip Card (Maratona accompagnati in mini gruppo da un Coach di riferimento)
Per i primi 200 iscritti si applica un prezzo speciale scontato al 50%!
La Segreteria della Maratona Fotografica è presso: VISIVA, via Assisi 117, Roma
WEB: http://www.visiva.info/ EMAIL: info@visiva.info
Le iscrizioni sono aperte ON LINE fino al 19 ottobre online dall’apposito form, pagamento con qualsiasi carta credito/debito ma anche presentandosi presso Visiva la Città dell’Immagine in via Assisi 117 Roma
Si, le 30 foto più votate verranno stampate ed esposte a partire dal 27 ottobre presso Visiva.
Le Stampe fine art delle trenta opere saranno offerte e realizzate dal partner FotoSciamanna.
le 3 foto migliori verranno ricompensate con degli OMAGGI forniti dai Partner della Maratona:
Il regolamento è consultabile direttamente sul nostro sito cliccando qui. L’adesione alla Maratona Fotografica prevede l’accettazione completa ed incondizionata del Regolamento.

Questo Viaggio risale al 2007, quando andai con l’amica Egittologa Stefania Sofra a documentare le meraviglie del Cairo, una città a sole 3 ore di volo dall’Italia eppure ai più sconosciuta…. Pochi pensano di poterci fare un week end, quasi nessuno va a farlo…. E invece il Cairo saprà stupirti…


In questo articolo voglio raccontarti della mia esperienza fatta alla Città dei Morti, un intero quartiere con decine di migliaia di abitanti che vivono abitualmente in un antico cimitero mamelucco.
Negli anni ’30 del secolo scorso, circa 80 anni fa, le famiglie più povere della città in cerca di alloggio trovarono comodo andare a vivere nelle cappelle del vecchio cimitero abbandonato a pochi passi dal Centro. Un territorio enorme, una vera città attraversata da ampi Viali che si allungano lungo i muri delle enormi cappelle cimiteriali… Ogni antica famiglia mamelucca aveva una cappella con annesso un piccolo appezzamento di terreno per le sepolture in terra, anche se molti sceglievano di farsi seppellire nei cenotafi, una sorta di tomba in muratura che fuoriesce dal terreno…

Le famiglie quindi occuparono il vecchio cimitero senza che nessuna Amministrazione facesse a questo opposizione, era un luogo abbandonato e quelli disposti ad abitarci erano fondamentalmente dei disperati che conveniva relegare lì piuttosto che tenerli a bivaccare come barboni in mezzo alla città. Passarono gli anni e le case prese gratis iniziarono a diventare delle dimore che a costo zero iniziavano ad essere meglio che niente e con il passare del tempo queste prolungate occupazioni diventarono per vari motivi (usufrutto, riscatto, usocapione ecc.) a tutti gli effetti di proprietà di coloro i quali le avevano occupate.
Oggi il quartiere di certo non è diventato di lusso come i Doks di Londra abitato dalla gente bene, anzi, continua ad essere un luogo molto umile ma dignitoso e contrariamente a quanto si possa immaginare è un posto molto tranquillo da visitare. E’ piuttosto desolato: la gente qui si alza presto al mattino per andare a lavorare e durante il giorno non vedrai in giro quasi nessuno, i pochi che restano sono persone molto accoglienti che ti faranno entrare in casa loro a vedere come nelle vecchie tombe oggi ci siano stati piantati i pomodori dell’orto…. Ti mostreranno come i cenotafi oggi siano i loro piani di cottura o dei giardini pensili da innaffiare tutti i giorni…

Il Governo di oggi, come quello di 80 anni fa, continua a tollerare la situazione ma non ad accettarla, di certo nessuna guida mai ti parlerà di questo quartiere, di certo se l’Amministrazione potesse farlo sparire lo farebbe, ma ci abitano troppe persone e non è possibile raderlo al suolo nè togliere le case a chi con tanta fatica se le è riscattate. Troverete difficile anche farvi accompagnare qui da un taxi, è strano , ma agli Egiziani questo posto proprio non piace.


Di certo se capiti al Cairo una visita di un paio di ore alla città dei morti conviene farla per scoprire una vera città in cui non ci sono quasi per niente automobili, in cui durante il giorno il silenzio è assordante e il pomeriggio nelle strade si riversano a giocare i bambini dopo la scuola, nel pomeriggio vale la pena venire qui, quando gli abitanti sono in casa e ti mostreranno dove e come vivono, dove ti offriranno un thè comodamente seduto su una cassetta per frutta all’ombra di un pergolato fatto di lamiera… Qui gli unici rumori durante il giorno sono quelli del martello del fabbro che echeggia a centinaia di metri di distanza o di piccole macchine tessili quando passi davanti ad una bottega la cui porta resta sempre rigorosamente aperta…
Tieniti pronto: qui farai un salto in un luogo senza tempo, sospeso tra modernità e tradizione, torneremo con Viaggio Fotografico alla Città dei Morti, se vuoi essere informato di quando partiremo contattami:
Roberto Gabriele: 347 3790441 oppure via email o WEB:
robertogabrielefotografo@gmail.com

Per concludere, vorrei condividere con Te che hai letto fin qui questo Articolo, una mia bella soddisfazione: le foto che stai vedendo sono state utilizzate come sigla finale del programma Mediterraneo su RAI3 nella puntata del 9 giugno 2013.
Ringrazio Adelaide Costa che ne curò la selezione e il montaggio.

Tanti sono i motivi per amare un luogo ma a volte ne basta uno soltanto e così, del resto, accade anche per le persone. Per innamorarsi di una donna potrebbe bastare invaghirsi di un particolare, che so: la voce, il modo di ravviarsi i capelli, di camminare, il modo di ridere o di cantare… Tutti elementi o addirittura frammenti della donna-archetipo che ognuno si porta nella testa. Non era forse accaduto così per Andreas, il protagonista de “Il treno era in orario” di Heirich Boll? Egli, disteso ferito al margine di una strada in Francia, durante la seconda guerra mondiale, si era innamorato dello sguardo di una donna, sì aveva conosciuto il più vero e profondo amore in una frazione di secondo, specchiandosi negli occhi di una donna che non aveva più rivista.
 Se dovessi ridir le ragioni del mio amore per l’Irlanda, farei presto a elencarle. Dico subito che non ho mai approfondito gli avvenimenti storici del Novecento in quell’amato Paese, trovandoli in verità ingarbugliati e soprattutto capaci di distogliermi appunto dall’amore per quell’archetipo-Irlanda che mi ero formato nel cervello. Del resto, mi dico, accade anche così per coloro che amano l’Italia, non stanno a guardar tanto per il sottile alla nostra storia, specialmente a quella recente!
Se dovessi ridir le ragioni del mio amore per l’Irlanda, farei presto a elencarle. Dico subito che non ho mai approfondito gli avvenimenti storici del Novecento in quell’amato Paese, trovandoli in verità ingarbugliati e soprattutto capaci di distogliermi appunto dall’amore per quell’archetipo-Irlanda che mi ero formato nel cervello. Del resto, mi dico, accade anche così per coloro che amano l’Italia, non stanno a guardar tanto per il sottile alla nostra storia, specialmente a quella recente!
Quanto alla mia passione per la terra irlandese, essa è incominciata con “Quiet man” di John Ford, “Un uomo tranquillo”, il film con John Wayne e Maureen O’Hara. L’avevo visto all’età di dieci anni e fin dalla prima volta mi aveva affascinato, a pensarci bene, per la forza dei sentimenti che tutti i personaggi esprimevano. Sarà stata forse la mia troppo precoce orfanezza di padre a farmi ravvisare nella gagliarda personalità di John Wayne un modello di un uomo protettivo, un tipo buono per me, una sorta di padre ideale, chissà! Fatto sta che quella pellicola mi si era stampata indelebilmente nella mente offrendomi il primissimo spunto di amor d’Irlanda. Dopo di allora mi è capitato di rivedere quel film in televisione e soprattutto, con l’avvento delle videocassette, di riguardarlo un’infinità di volte, sempre aumentando i motivi di interesse. Una fissazione? Può darsi! Potrei raccontare scena per scena, ad iniziar dall’arrivo del treno e dall’annuncio del capotreno:-Castletown! Potrei dire della curiosità, che anima tutti coloro che sono nella stazione, di sapere chi sia quello straniero che è sceso dal vagone, potrei descrivere tante scene, per finire con il racconto della grande scazzottata finale che non rappresenta il culmine di una inimicizia ma, direi, l’inizio di una generale pacificazione.
Adesso l’intero film mi detta una serie di motivi di apprezzamento, ad iniziare dalla bella musica che accompagna la vicenda, seguitando con l’aspra bellezza dei luoghi e soprattutto con l’incanto del verde, con l’assorta bellezza di quella verdità che non è soltanto un colore ma direi piuttosto un concetto, tanti sono i toni affluenti, tante le sfumature che vanno a comporre quell’entità che siamo soliti designare come “il verde”. Proprio questo, il verde, è il cuore dell’Irlanda, così come da tutti è riconosciuto. E possibile allora che un unico film abbia determinato in me una tanto amorevole inclinazione? Indubbiamente siamo davanti a un’opera d’arte, e non è questa la capacità sublime di ogni lavoro che possa definirsi in quel modo.
 “Un uomo tranquillo” è un’opera di poesia, di poesia degli affetti ma contiene non effimeri brani di epos. Sean Torton-John Wayne ritorna a Innisfree, la sua patria elettiva, dopo un tratto della sua vita vissuta in America. Ritorna al luogo del sogno, sulle rive del lago di Innisfree, di cui nel film abbiamo magnifiche scene di tramonto. La pellicola narra la vicenda di un uomo ma anche di una donna e di tutto un villaggio, che alla fine ci si presenta come un luogo di favola, una sorta di Brigadoon, in cui sia possibile la felicità e questa sia ottenibile con la semplicità del vivere e l’autenticità degli schietti sentimenti.
“Un uomo tranquillo” è un’opera di poesia, di poesia degli affetti ma contiene non effimeri brani di epos. Sean Torton-John Wayne ritorna a Innisfree, la sua patria elettiva, dopo un tratto della sua vita vissuta in America. Ritorna al luogo del sogno, sulle rive del lago di Innisfree, di cui nel film abbiamo magnifiche scene di tramonto. La pellicola narra la vicenda di un uomo ma anche di una donna e di tutto un villaggio, che alla fine ci si presenta come un luogo di favola, una sorta di Brigadoon, in cui sia possibile la felicità e questa sia ottenibile con la semplicità del vivere e l’autenticità degli schietti sentimenti.
Avanzando nell’età ho letto, come tutti, qualche scrittore irlandese ma senza dare gran peso al luogo di origine come, ad esempio,nel caso di Samuel Beckett, che per quanto mi riguarda potrebbe essere francese o inglese.
Non così con Seamus Heaney, che per mia buona ventura conoscevo dall’epoca precedente all’assegnazione del Nobel, per averlo incontrato nelle pagine di quella gloriosa rivista che fu “Uomini e Libri”, che tanto ha fatto per far conoscere in Italia la poesia del resto del mondo. Heaney mi appariva come un autentico poeta irlandese, con quel suo ricondursi alla tradizione della sua terra, alle eroiche leggende dell’Irlanda, ai personaggi mitici della sua storia.
Non così soprattutto con James Joyce di cui, per mia maggior ventura, ho letto “Ulisse” nella prima traduzione mai fatta in italiano, quella di Giulio De Angelis, con la consulenza di Glauco Cambon, Carlo Izzo e Giorgio Melchiori, quel bellissimo volume in cofanetto stampato su carta giallo-pallido nella collezione I classici contemporanei stranieri diretta da Giansiro Ferrata per Arnoldo Mondadori Editore. Lessi “Ulisse” nel 1961, quando avevo diciotto anni. Fu un’esperienza incredibile, rappresentò per me una profonda revisione di schemi, soprattutto di quelli discendenti dall’insegnamento scolastico, nella sostanza si tradusse in una operazione analoga a quella che avevo compiuto appena un anno addietro, quando avevo conosciuto la poesia di Federico Garcia Lorca, che d’incanto mi aveva sottratto all’ostaggio carducciano, a tutta la monumentalità della poesia. Scoprivamo il flusso di coscienza, vi ci introduceva J.Joyce. In quel periodo si trattò di un evento fenomenale, basti dire che tutte le stelline del cinema, interrogate su quale fosse il libro preferito, attestavano con sicurezza sospetta e senza interporre alcun tempo di dubbiosa riflessione: – Ulisse, di James Joyce! Non saprei riferire ora quanto allora ci avessi capito, posso dire però che l’Irlandese mi aveva conquistato. Non avrei mai più dimenticato la figura del paffuto Buck Mulligan né il sole che saliva sul grigio mare della baia di Dublino (una dolce madre grigia) mentre lui officiava una scherzosa, blasfema?, pantomima della messa con il bacile di schiuma per radersi. E come dimenticare l’errabonda giornata di Leopold Bloom, il borghesuccio ebreo, e di Stephen Dedalus, l’intellettuale tormentato e problematico? Come scordarsi la figura di Molly, come l’attraversamento di Dublino in quella giornata del 16 giugno del 1904?
Qualunque cosa avessi allora capito del libro, riuscii forse ad afferrare qualche nuovo significato ogni volta, quante?, che lo ebbi riletto. Soltanto dopo lessi le poesie joyciane, soltanto dopo Dedalus e Gente di Dublino. L’Irlanda aveva in Joyce uno scrittore geniale! Il più grande del secolo, dicono. Lui sì che mi appariva un grande irlandese! Fu lui a rinsaldare il mio vincolo con quella verde isola. Lui e William Butler Yeats. Di quest’ultimo, per chiudere il cerchio con Innisfree, di cui ho parlato all’inizio riferendomi al ritorno di Sean Torton-John Waine, voglio citare soltanto i meravigliosi versi de L’isola del lago d’Innisfree, nella traduzione di Roberto Sanesi (Mondadori):
 Io voglio alzarmi ora, e voglio andare,andare ad Innisfree,
Io voglio alzarmi ora, e voglio andare,andare ad Innisfree,
E costruire là una capannuccia fatta d’argilla e vimini:
Nove filari a fave voglio averci,e un alveare,
E vivere da solo nella radura dove ronza l’ape.
E un po’ di pace avrò, ché pace viene lenta
Fluendo stilla a stilla dai veli del mattino, dove i grilli
Cantano: e mezzanotte è tutta un luccicare, ed il meriggio brilla
Come di porpora, e l’ali dei fanelli ricolmano la sera.
Io voglio alzarmi ora, e voglio andare, perché la notte e il giorno
Odo l’acqua del lago sciabordare presso la riva con un suono lieve;
E mentre mi soffermo per la strada, sui marciapiedi grigi,
Nell’intimo del cuore ecco la sento.
Parti con noi, vieni a scoprire i luoghi descritti in questo bellissimo Articolo di Renato Gabriele Partiremo per l’Irlanda dal 2 al 12 agosto 2013 con un Viaggio Fotografico adatto a tutti: Fotografi incalliti e Appassionati alle prime armi.

Un posto dove mangiare un ottimo Burritos a Dublino è il “Saburritos” tipica cucina messicana nella Tabol Street, proprio difronte alla statua dello scrittore James Joice. L’ambiente è confortevole per un pasto veloce che però non disdegna la possibilità di trattenere anche il passante che va in cerca di una sosta più prolungata, facendolo accomodare in un contesto moderno con tavoli quadrati bianchi e sedie bianche a righe trasversali nere. Nel poco tempo che mi sono trattenuta qui, tra un morso piccante e un sorso per alleviare il bruciore, hanno sostato per di più donne e giovani coppie. E mentre il fuoco divampava nella mia bocca ho pensato che dopotutto quel Burritos per quanto piccante fosse, valeva proprio la pena mangiarlo!
Le vie Dublinesi la domenica brulicano di turisti di ogni nazionalità che non si arrendono al fatto che la maggior parte delle vetrine dei negozi siano chiuse. Dalla mattina alla sera la fiumana di gente imperterrita non cessa di percorrere la capitale in lungo e in largo e quando cala la notte quelli che la fanno da padrone sono i tantissimi giovani. Dublino è il colore cosmopolita per eccellenza, è la patria dei giovani, è la culla dell’incontro multietnico. Chiunque abbia dimestichezza con la lingua inglese qui è di casa ma se anche uno non parla nemmeno una parola della lingua ufficiale non troverà alcun problema nel comunicare con gli Irlandesi o con chi vive nella città e ne ha acquisito gli usi, perché qui il turista è sacro e in un modo o in un’altro la comunicazione infrange le barriere parlando la lingua universale del cuore a cuore, con gentilezza e disponibilità assoluta, al punto che ci si sente coccolati e si percepisce quasi la strana sensazione di essere come a casa. Questo è ciò che sa regalare una città come Dublino.
(by Silvia Montis) https://www.facebook.com/Saburritos
From Dublin, Ireland
© Photography by Silvia Montis


L’oggetto più antico esistente nella nostra casa, un vero cimelio storico, era un bauletto appartenuto al mio trisavolo materno. Per tutti noi era semplicemente il forziere, un nome che testimoniava l’alta considerazione in cui era tenuto per via della vita lunga e avventurosa dell’avo, della quale ciascuno di noi era a conoscenza, almeno a grandi linee, perché nel racconto di quella umana vicenda si era esaltata la fantasia di ogni giovane generazione della nostra famiglia. Non escludo che il racconto orale, nel lungo tempo trascorso, possa essersi arricchito di molti particolari o di episodi che abbiano aumentato l’attrattiva e lo smalto favoloso di quel vissuto. Dico questo soprattutto in considerazione di quanto fatto proprio da me con l’accrescere,ogni volta che ne raccontavo, l’aspetto avventuroso di quella vita, e con la colmatura delle lacune e degli strappi nella successione cronologica,ma suppongo che molti altri abbiano dato un contributo a trasformare i vari episodi in un vero romanzo di avventure. Durante l’adolescenza sono stato un affamato lettore di libri di quel genere ma non saprei dire se a ciò fossi indotto dal ricordo dell’avo o se viceversa fosse stata la mia passione per i libri di avventura a farmi mitizzare la sua figura. Conoscevo a fondo, per averli letti e riletti, romanzi come L’isola del tesoro, come Le avventure di Arthur Gordon Pym o Robinson Crusoe, come I pirati della Malesia o Billy Budd, gabbiere di parrocchetto.
 Mi piaceva soprattutto la marineria ed ero giunto al punto da studiarne propriamente ogni aspetto, come la nomenclatura completa di ogni tipo e classe di bastimento e delle varie parti che compongono una nave e i vari pezzi di costruzione, l’alberatura, l’attrezzatura – cavi, paranchi, bozzelli, ancore, vele… – e le manovre, e i nodi, le legature…, come pure i nomi degli uomini che nelle varie funzioni attendono al governo di un natante. La mia passione si alimentava specialmente con le storie ambientate nei mari del Sud, il cielo australe mi affascinava per l’aura di mistero che io vi annettevo. E certamente pensavo che le avventure possibili in quell’emisfero fossero di tutt’altra natura, non dico superiore ma affatto diversa,che quelle nei mari del Nord. Insomma in quelle della Croce del Sud, in quei caldi arcipelaghi, nel Mar della Cina, nei mari della Malesia e del Borneo era tutto un andirivieni di giunche di pirati e di traffici di dubbia legalità;nelle altre,quelle dei mari del Nord, c’era il lento procedere delle navi rompighiaccio, l’attiva vita dei pescatori di aringhe e di merluzzi ai Grandi Banchi di Terranova, l’epica caccia alla balena nei freddi mari della Corrente del Labrador: due mondi così distanti…
Mi piaceva soprattutto la marineria ed ero giunto al punto da studiarne propriamente ogni aspetto, come la nomenclatura completa di ogni tipo e classe di bastimento e delle varie parti che compongono una nave e i vari pezzi di costruzione, l’alberatura, l’attrezzatura – cavi, paranchi, bozzelli, ancore, vele… – e le manovre, e i nodi, le legature…, come pure i nomi degli uomini che nelle varie funzioni attendono al governo di un natante. La mia passione si alimentava specialmente con le storie ambientate nei mari del Sud, il cielo australe mi affascinava per l’aura di mistero che io vi annettevo. E certamente pensavo che le avventure possibili in quell’emisfero fossero di tutt’altra natura, non dico superiore ma affatto diversa,che quelle nei mari del Nord. Insomma in quelle della Croce del Sud, in quei caldi arcipelaghi, nel Mar della Cina, nei mari della Malesia e del Borneo era tutto un andirivieni di giunche di pirati e di traffici di dubbia legalità;nelle altre,quelle dei mari del Nord, c’era il lento procedere delle navi rompighiaccio, l’attiva vita dei pescatori di aringhe e di merluzzi ai Grandi Banchi di Terranova, l’epica caccia alla balena nei freddi mari della Corrente del Labrador: due mondi così distanti…
Tornando al mio avo, vi è da sapere che il racconto della sua vita non è stato intessuto soltanto oralmente dai suoi discendenti ma ha avuto inizio da un prezioso brogliaccio contenuto nel suo forziere giunto fino a noi. In quel bauletto, un pezzo veramente ben costruito, in legno di pero rinforzato e borchiato e ancora pressoché intatto, erano contenuti oggetti preziosi e in primo luogo un brogliaccio rilegato solidamente,con il taglio delle pagine tinto di rosso come una bibbia o un breviario da ecclesiastico:e questo sì, è il pezzo che maggiormente ci interessa ma non posso tacere del fascino che su di me esercitavano le altre reliquie (un piccolo cannocchiale di lucente ottone, due paia di guanti, un orologio da tasca, un paio di occhialoni con la mascherina, un kris malese, un cannello di penna di giada, una medaglia della British East India Company, vari libriccini di appunti delle dimensioni di un enchiridio, un calendario perpetuo e altri piccoli oggetti) la principale delle quali era un copialettere portatile ancora perfettamente funzionante. Proprio con quello strumento il mio avo aveva diligentemente ricopiato nel grande brogliaccio ogni atto scritto e ogni lettera – atti e lettere redatti in italiano, in francese e in inglese – da lui prodotti nel corso della sua lunga vita, essendo morto nonagenario, proco prima della grande guerra, nel suo buen retiro sorrentino.
 Nel brogliaccio del mio trisavolo erano annotati, quali brevemente e quali più estesamente, molti fatti e circostanze della sua vita, non esclusi certi rilievi psicologici personali e certe meditazioni, tutte scritture che fanno di quel libro un vero e proprio diario. Ho detto già degli spunti di riflessione ma non sottovaluto le altre minuzie e gli appunti frammentari rilevati dagli enchiridi: tutte notizie che compongono il vivido mosaico della sua esistenza. Si va dai fugaci amori, per la verità non infrequenti anche dopo il suo matrimonio, alla nascita dei figli, dagli acquisti di oggetti importanti all’annotazione dei bagni completi fatti per l’igiene personale e finanche talvolta alle osservazioni meteorologiche e climatiche.
Nel brogliaccio del mio trisavolo erano annotati, quali brevemente e quali più estesamente, molti fatti e circostanze della sua vita, non esclusi certi rilievi psicologici personali e certe meditazioni, tutte scritture che fanno di quel libro un vero e proprio diario. Ho detto già degli spunti di riflessione ma non sottovaluto le altre minuzie e gli appunti frammentari rilevati dagli enchiridi: tutte notizie che compongono il vivido mosaico della sua esistenza. Si va dai fugaci amori, per la verità non infrequenti anche dopo il suo matrimonio, alla nascita dei figli, dagli acquisti di oggetti importanti all’annotazione dei bagni completi fatti per l’igiene personale e finanche talvolta alle osservazioni meteorologiche e climatiche.
 Durante la mia adolescenza, nelle lunghe giornate delle vacanze estive, ho trascorso molto tempo a compulsare quel diario ed a farne un duplicato in un librone molto somigliante all’originale, riportando però tutti gli scritti in lingua italiana, avendo io stesso tradotto tutti i testi. Tra le lettere più importanti ve n’è una che contiene alcune informazioni generali sull’autore, di cui non ho ancora detto il nome perché lo dirà lui stesso nella lettera. Questo scritto è una sorta di curriculum da lui inviato all’antropologo dell’Inghilterra vittoriana Edward Burnett Tylor, l’autore del famoso libro Primitive Culture. Ho definito avventurosa la vita del mio trisavolo senza dire perché lo fosse: dalla lettera si capisce e per questo la trascriverò qui di seguito, ma intanto basti considerare il luogo di partenza di quella lettera, Makassar – una città che ai giorni nostri è la capitale della provincia indonesiana del Sulawesi Meridionale, che è una grande isola – e che già allora, alla metà del secolo diciannovesimo era un importante porto libero dell’isola di Celebes, nome con cui a quel tempo era conosciuta in tutto l’Occidente.
Durante la mia adolescenza, nelle lunghe giornate delle vacanze estive, ho trascorso molto tempo a compulsare quel diario ed a farne un duplicato in un librone molto somigliante all’originale, riportando però tutti gli scritti in lingua italiana, avendo io stesso tradotto tutti i testi. Tra le lettere più importanti ve n’è una che contiene alcune informazioni generali sull’autore, di cui non ho ancora detto il nome perché lo dirà lui stesso nella lettera. Questo scritto è una sorta di curriculum da lui inviato all’antropologo dell’Inghilterra vittoriana Edward Burnett Tylor, l’autore del famoso libro Primitive Culture. Ho definito avventurosa la vita del mio trisavolo senza dire perché lo fosse: dalla lettera si capisce e per questo la trascriverò qui di seguito, ma intanto basti considerare il luogo di partenza di quella lettera, Makassar – una città che ai giorni nostri è la capitale della provincia indonesiana del Sulawesi Meridionale, che è una grande isola – e che già allora, alla metà del secolo diciannovesimo era un importante porto libero dell’isola di Celebes, nome con cui a quel tempo era conosciuta in tutto l’Occidente.
Dopo queste poche premesse è ormai il momento di riportare l’intero testo della lettera nella versione da me tradotta.
Al Signor Professor
Edward Burnett Tylor
care of Reale Società di Biologia
LONDON
“Makassar, a dì 13 aprile 1848
“Illustre Signore,
mi presento a Lei a nome del Primo Nostromo della goletta Plymouth II, il Signor Bud Fitzpatrick: sono Pietro Agnello Giaccarino, un suddito di S.M. il Re delle Due Sicilie. Sono nato a Sorrento nell’anno 1823 e mi sono stabilito nell’isola di Celebes da circa quattro anni, dopo aver fatto la spola per tre anni, negli arcipelaghi delle Molucche e della Sonda, su un navilio di lungo corso, un brigantino mercantile a tre alberi. Conosco il mare dall’infanzia e navigo fin dalla giovine età dei sedici anni.
“Il mio officio consiste nell’approvvigionare di legnami pregiati, tek, ebano, sandalo e canfora, nonché di scorza di china una ditta genovese, di cui sono commissionario, la quale ne fa commercio in Italia e in Europa; legnami che in queste terre sono largamente diffusi.
Il Nostromo Fitzpatrick avrebbe in me ravvisato le qualità adatte a corrispondere con Lei, illustre Professore, con riferimento alla materia delle usanze e tradizioni tribali nonché dei riti di queste popolazioni, per il fine di fornire a Lei mezzi di studio e di comparazione, se ho ben compreso, per un Suo lavoro intorno alla cultura delle genti primitive.
 “Quantunque il mio umano sostentamento mi provenga dall’attività del tutto diversa di cui Le ho riferito e nonostante il forse troppo breve periodo di stanziamento in Makassar, mi professo adatto alla bisogna,g iacché il tipo di osservazioni che essa mi richiederebbe è consono al mio personale interesse. Le dico, a tal proposito, che io fui educato in Amalfi da un sant’uomo,un ecclesiastico barnabita, di nome Padre Bracciolino Calise, già stato missionario per lunghissimi anni in terre d’Affrica eppertanto profondamente versato nella scienza etnografica, di cui m’insegnò i rudimenti, quegli stessi che mi hanno accompagnato in Celebes e che m’hanno dato contezza di tanto argomento che altrimenti mi sarebbe restato estraneo.
“Quantunque il mio umano sostentamento mi provenga dall’attività del tutto diversa di cui Le ho riferito e nonostante il forse troppo breve periodo di stanziamento in Makassar, mi professo adatto alla bisogna,g iacché il tipo di osservazioni che essa mi richiederebbe è consono al mio personale interesse. Le dico, a tal proposito, che io fui educato in Amalfi da un sant’uomo,un ecclesiastico barnabita, di nome Padre Bracciolino Calise, già stato missionario per lunghissimi anni in terre d’Affrica eppertanto profondamente versato nella scienza etnografica, di cui m’insegnò i rudimenti, quegli stessi che mi hanno accompagnato in Celebes e che m’hanno dato contezza di tanto argomento che altrimenti mi sarebbe restato estraneo.
“Vorrei dunque darle un breve saggio delle informazioni che potrei trasferirle se Lei acconsentisse alla mia collaborazione, che sin d’ora Le assicuro gratuita. Per il momento mi applicherò a riferire le osservazioni già da me fatte, specialmente quelle intorno ai Toradja o Taraja, il popolo dell’altopiano. In seguito Le fornirò notizie più diffuse e più dettagliate,conforme al desiderio mio di servir al meglio Lei e la scienza.
 “Inizio dai riti connessi con la lunga siccità o con l’eccesso di pioggia e dunque dalle azioni volte a provocarla,nel primo caso, ed a farla cessare, nel secondo. Nelle zone a nord di Celebes nominate Minahassa, gli sciamani prendono lunghi bagni cerimoniali con l’intenzione di provocare il cielo alla pioggia. Nella zona centrale dell’isola, allorché per l’assenza prolungata dell’acqua le piantine di riso principiano a rinseccolirsi e prima che il raccolto vada perso del tutto, gli abitatori dei villaggi si portano ai fiumiciattoli,alle pozze d’acqua e se ne aspergono con grandi strilli, specialmente quelli dei giovani, e se ne spruzzano e schizzano. E imitano il rumore della pioggia battendo le mani sulla superficie liquida o tamburellano,con la stessa intenzione, su una zucca svuotata. Sotto questi cieli è altresì necessario, talvolta, scongiurare la pioggia, farla cessare quando è troppa e questa, si sa, è una necessità anche dei contadini delle nostre parti. Ed anzi posso aggiungere che tante pratiche consimili avvengano anche nelle terre dove nacqui. Per restare a Celebes, l’eccesso d’acqua può diventare disastroso, e questo accade quando i venti Alisei si sono sovraccaricati all’eccesso di umidità durante il loro percorso sugli oceani. Può allora piovere sull’isola per mesi e mesi e mandar tutto marcio. Prima che questo avvenga, il sacerdote o mago della pioggia inizia quello che è un combattimento serrato con l’acqua, cioè si astiene totalmente dal toccarla, non si lava mai,beve soltanto il vino di palma; se deve attraversare un ruscello cerca un punto in cui gli sia possibile farlo senza toccare l’acqua, appoggia i piedi sui massi petrosi che emergono. Durante questo tempo propiziatorio egli vive in una capannuccia appartata dal villaggio ed eretta nel campo di riso. Qui accende un focherello che deve essere continuamente alimentato e vi brucia legnetti che dovrebbero avere il potere di tenere lontana la pioggia. Se all’orizzonte si profilano banchi di nubi carichi di pioggia, il mago soffia in quella stessa direzione reggendo tra le mani foglie e scorze d’albero che, per gli stessi nomi che portano suggeriscono la leggerezza e dunque si presume abbiano il potere di allontanare le nubi rendendole leggere sotto il soffio dello sciamano. In questo caso come in tante altre occasioni, questi uomini fanno un teatrino basato sulla somiglianza, sull’imitazione, credendo così di indurre gli spiriti che sono nelle cose ad imitarli. Questo mi ha insegnato il mio maestro Padre Bracciolino Calise e questo ho sempre potuto osservare:ma queste sono cose che lei sa meglio di me,modi di cui Lei conosce il nome ed io no. Ad ogni modo posso dirle che questa imitazione, questa specie di recita teatrale tanto ingenua è largamente praticata da tutti,anche da chi sciamano non è e per una serie infinita di intenzioni. Per esempio, chi volesse catturare un cinghiale, un maiale selvatico o altro animale, dovrà esporre all’esterno della casa o capanna una parte dell’animale che vuole attirare:una zampa,un corno,un lembo di pelle scuoiata… Lo stesso fanno, s’intende in altri modi ma con la stessa idea di teatro e di somiglianza, per mantenere in vita una persona,per scacciare gli spiriti del male. Queste però sono cerimonie cruente e qualche volta crudeli,almeno per noi. I riti che vogliono espellere il male sono eseguiti con il sacrificio di animali,con scannamenti che a noi potrebbero sembrare raccapriccianti se non sapessimo che un tempo,e forse ancora oggi presso i gruppi tribali più selvaggi,i sacrifizi erano fatti con l’uccisione di persone.
“Inizio dai riti connessi con la lunga siccità o con l’eccesso di pioggia e dunque dalle azioni volte a provocarla,nel primo caso, ed a farla cessare, nel secondo. Nelle zone a nord di Celebes nominate Minahassa, gli sciamani prendono lunghi bagni cerimoniali con l’intenzione di provocare il cielo alla pioggia. Nella zona centrale dell’isola, allorché per l’assenza prolungata dell’acqua le piantine di riso principiano a rinseccolirsi e prima che il raccolto vada perso del tutto, gli abitatori dei villaggi si portano ai fiumiciattoli,alle pozze d’acqua e se ne aspergono con grandi strilli, specialmente quelli dei giovani, e se ne spruzzano e schizzano. E imitano il rumore della pioggia battendo le mani sulla superficie liquida o tamburellano,con la stessa intenzione, su una zucca svuotata. Sotto questi cieli è altresì necessario, talvolta, scongiurare la pioggia, farla cessare quando è troppa e questa, si sa, è una necessità anche dei contadini delle nostre parti. Ed anzi posso aggiungere che tante pratiche consimili avvengano anche nelle terre dove nacqui. Per restare a Celebes, l’eccesso d’acqua può diventare disastroso, e questo accade quando i venti Alisei si sono sovraccaricati all’eccesso di umidità durante il loro percorso sugli oceani. Può allora piovere sull’isola per mesi e mesi e mandar tutto marcio. Prima che questo avvenga, il sacerdote o mago della pioggia inizia quello che è un combattimento serrato con l’acqua, cioè si astiene totalmente dal toccarla, non si lava mai,beve soltanto il vino di palma; se deve attraversare un ruscello cerca un punto in cui gli sia possibile farlo senza toccare l’acqua, appoggia i piedi sui massi petrosi che emergono. Durante questo tempo propiziatorio egli vive in una capannuccia appartata dal villaggio ed eretta nel campo di riso. Qui accende un focherello che deve essere continuamente alimentato e vi brucia legnetti che dovrebbero avere il potere di tenere lontana la pioggia. Se all’orizzonte si profilano banchi di nubi carichi di pioggia, il mago soffia in quella stessa direzione reggendo tra le mani foglie e scorze d’albero che, per gli stessi nomi che portano suggeriscono la leggerezza e dunque si presume abbiano il potere di allontanare le nubi rendendole leggere sotto il soffio dello sciamano. In questo caso come in tante altre occasioni, questi uomini fanno un teatrino basato sulla somiglianza, sull’imitazione, credendo così di indurre gli spiriti che sono nelle cose ad imitarli. Questo mi ha insegnato il mio maestro Padre Bracciolino Calise e questo ho sempre potuto osservare:ma queste sono cose che lei sa meglio di me,modi di cui Lei conosce il nome ed io no. Ad ogni modo posso dirle che questa imitazione, questa specie di recita teatrale tanto ingenua è largamente praticata da tutti,anche da chi sciamano non è e per una serie infinita di intenzioni. Per esempio, chi volesse catturare un cinghiale, un maiale selvatico o altro animale, dovrà esporre all’esterno della casa o capanna una parte dell’animale che vuole attirare:una zampa,un corno,un lembo di pelle scuoiata… Lo stesso fanno, s’intende in altri modi ma con la stessa idea di teatro e di somiglianza, per mantenere in vita una persona,per scacciare gli spiriti del male. Queste però sono cerimonie cruente e qualche volta crudeli,almeno per noi. I riti che vogliono espellere il male sono eseguiti con il sacrificio di animali,con scannamenti che a noi potrebbero sembrare raccapriccianti se non sapessimo che un tempo,e forse ancora oggi presso i gruppi tribali più selvaggi,i sacrifizi erano fatti con l’uccisione di persone.
 “Modi estremamente cruenti accompagnano anche il più complesso rito della sepoltura,un evento che può occupare giorni e giorni, durante i quali il villaggio attraversa momenti di baraonda alternati allo svolgersi della comune vita, al commercio ed alle altre umane cure. Quello che conta è l’importanza che si dà al corpo del defunto che,con un lungo cerimoniale accompagnato da canti e suoni di cimbali e tamburi, viene posto,dopo essere stato portato in processione, su un grande catafalco tutto ornato. D’intorno c’è gente che mangia (e questo, se mi è permesso dire, mi rammenta quel che avviene presso di noi, nelle nostre terre, dove si usa preparare il cuonsolo, cioè la consolazione, che è un lauto pasto da offrirsi a cura dei vicini alla famiglia del defunto), gente che attende ai propri affari approfittando dell’occasione di quel grande concentramento di gente. In queste cerimonie, quello che maggiormente mi ha impressionato è il sacrificio del bufalo, anzi di uno o più bufali, che viene fatto davanti a tutti, sulla radura dove si svolge il rito funebre. Quegli animali mastodontici vengono legati per le zampe ad un palo conficcato saldamente nel terreno, tanto profondamente per poter reggere, senza svellersi, alla forza immane dell’animale. Quando è il momento, il sacerdote si avvicina cautamente al bestione, che forse per via delle legature subite è già infuriato e come presago del suo destino di morte, e servendosi di un lungo e affilatissimo pugnale lo trafigge alla gola. L’impressionante fiotto di sangue che ne spiccia fuori inonda il terreno circostante, cioè tutto il cerchio intorno al palo a cui è vincolato e nel quale l’animale impazzito riesce ancora a muoversi scalciando in maniera furibonda. Durante questa penosa agonia la bestia riceve altre trafitture con le stesse modalità finché, totalmente dissanguato, crolla al suolo privo di vita se non per qualche fremito o spasmo residuo del suo corpo. Considerato che questo sacrifizio può ripetersi con altri animali durante la stessa cerimonia, alla fine il terreno è intriso totalmente di sangue.
“Modi estremamente cruenti accompagnano anche il più complesso rito della sepoltura,un evento che può occupare giorni e giorni, durante i quali il villaggio attraversa momenti di baraonda alternati allo svolgersi della comune vita, al commercio ed alle altre umane cure. Quello che conta è l’importanza che si dà al corpo del defunto che,con un lungo cerimoniale accompagnato da canti e suoni di cimbali e tamburi, viene posto,dopo essere stato portato in processione, su un grande catafalco tutto ornato. D’intorno c’è gente che mangia (e questo, se mi è permesso dire, mi rammenta quel che avviene presso di noi, nelle nostre terre, dove si usa preparare il cuonsolo, cioè la consolazione, che è un lauto pasto da offrirsi a cura dei vicini alla famiglia del defunto), gente che attende ai propri affari approfittando dell’occasione di quel grande concentramento di gente. In queste cerimonie, quello che maggiormente mi ha impressionato è il sacrificio del bufalo, anzi di uno o più bufali, che viene fatto davanti a tutti, sulla radura dove si svolge il rito funebre. Quegli animali mastodontici vengono legati per le zampe ad un palo conficcato saldamente nel terreno, tanto profondamente per poter reggere, senza svellersi, alla forza immane dell’animale. Quando è il momento, il sacerdote si avvicina cautamente al bestione, che forse per via delle legature subite è già infuriato e come presago del suo destino di morte, e servendosi di un lungo e affilatissimo pugnale lo trafigge alla gola. L’impressionante fiotto di sangue che ne spiccia fuori inonda il terreno circostante, cioè tutto il cerchio intorno al palo a cui è vincolato e nel quale l’animale impazzito riesce ancora a muoversi scalciando in maniera furibonda. Durante questa penosa agonia la bestia riceve altre trafitture con le stesse modalità finché, totalmente dissanguato, crolla al suolo privo di vita se non per qualche fremito o spasmo residuo del suo corpo. Considerato che questo sacrifizio può ripetersi con altri animali durante la stessa cerimonia, alla fine il terreno è intriso totalmente di sangue.
Egregio Signor Professore, queste poche considerazioni valgano soltanto a illustrare la possibilità di giovarsi dei miei rapporti, che saranno tanto più accurati se Ella vorrà indicarmi uno schema da seguire, una traccia a cui attenermi. In attesa di un Suo scritto di risposta, Le mando i miei migliori saluti da Makassar. Sono il Suo servitore e mi firmo Pietro Agnello Giaccarino.”


Questa mostra sembra essere stata fatta apposta per noi di Viaggio Fotografico! Nel nome, nei contenuti e per lo stile… Invece NON ci assumiamo la paternità di questa bellissima esposizione e ne parliamo con la voce di chi l’ha visitata e apprezzata.
Prendiamo uno dei più begli spazi espositivi del mondo, immaginiamo che questo spazio “espone” qualcosa da più di 2000 anni, prima era un mercato ed esponeva merci, ora è una prestigiosissima galleria d’arte che espone opere. Immagina, se non ci sei mai stato, che questo spazio enorme si affaccia con ampie vedute e terrazzi sui Fori Imperiali, pensa che tra un’opera e l’altra puoi camminare tra le rovine di epoca romana e avere una vista mozzafiato sulla storia, cerca di immaginare infine cosa significa vedere una mostra di arte moderna in uno spazio così antico… Ecco… hai fatto già due viaggi: uno nel tempo e uno con la fantasia. In questo contesto unico al mondo, il terzo viaggio te lo fa fare The Trip Magazine con la sua mostra Travel Routes in Photography.
Vedere una mostra in un contesto del genere è già di per sè un’esperienza straordinaria, aggiungici poi quattro bellissimi progetti fotografici e hai un mix incredibile di emozioni che ti verranno dal visitarla. Simon Norfolk, Elaine Ling, Giancarlo Ceraudo e Cristina De Middel sono i quattro Autori che ci raccontano il loro modo di viaggiare e di vedere il mondo. Lo fanno con il tipico stile della rivista The Trip, un free magazine bellissimo, curatissimo, dalla grafica raffinata di impaginazione diffuso a livello internazionale che viene diffuso anche grazie ad happening strategici come questa mostra, o le serate fatte al Chiostro del Bramante e al MACRO di Roma…
Il primo dei quattro Progetti, di Elaine Ling, ci propone all’ingresso della mostra delle gigantografie sospese con dei bellissimi baobab (giganti anche loro) scattati in grande formato su Polaroid Bianco e Nero a sviluppo istantaneo.
Il secondo lavoro a cura di Giancarlo Ceraudo ci parla di Cuba e di un modo onirico di raccontarla, anche questa in bianco e nero, l’isola caraibica perde i suoi famosi colori per essere vista con un dinamismo particolare dato da inquadrature suggestive, dal mosso e dal probabile uso del lensbabyes per ottenere effetti molto particolari di sfocatura zonale.
Passiamo poi a Cristina De Middel che al primo piano ci propone un ironico, geniale e improbabile viaggio spaziale rievocando una divertente conquista dello spazio da parte dello Zambia, una sorta di Armata Brancaleone alle prese con un’impresa più grande di lei.
Per finire espone Simon Norfolk che riprende delel vecchie fotografie dell’800 fatte dal primo fotoreporter che sia andato a documentare la guerra in Afghanistan e le ripropone oggi documentando come sia cambiato tutto, tranne, purtroppo la guerra che continua a martoriare questo paese.
Abbiamo visitato la mostra con gli Allievi della mia Photo Academy e camminare tra le opere esposte in mezzo ad antichi resti è un viaggio nel viaggio, vorrei suggerire a Te che sei arrivato a leggere fin qui di non perderti questa straordinaria esperienza visiva.

Il Palazzo delle Esposizioni di Roma ha fatto l’ennesimo grande omaggio alla Fotografia contemporanea, ormai la prestigiosa galleria in via Nazionale ci propone solo emozioni fotografiche di altissimo livello.
Sono andato ieri con i miei Allievi della Photo Academy in visita alla mostra di Helmut Newton, senza dubbio un nome che ha fatto la storia della fotografia anche quando era ancora vivo. Famosissimo e amatissimo da tutti Helmut Newton è sempre stato un personaggio di grande spicco, un divo a tutti gli effetti, parte integrante dello star system che ha sempre raccontato e descritto nelle sue immagini. Newton insomma non è mai stato un osservatore di un certo mondo, non un narratore reporter affascinato dai suoi soggetti, lui raccontava il suo mondo vivendoci dall’interno come suo stile di vita e mostrandoli all’esterno con le sue fotografie come icone di un mondo altrimenti inaccessibile ai più.
Le sue immagini ci raccontano di ville con piscina a Montecarlo, di attici a Manhattan o ai piedi delle Torre Eiffel, lui scattava per lo più in casa di amici o in quelle delle persone che ritraeva o nelle sue case che aveva sparse per il mondo. Le sue location preferite erano le grandi città come Parigi o Berlino, o le ville monumentali del lago di Como… Visioni di vita quotidiana, la sua. Concessioni fatte all’umanità di poter dare uno sguardo ad un mondo abitato da donne bellissime, discinte e disponibili, che vivono in case da film. Quelle di Newton sono delle visioni voyeuristiche di una società occidentale ricca e opulenta, arrogante e trasgressiva. Le donne di Newton sono annoiate, prepotenti, capricciose e fisicamente perfette, sono le donne che tutti gli uomini vorrebbero avere ma nessuno vorrebbe sposare, ma sono donne spesso tristi, insoddisfatte, la loro disponibilità è solo fisica, non morale.
Queste donne si baciano tra loro per noia, perchè vivono da sole in case senza uomini troppo affaccendati a fare altro. Le rare volte che gli uomini appaiono al cospetto di queste donne languide hanno sempre un ruolo subalterno, sottomesso, servile. Ecco quindi uomini baciare manichini o stare con lo sguardo basso, preso da altri pensieri mentre ci sono due donne davanti a lui riflesse nello specchio che amoreggiano tra loro completamente nude. Le donne di Newton arrivano ad interpretare il ruolo dell’altro sesso fino al punto di indossare abiti maschili e a tagliarsi i capelli in un continuo gioco fatto di ruoli e di identità. Gli uomini nel migliore dei casi stanno a guardare o sono schiavi della bellezza femminile.
Le modelle che il grande maestro tedesco sceglie per le sue visioni fotografiche giocano alla cavallina con tanto di frustino tra i denti all’interno di lussuosissime residenze, vestono con vertiginosi tacchi a spillo e ostentano la loro superba bellezza facendone un uso di fortissimo erotismo, mai volgare, mai pornografico. Per primo Newton ha portato il nudo nella fotografia di moda, pubblicizzando gli abiti e gli atelier internazionali con modelle in nudo integrale.
Vedendo la mostra di Roma, con oltre 200 foto tratte da 3 libri che sono stati diffusi in tutto il mondo, si ripercorre la storia della poetica visiva di questo grande artista. L’osservatore poco attento viene immancabilmente rapito dalla bellezza plastica delle modelle che qui vengono usate nel vero e proprio senso letterale del termine per interpretare il loro quotidiano, per quanto questo sia distante dal vissuto comune. Ad uno sguardo più approfondito ci si rende conto di come queste foto abbiano dettato 40 anni fa gli stili della fotografia moderna e contemporanea, di come le sue inquadrature, i suoi tagli e lo stile cromatico che otteneva in camera oscura siano oggi del tutto attuali e gli stessi che cerchiamo di ottenere con gli effetti di Photoshop.

Altra cosa che sconcerta chiunque visiti la mostra di Newton al Palazzo delle Esposizioni di Roma è la vastità e la quantità delle opere esposte oltre che il loro allestimento. La sezione dei Big Nudes è quella che mi ha di più affascinato, qui le donne appaiono nelle gigantografie stampate a dimensione naturale in una sorta di ricostruzione “in copia dell’originale”. Le ragazze diventano cloni di sè stesse in scala 1:1 e la loro giovane bellezza viene consegnata all’immortalità della fotografia mediante la conservazione eterna del negativo fotografico.

Consultare il sito del Palazzo delle Esposizioni di Roma: http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/mostra-helmut-newton Apertura al pubblico fino al 21 luglio 2013.

